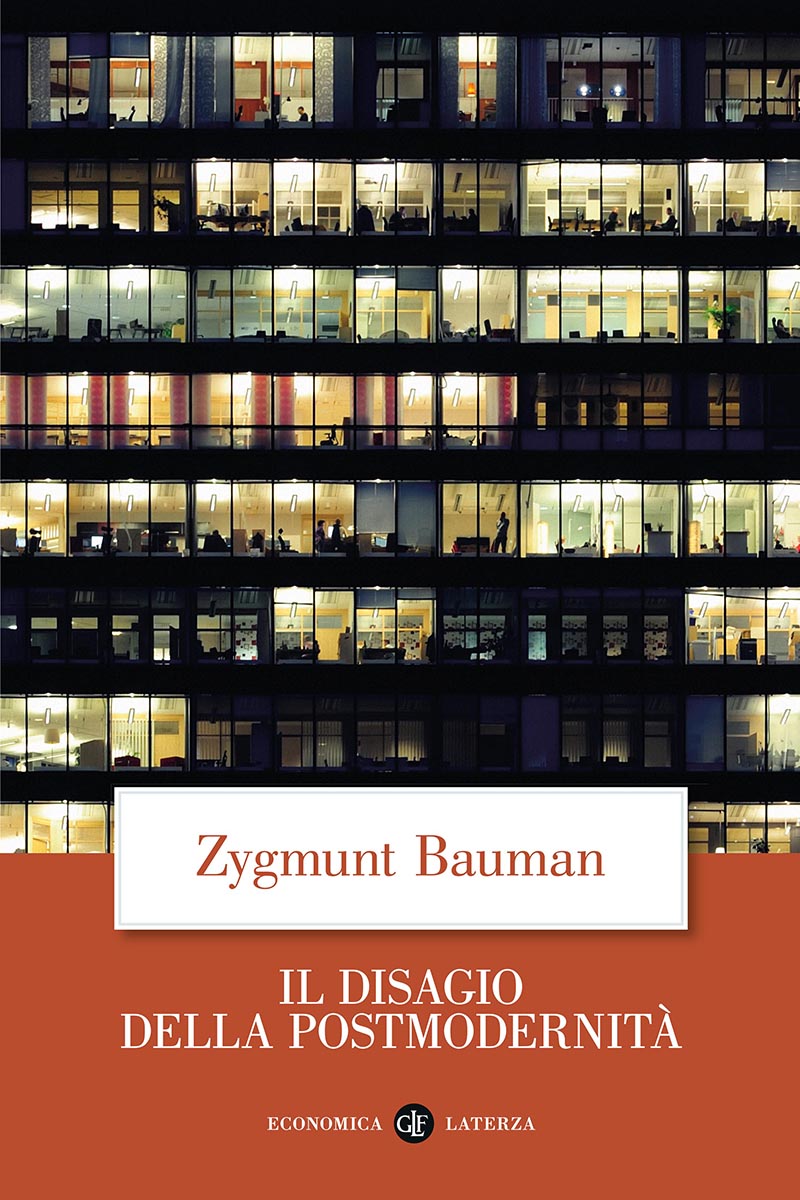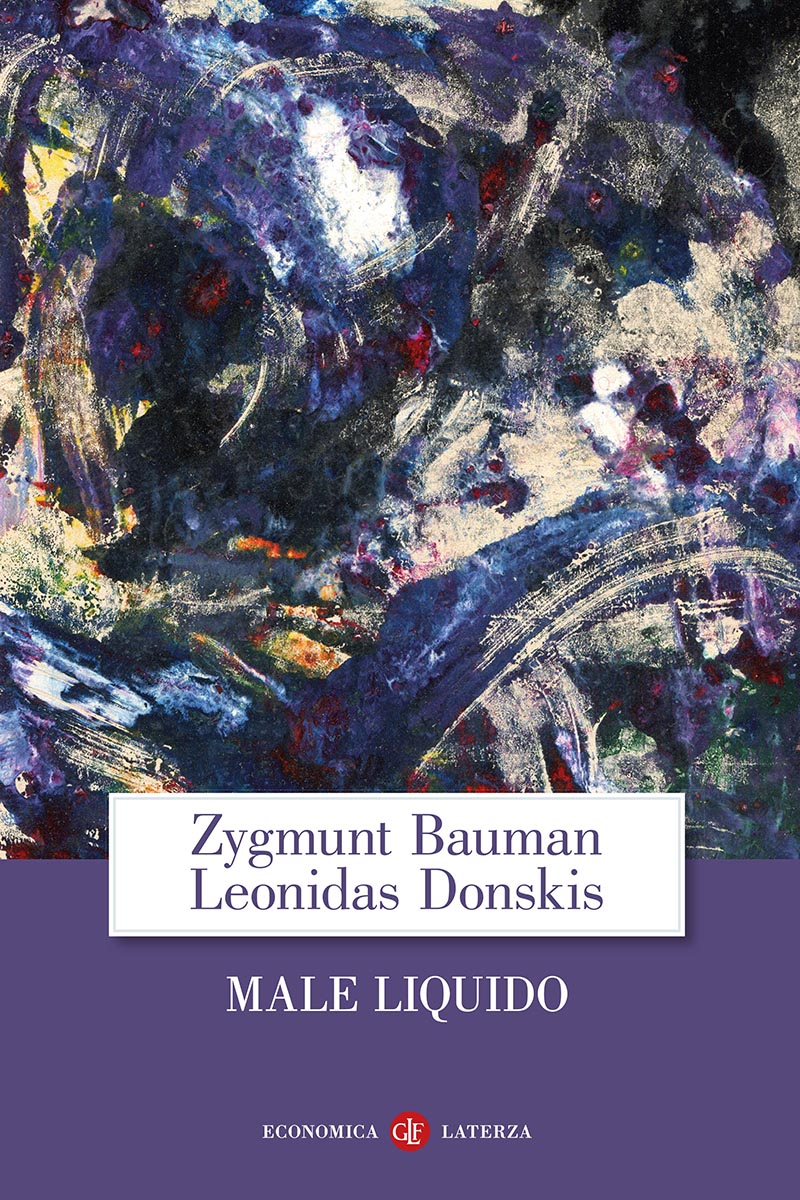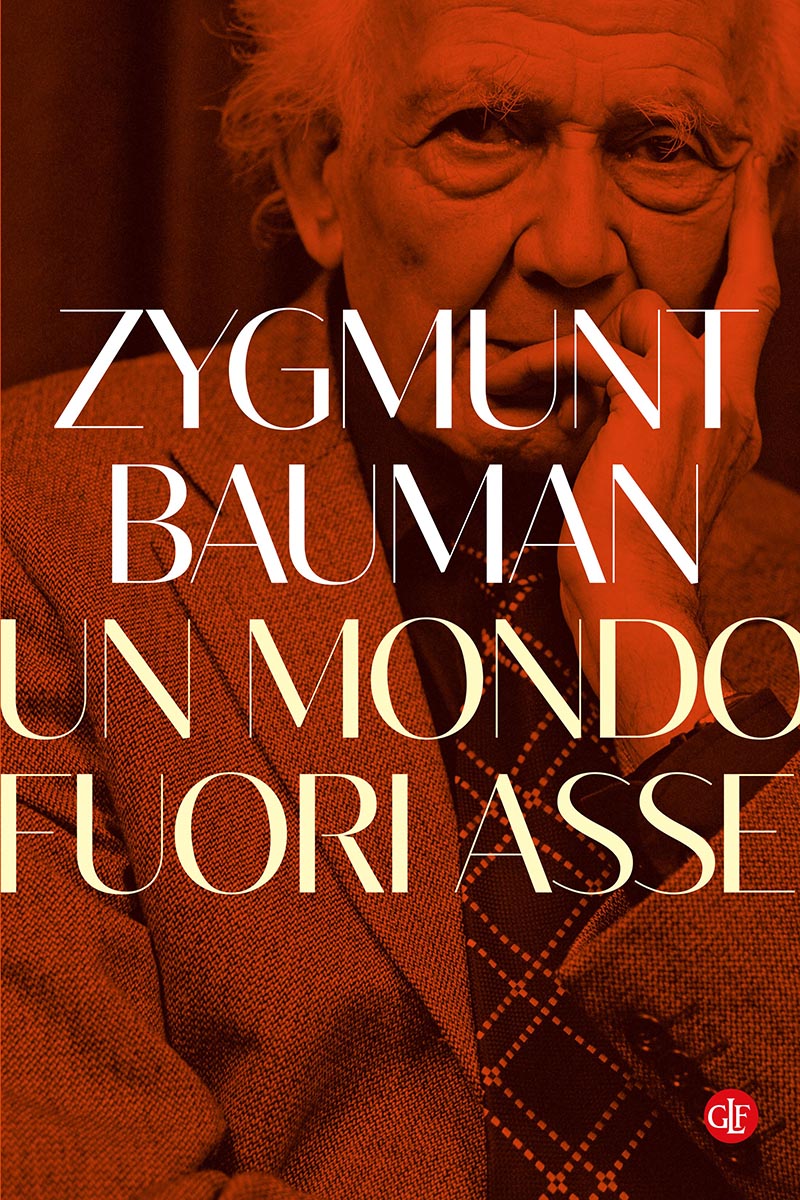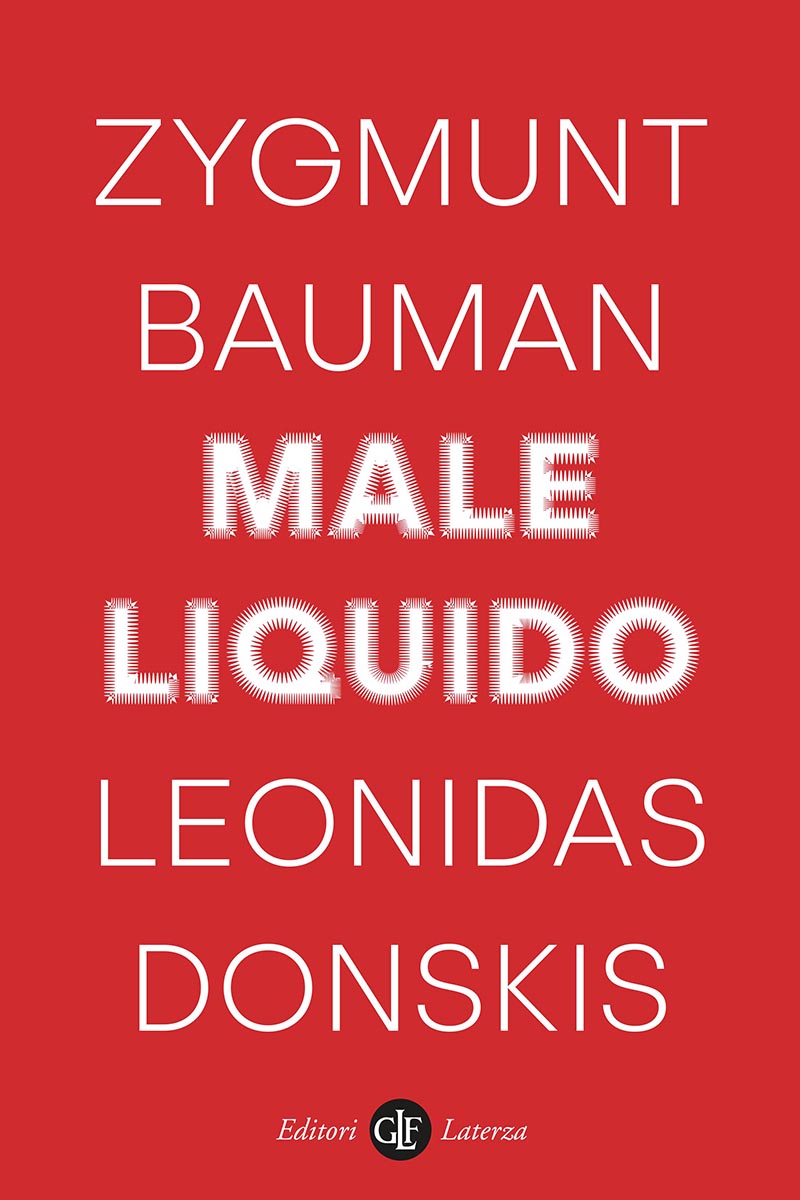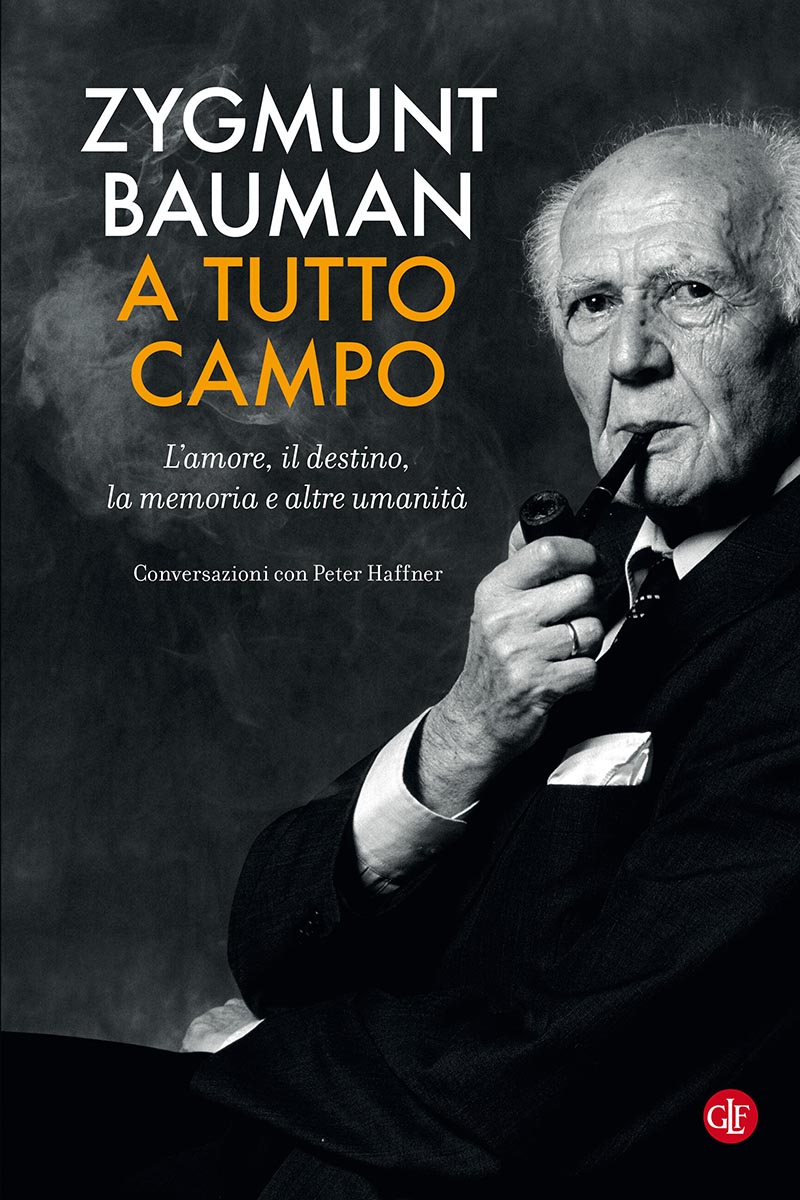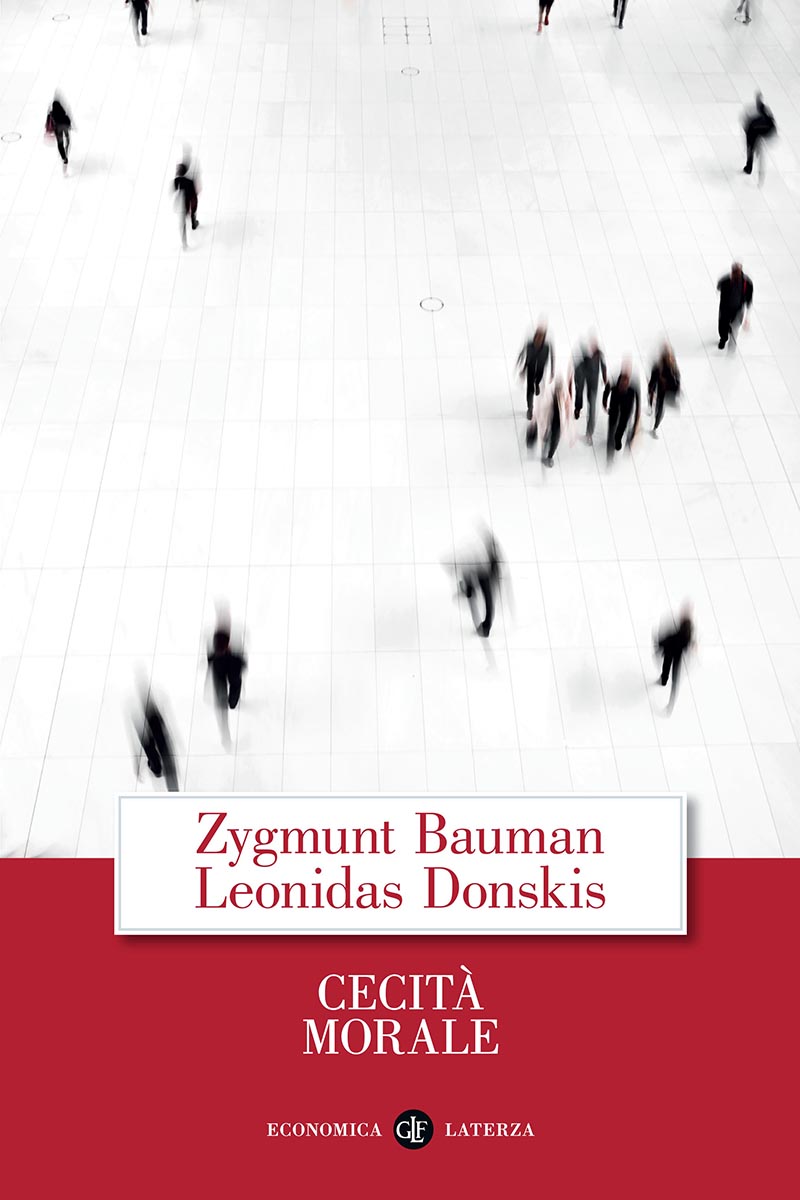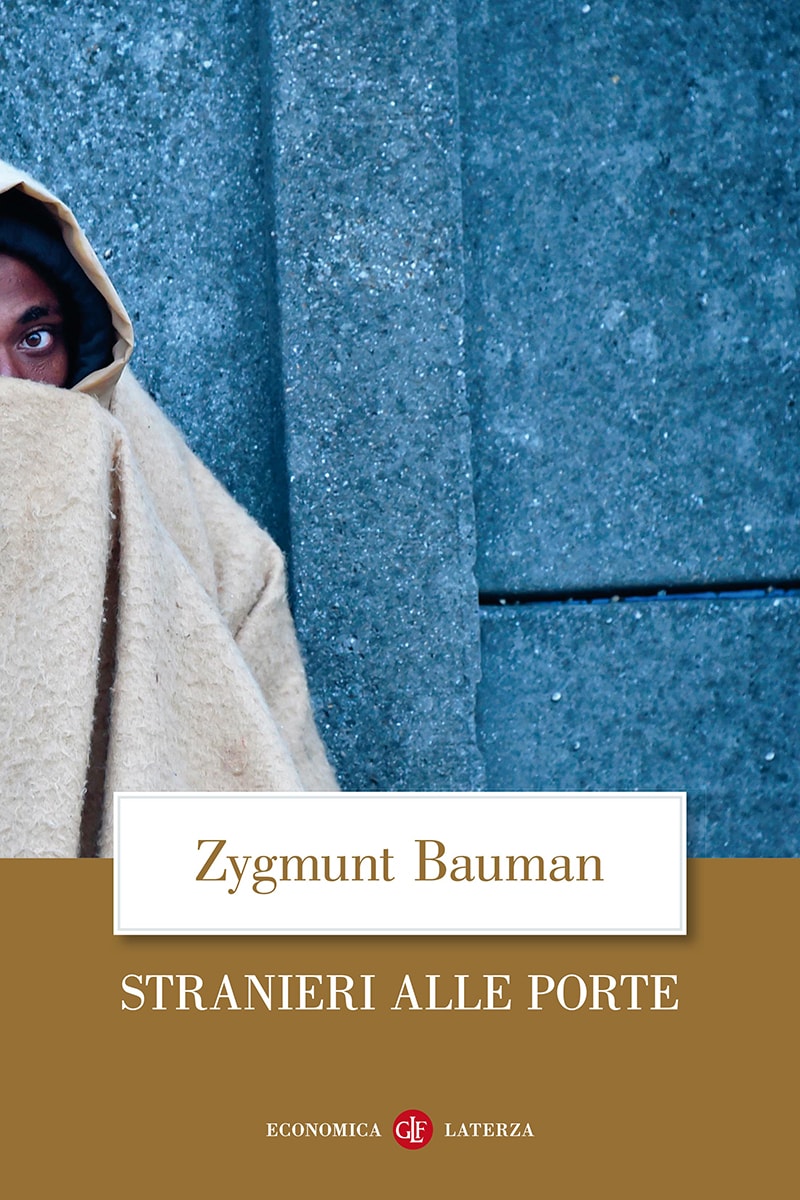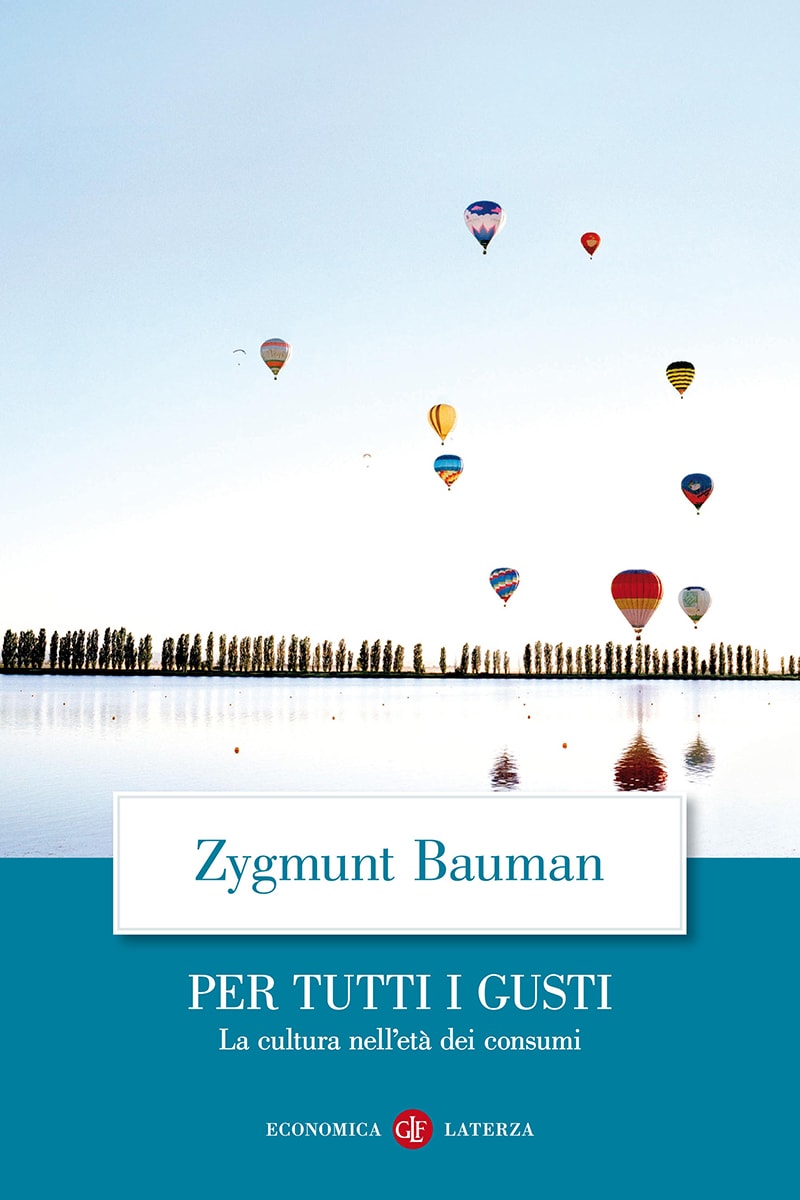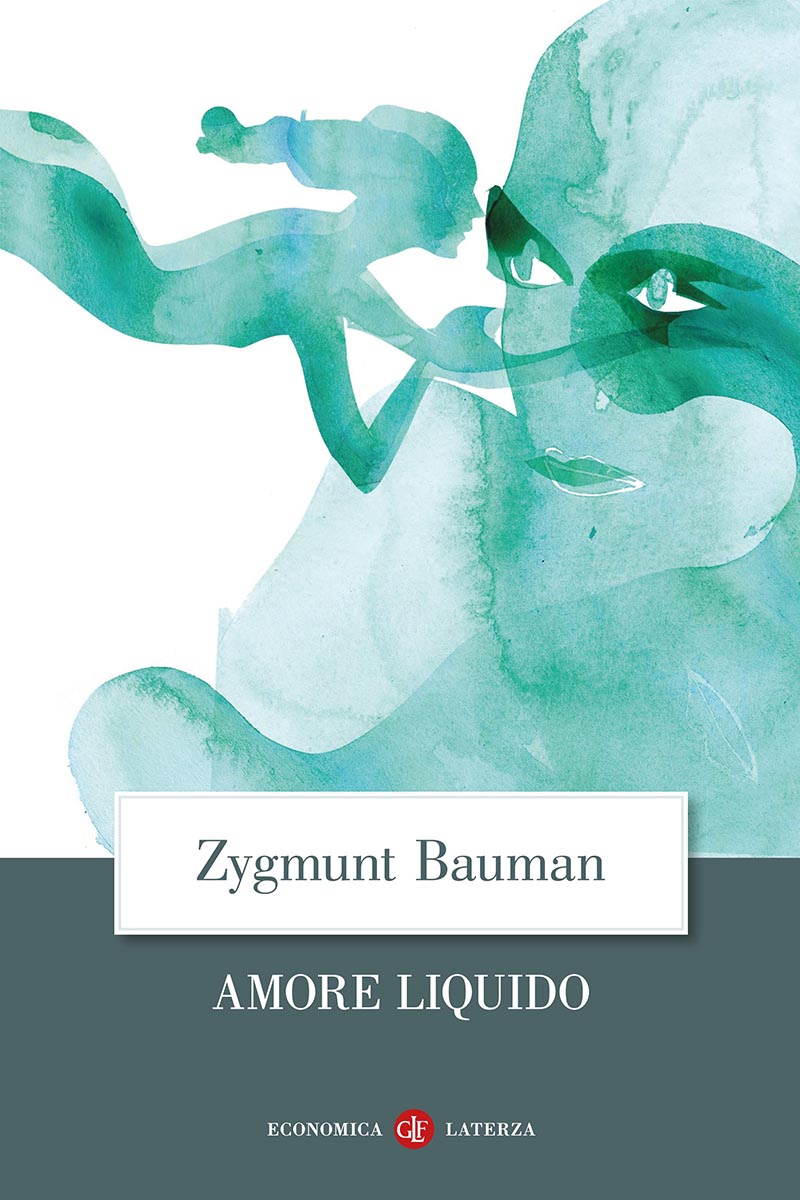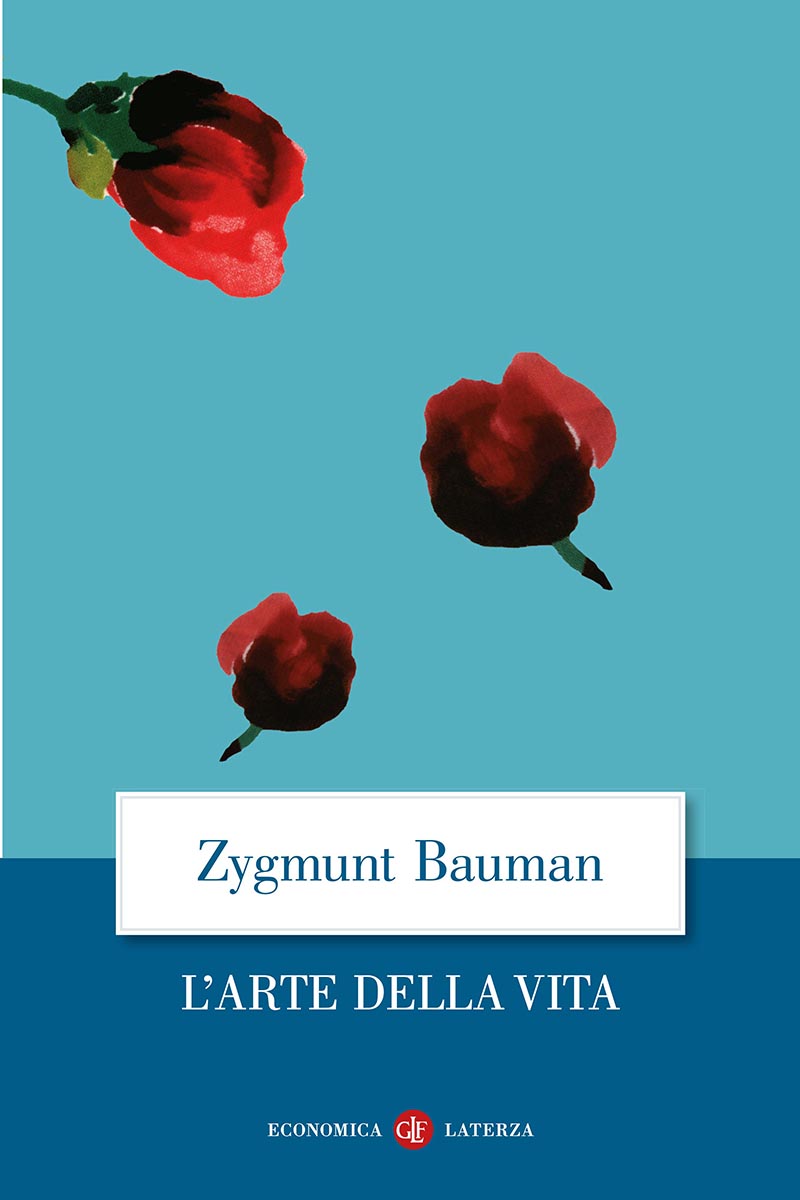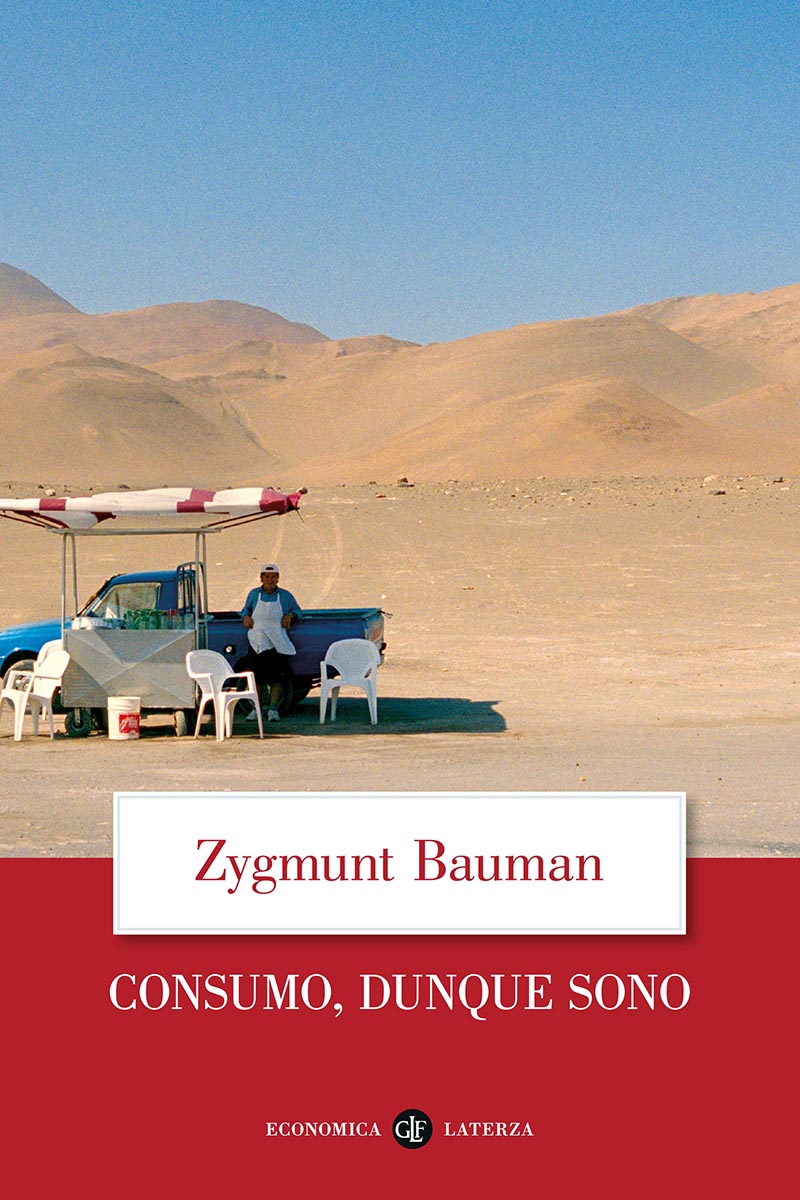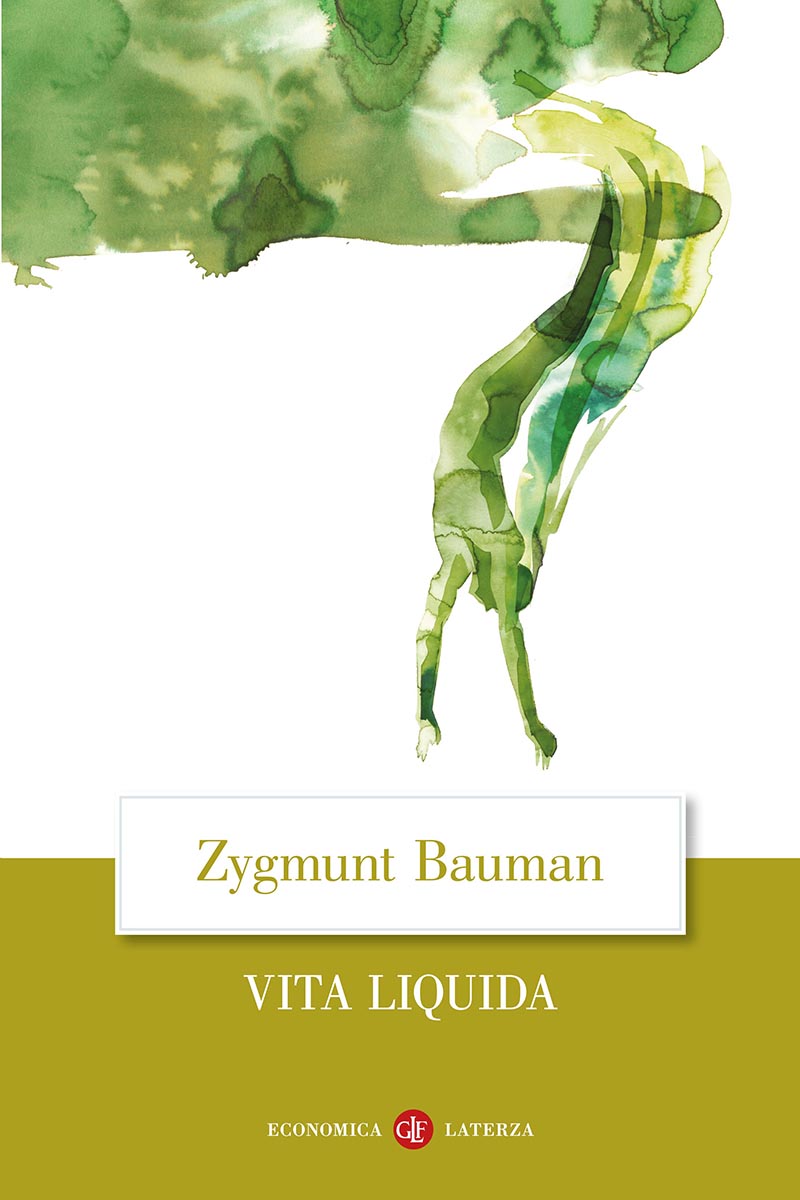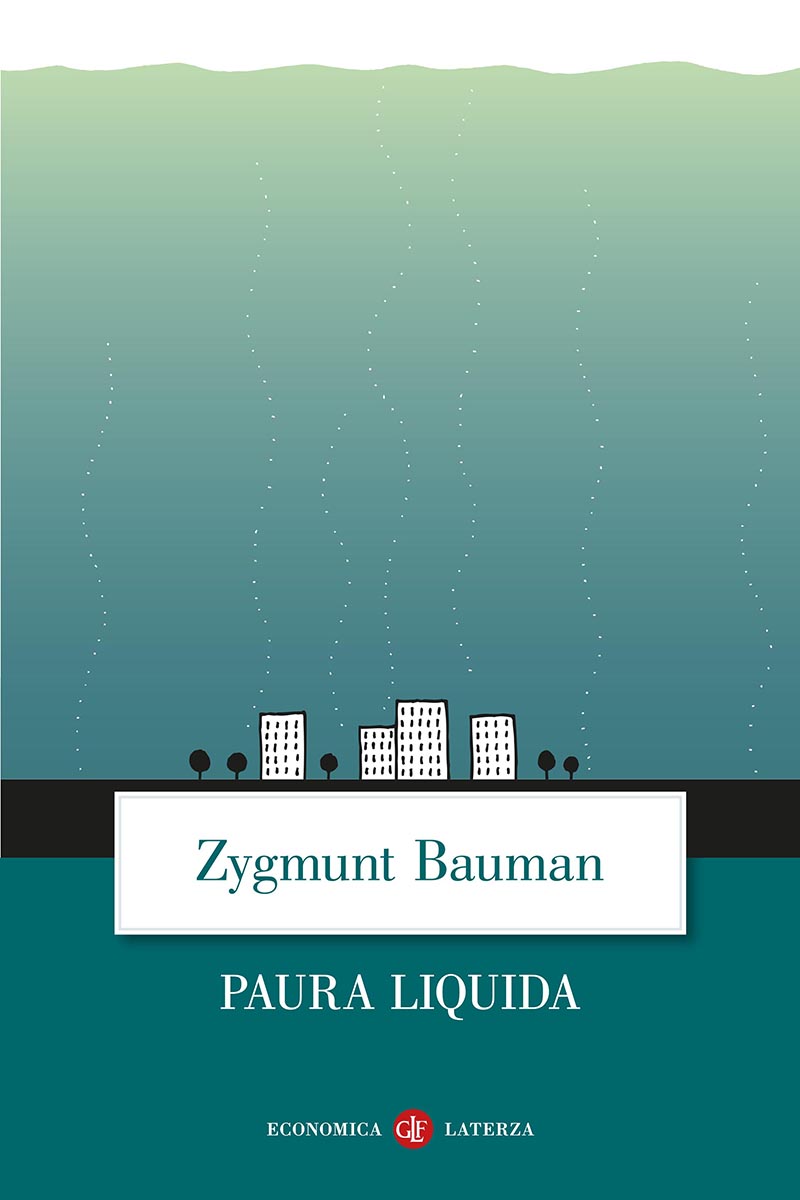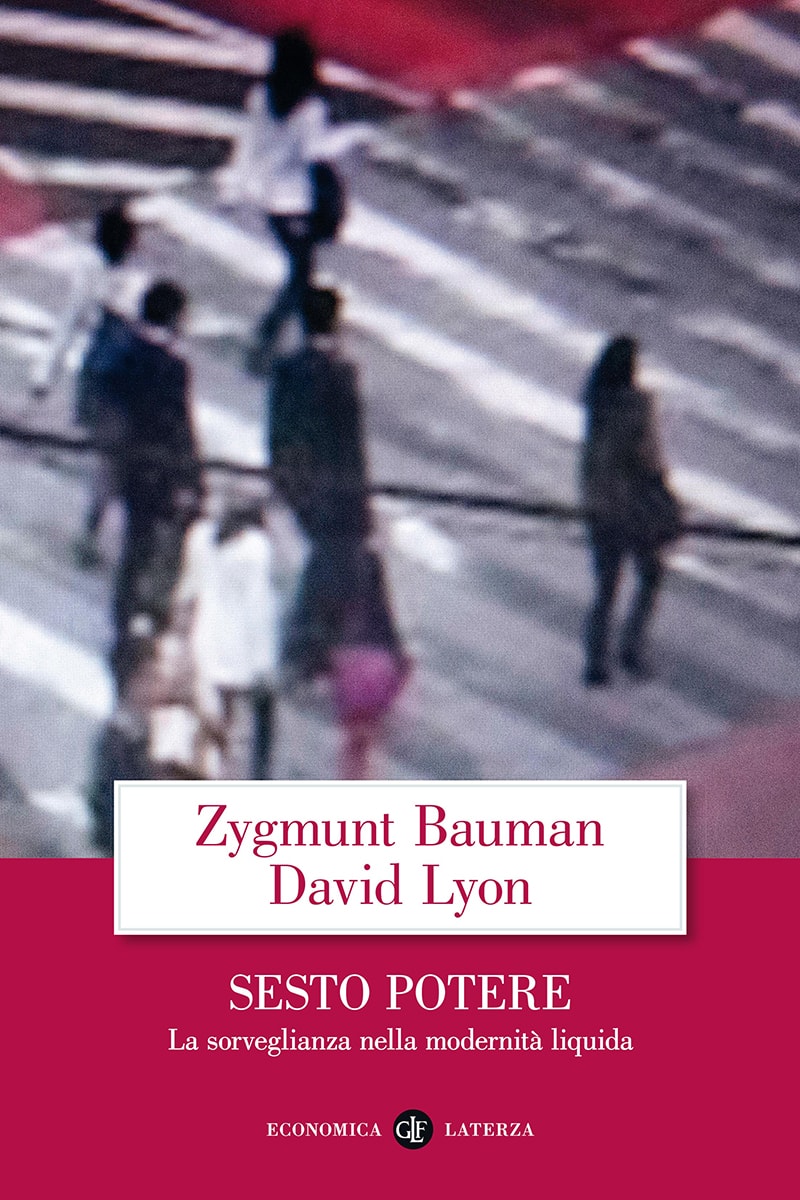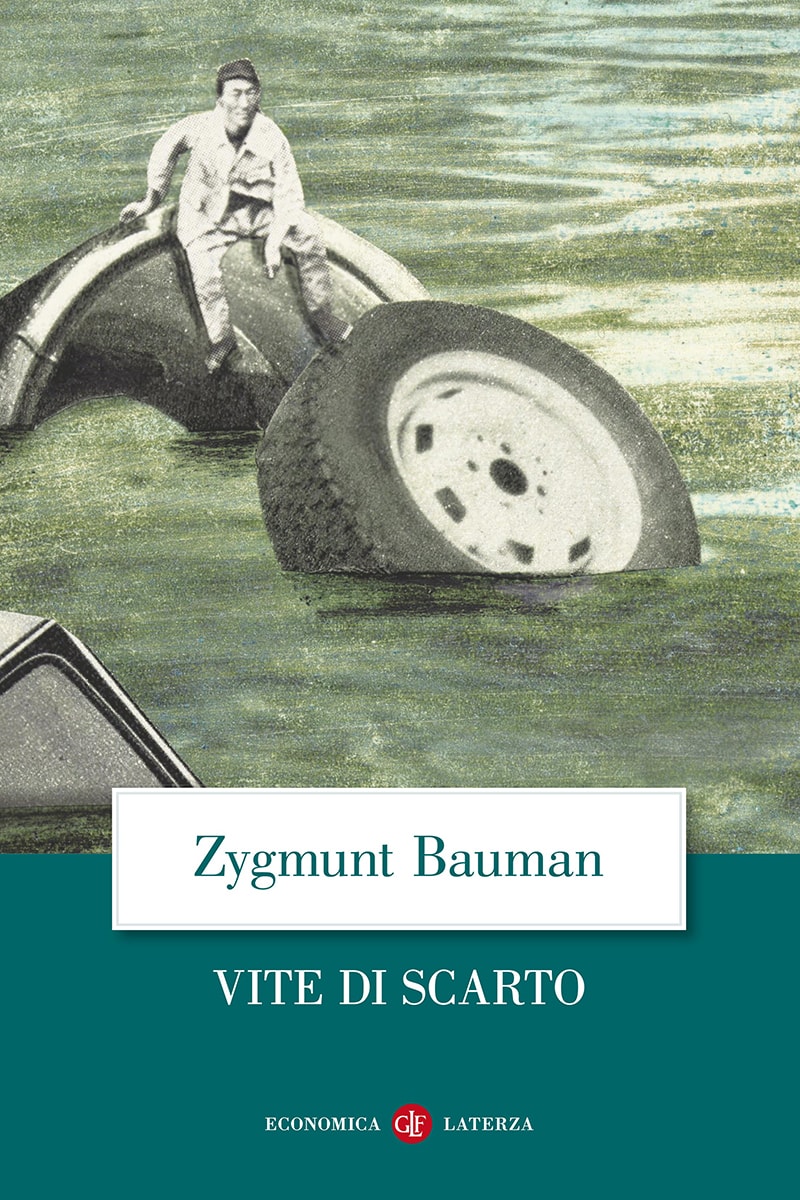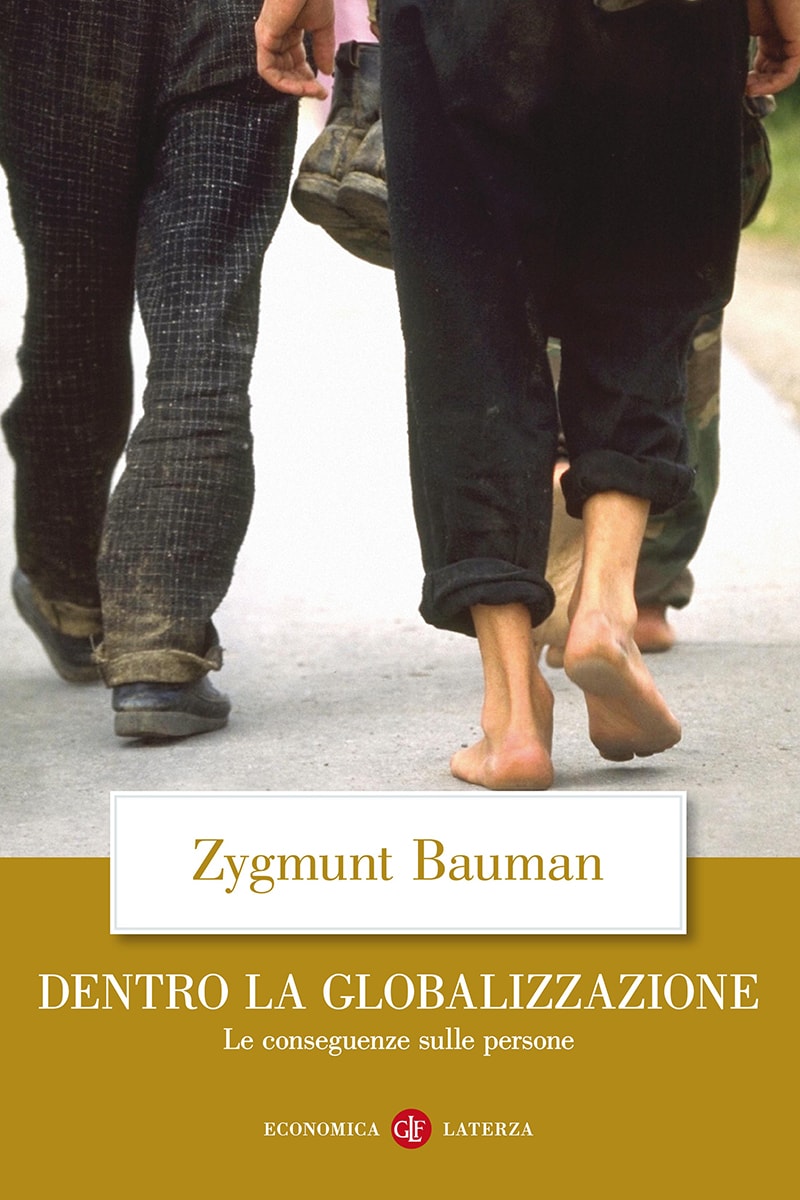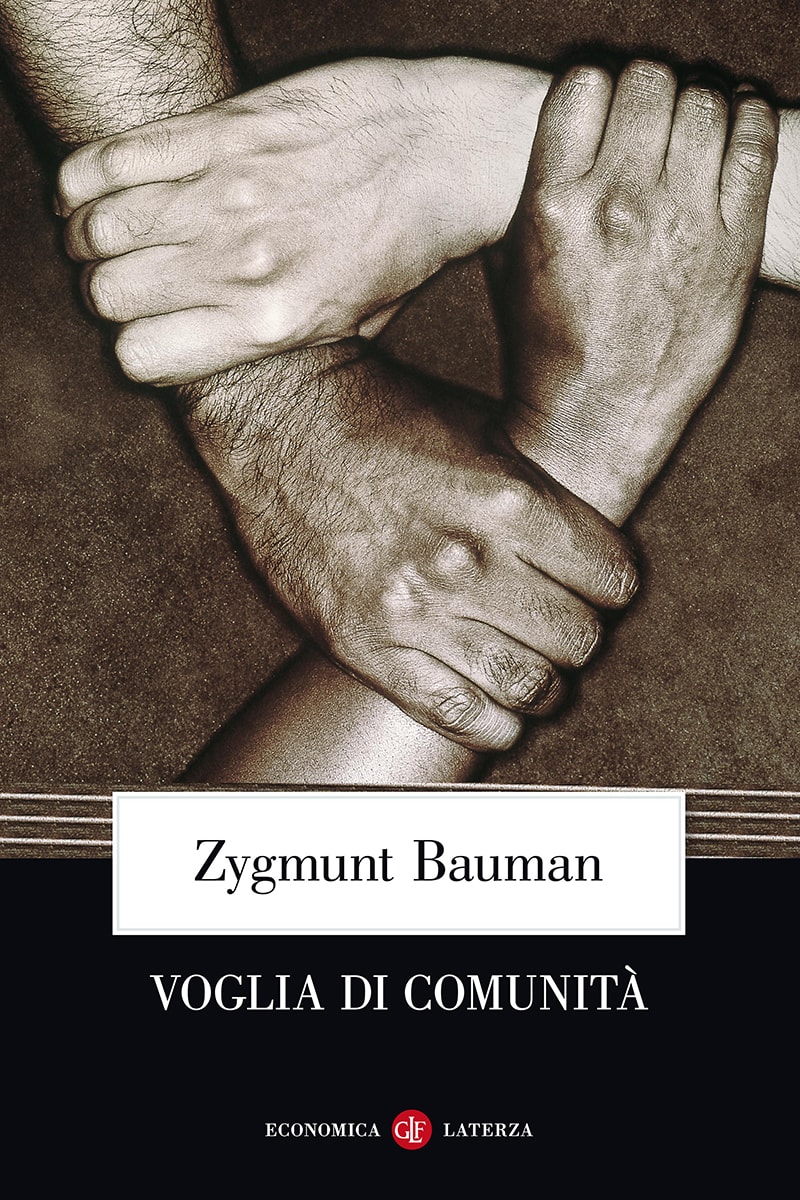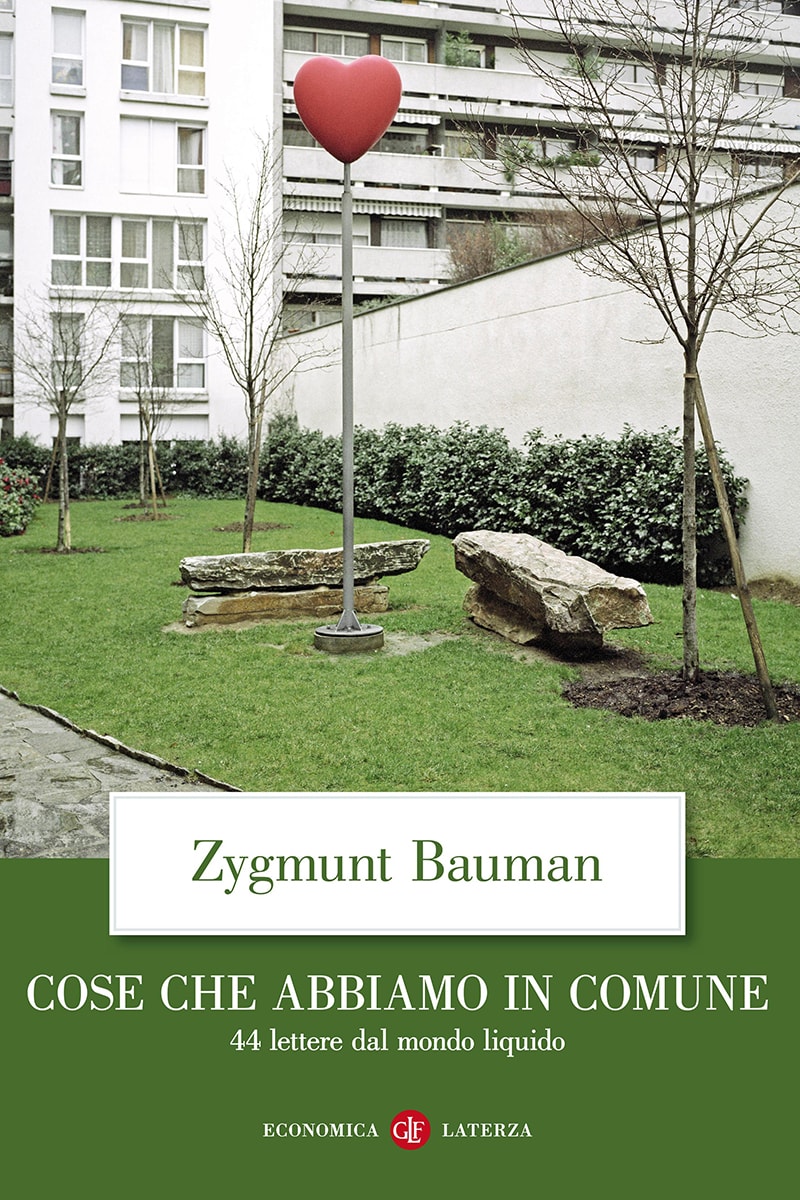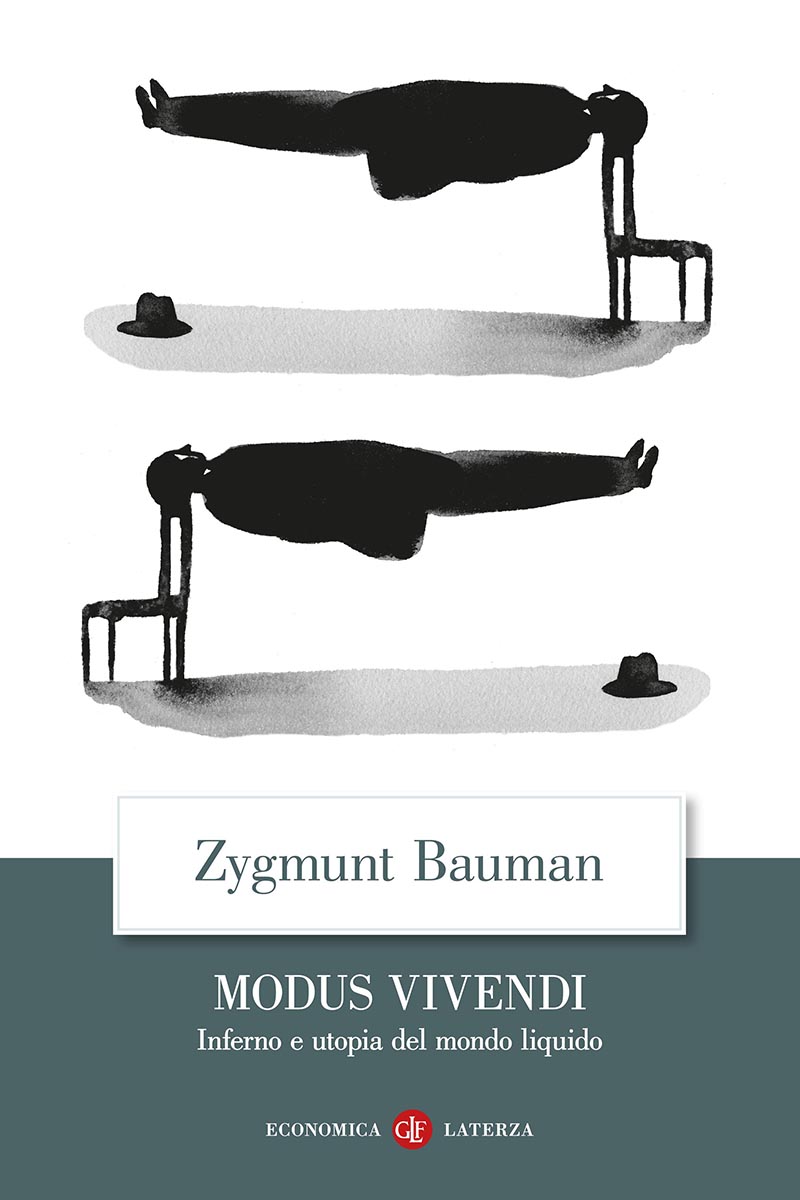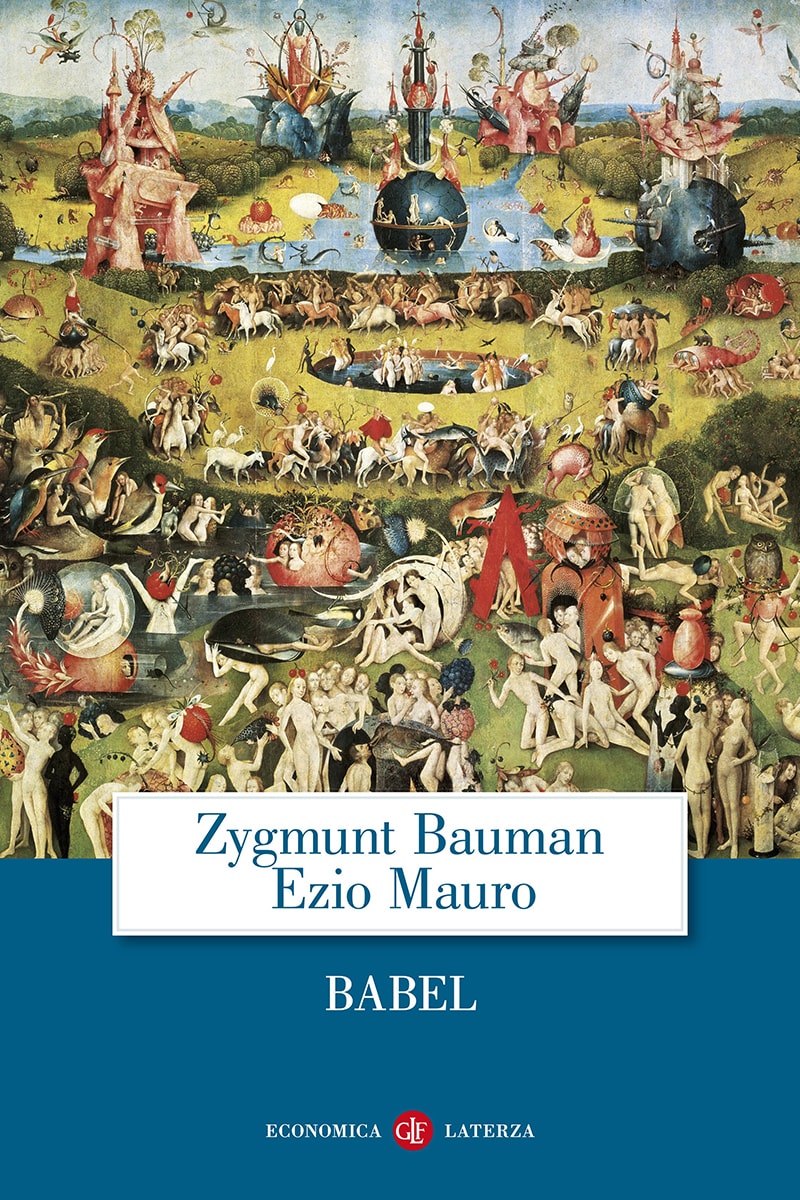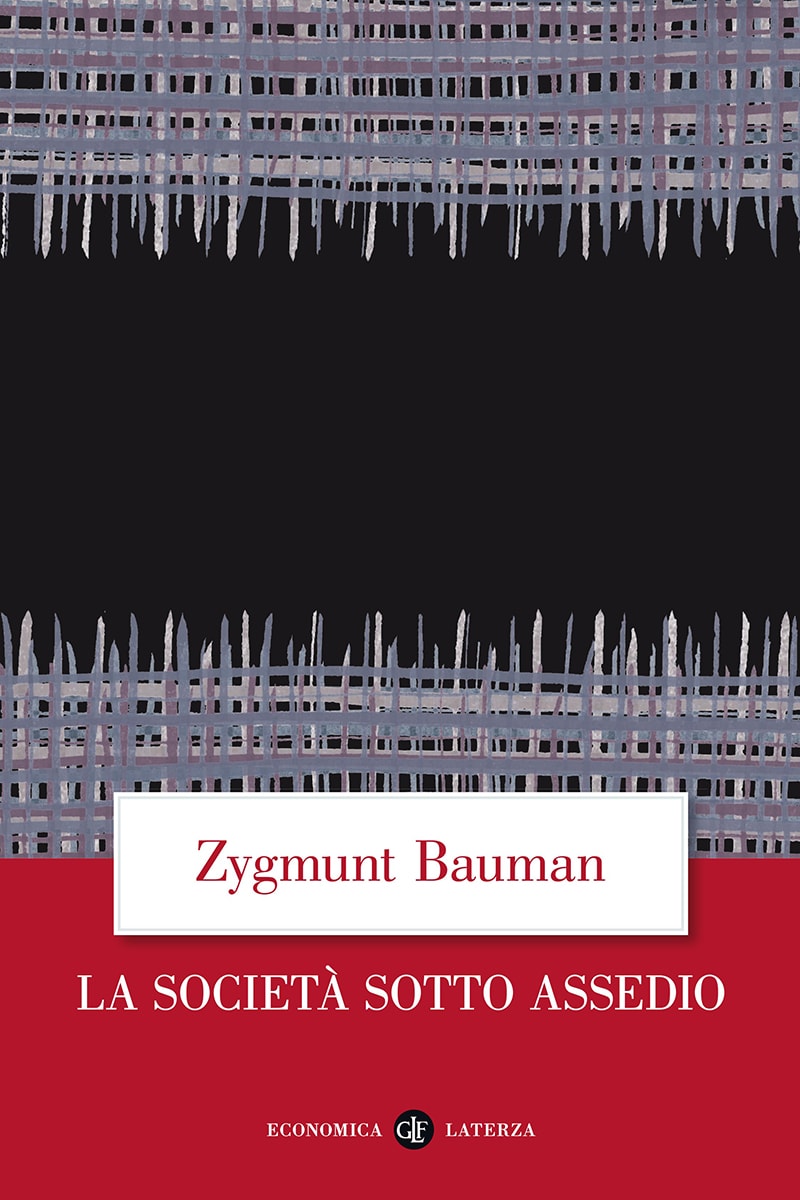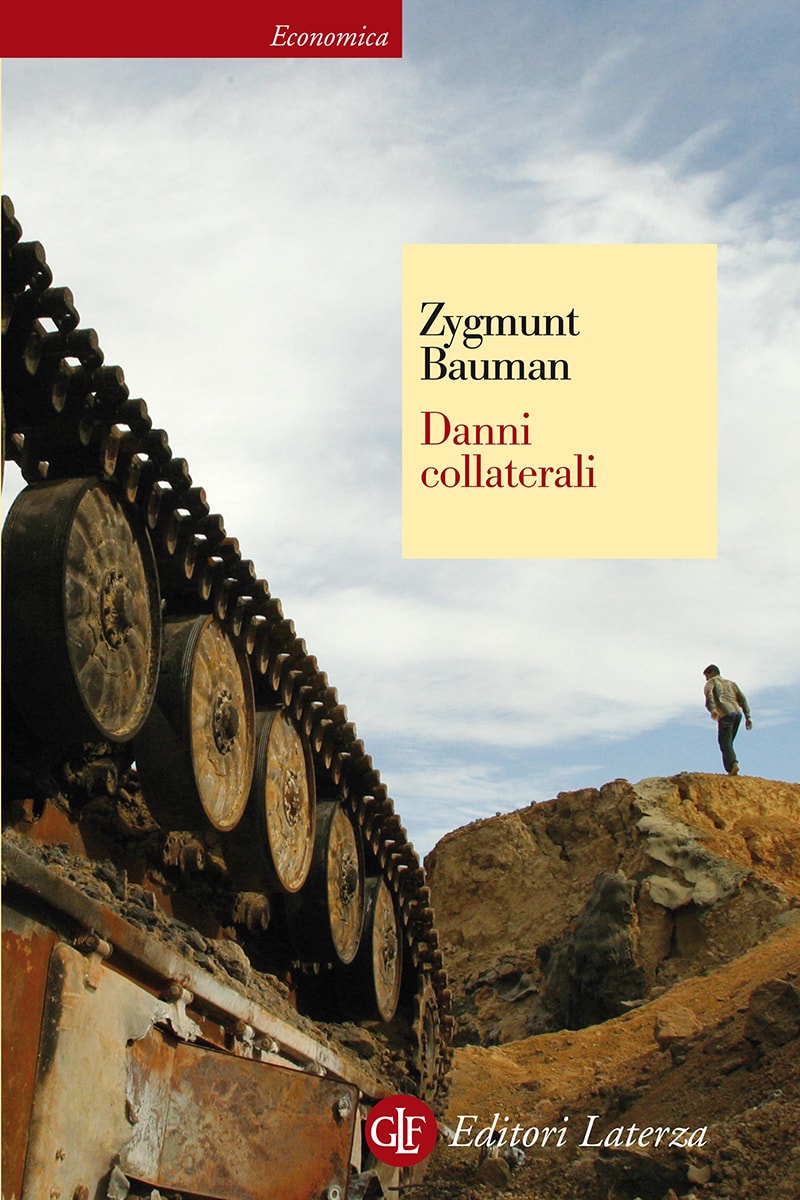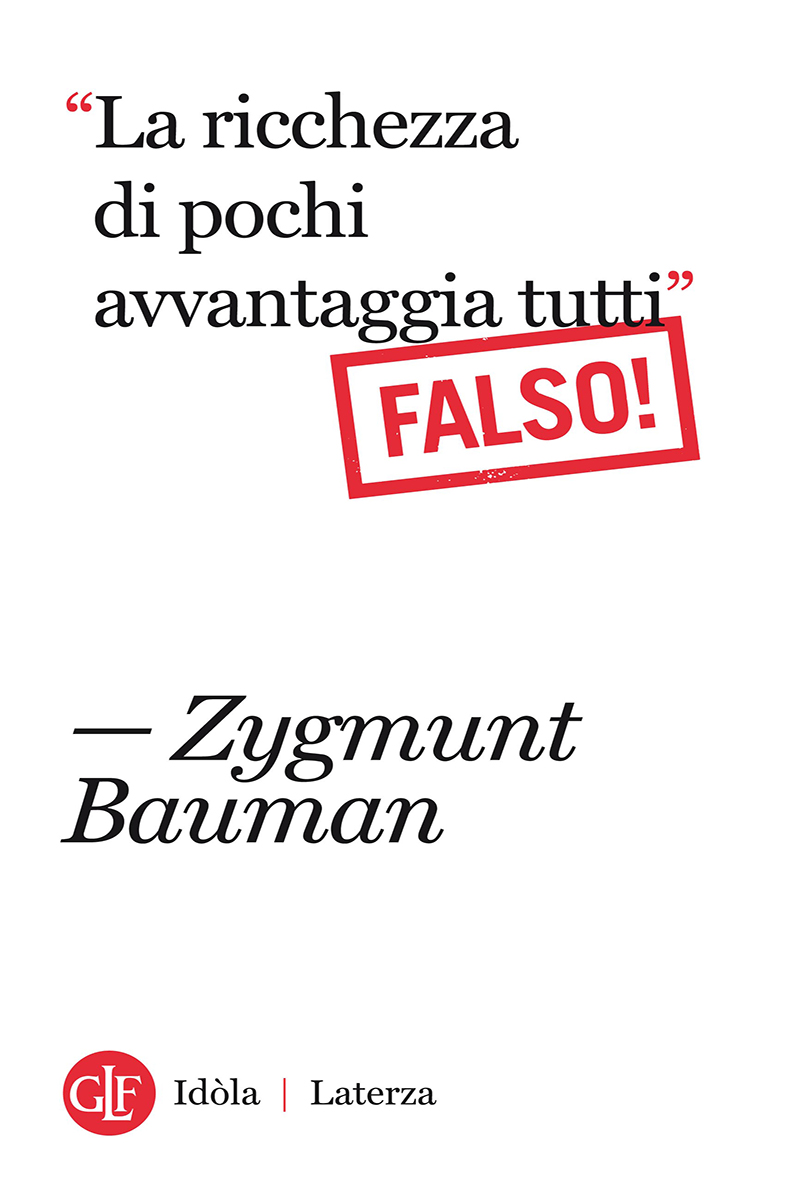Cecità morale
Quando il dolore morale perde la salutare funzione di avvertimento, di allarme e di spinta ad aiutare il nostro simile, inizia il tempo della cecità morale.
La cultura consumistica trasforma qualsiasi negozio o agenzia di servizi in una farmacia dove rifornirsi di tranquillanti e analgesici per attenuare o placare dolori che in questo caso non sono fisici ma morali. Man mano che la negligenza morale si estende e si intensifica, aumenta a dismisura la domanda di antidolorifici e il ricorso a tranquillanti morali diventa assuefazione. Il risultato è che l'insensibilità morale artificialmente indotta tende a diventare compulsiva, una sorta di ‘seconda natura’. Il dolore morale viene soffocato prima che diventi davvero fastidioso e preoccupante, e la trama dei legami umani, intessuta di morale, si fa sempre più fragile e delicata, fino a lacerarsi. I cittadini vengono addestrati a cercare sui mercati, nel consumo, la salvezza dai propri guai, la soluzione ai propri problemi, e la politica si trova (anzi è pungolata, spinta, in ultima analisi costretta) a interpellare i propri governati come consumatori anziché come cittadini, facendo del consumo l’adempimento di un primario dovere civico...