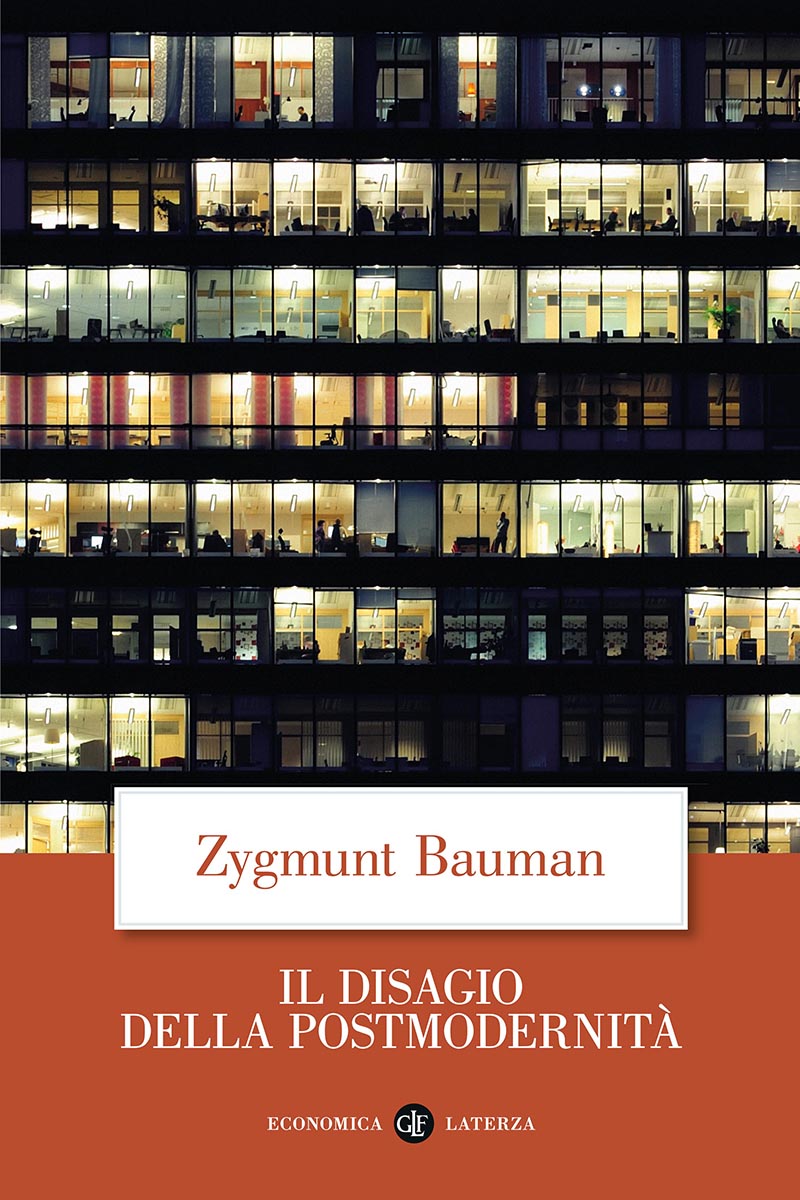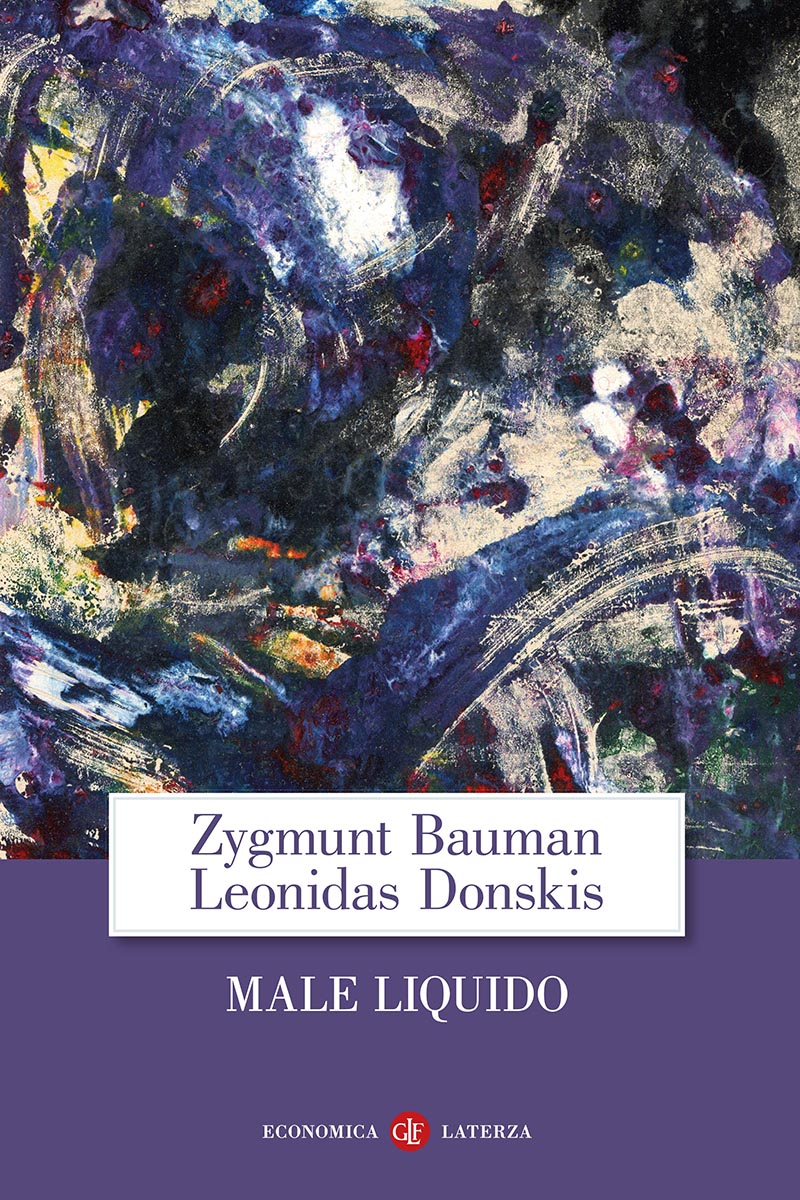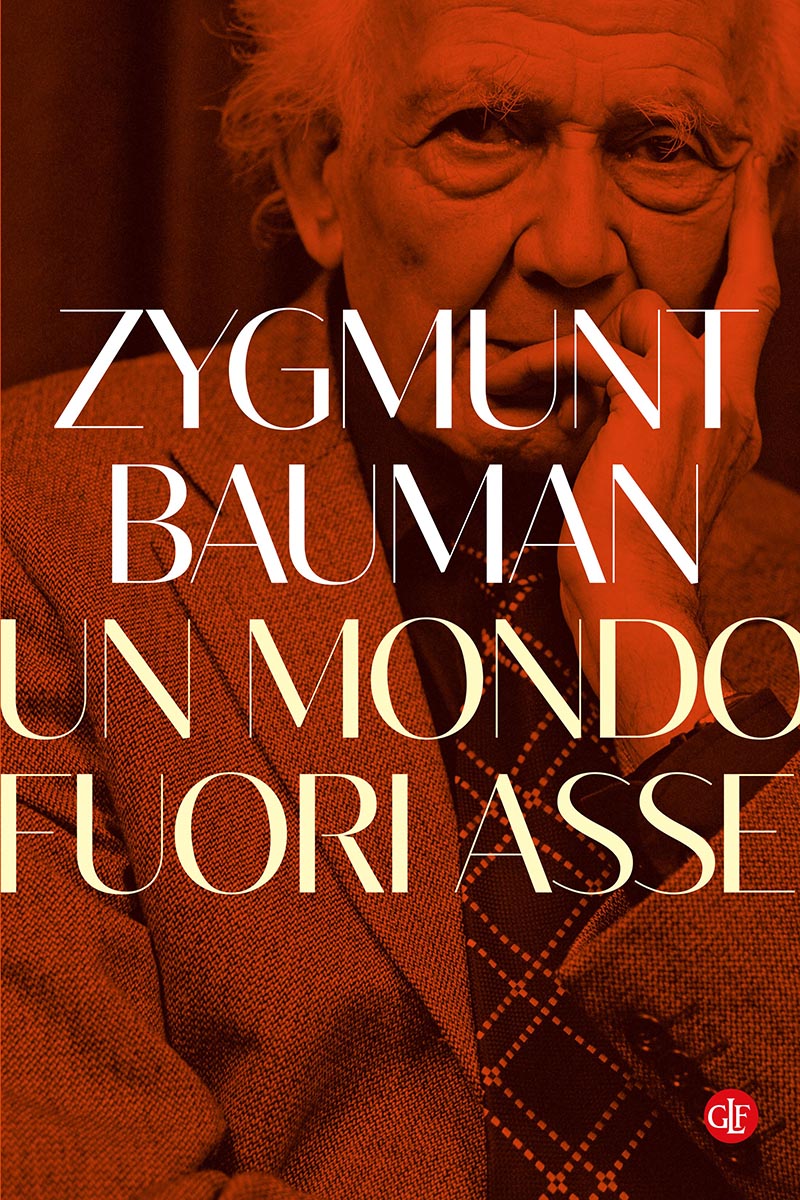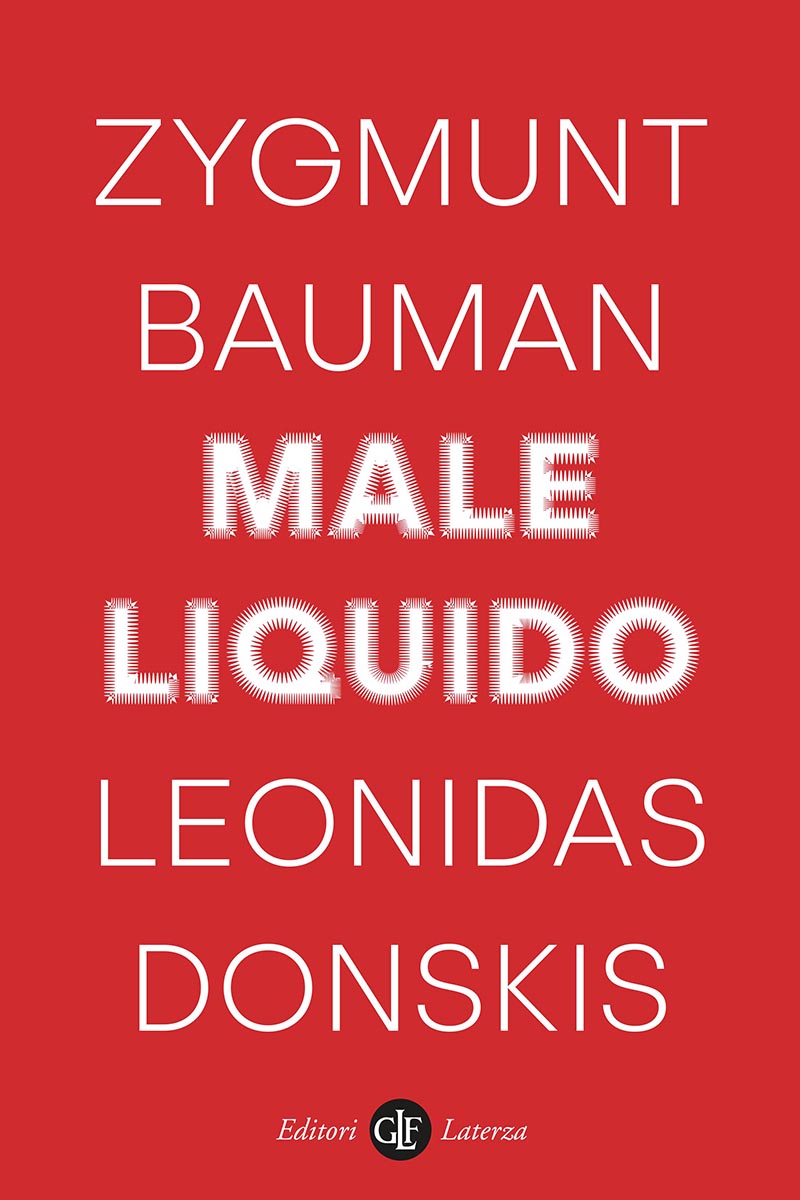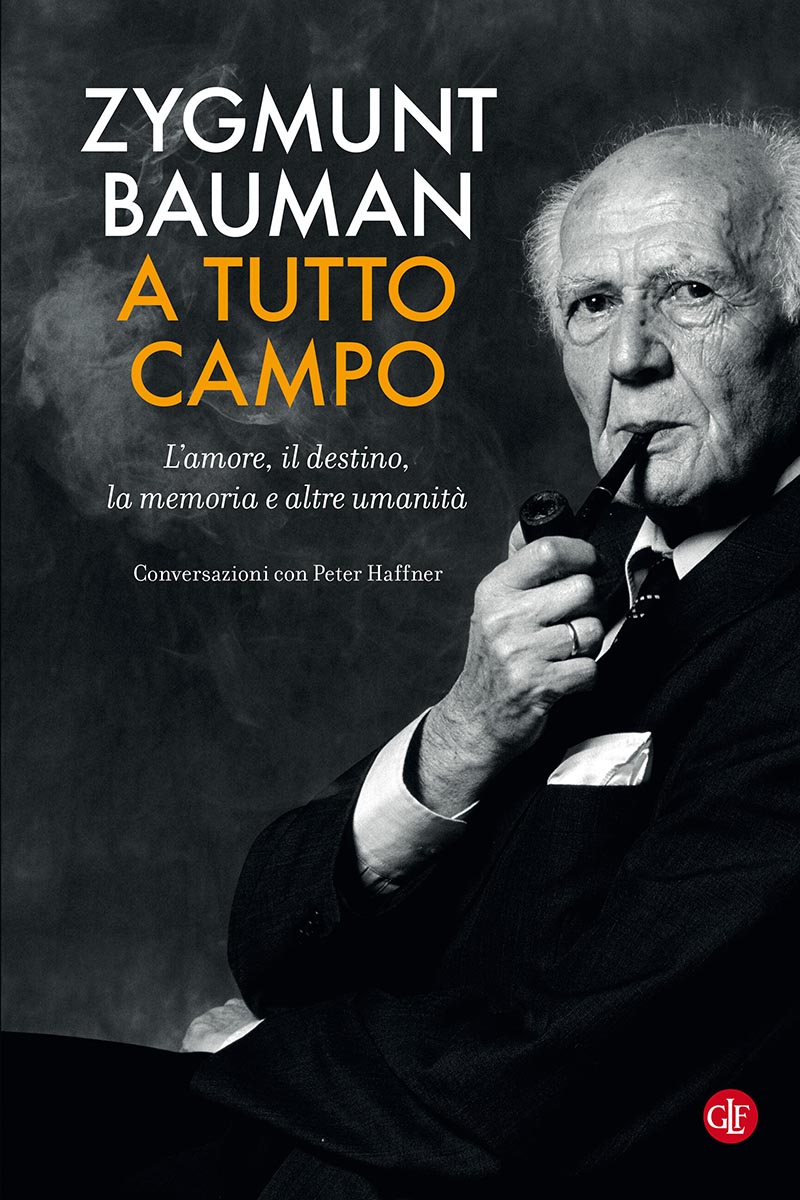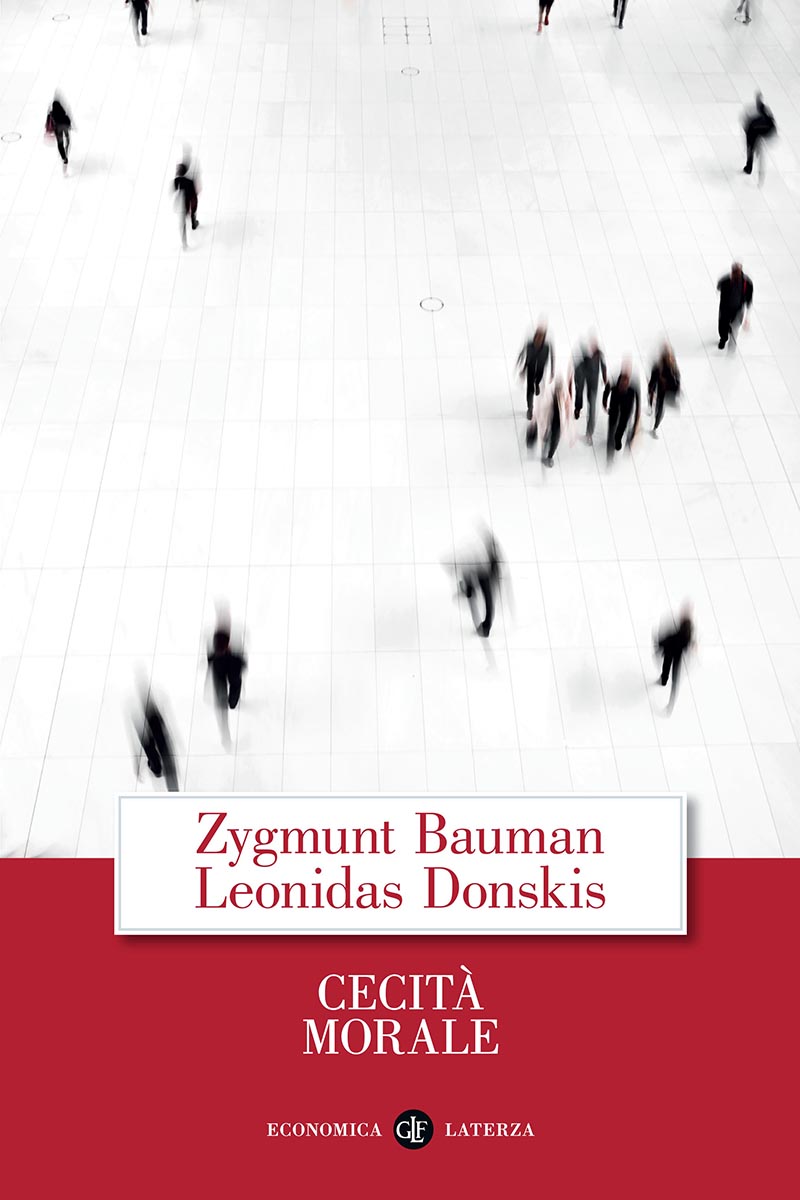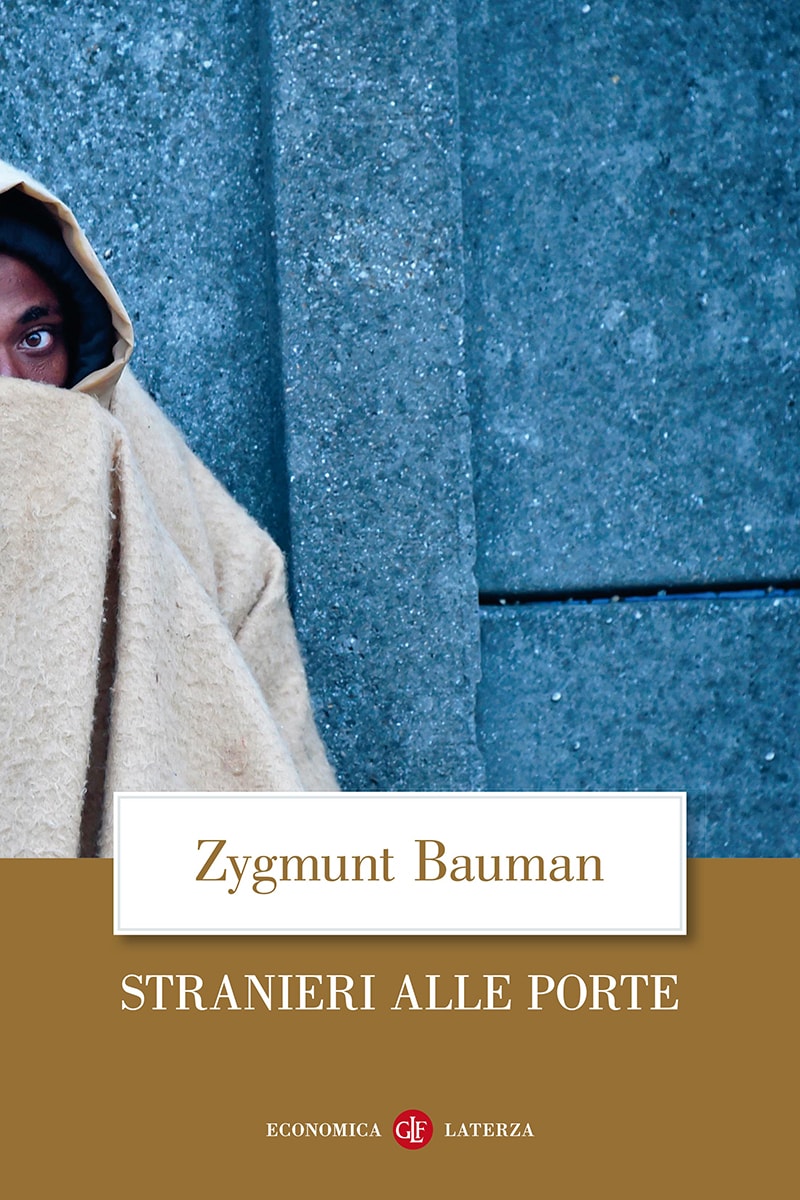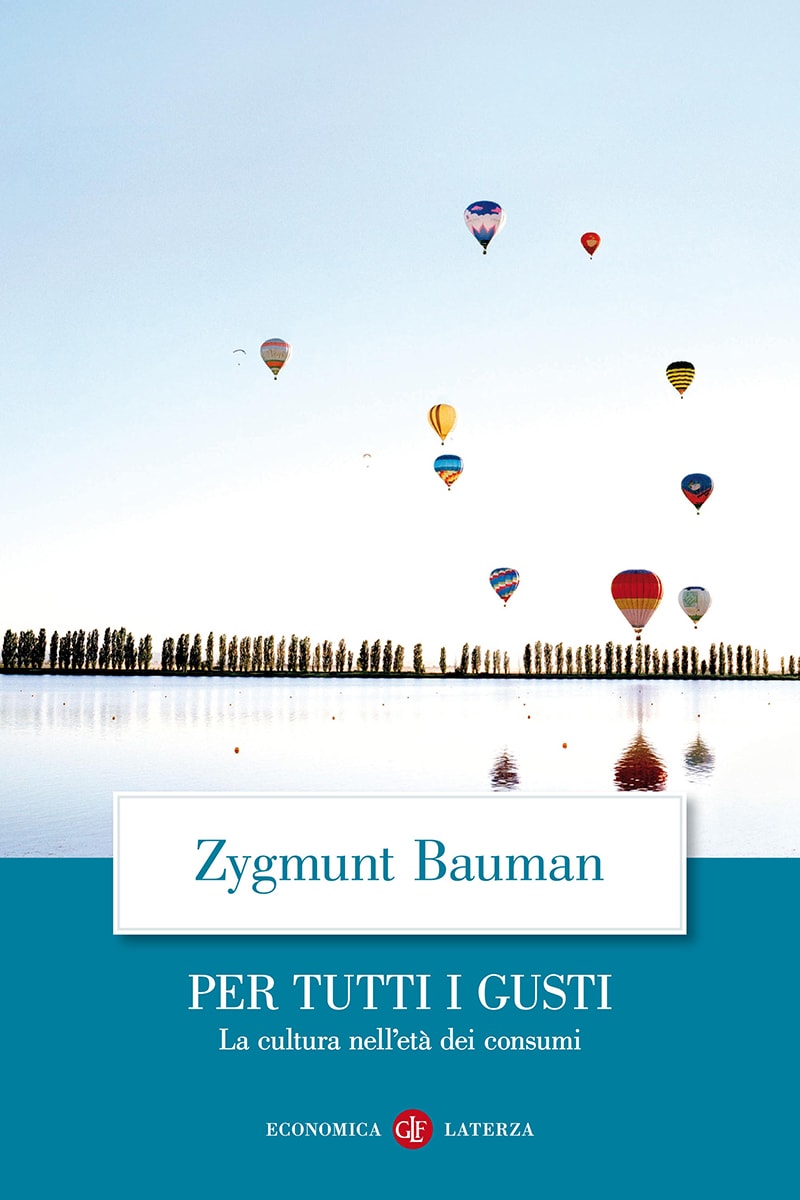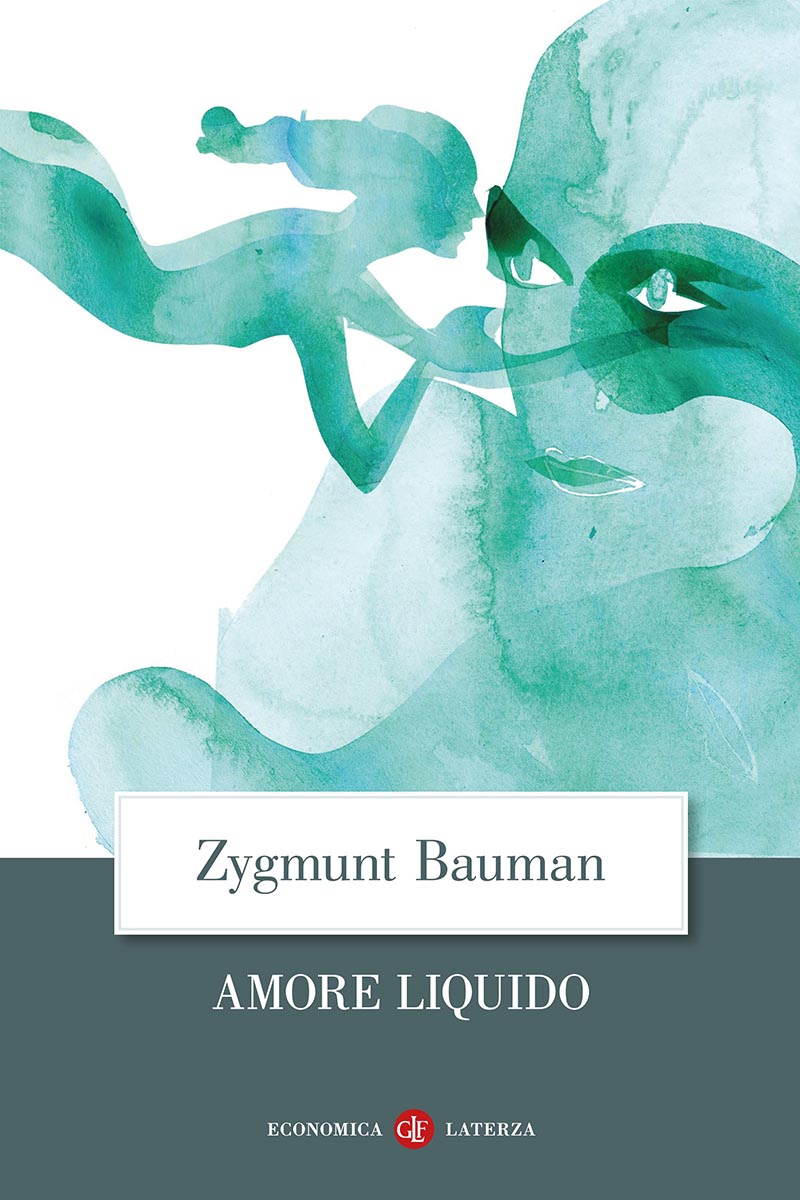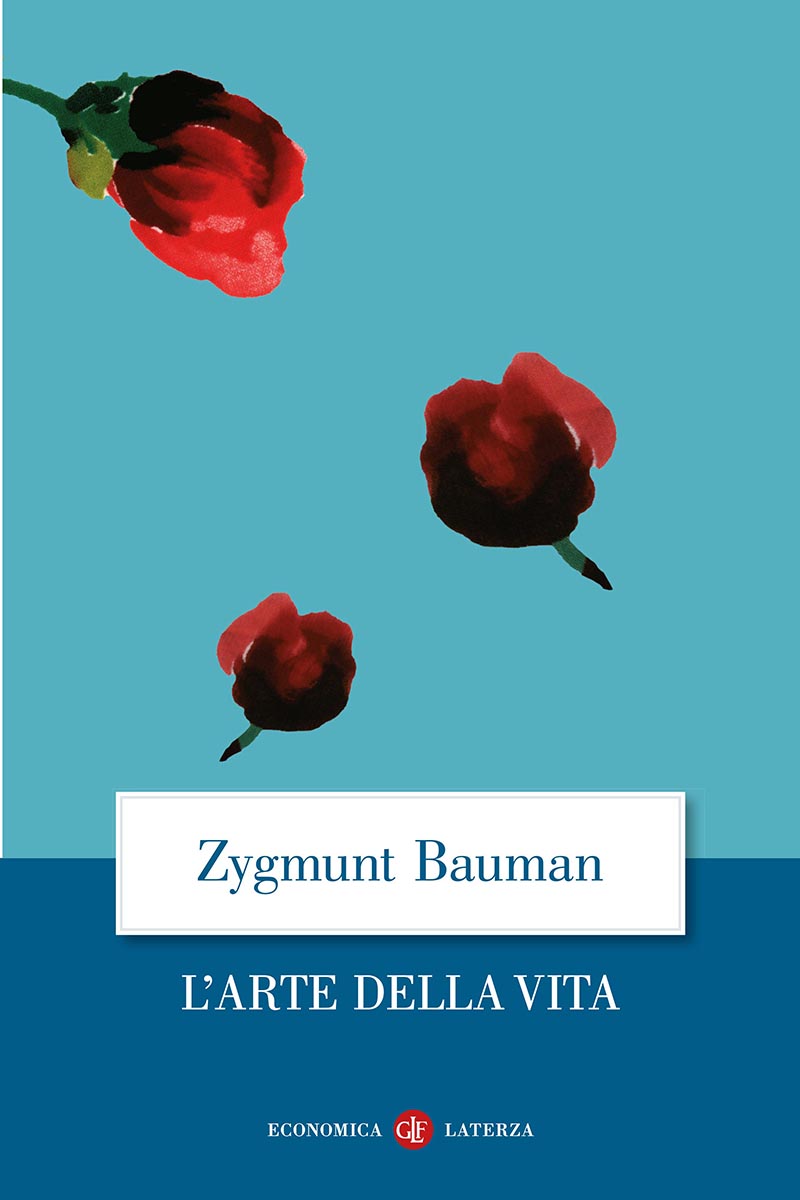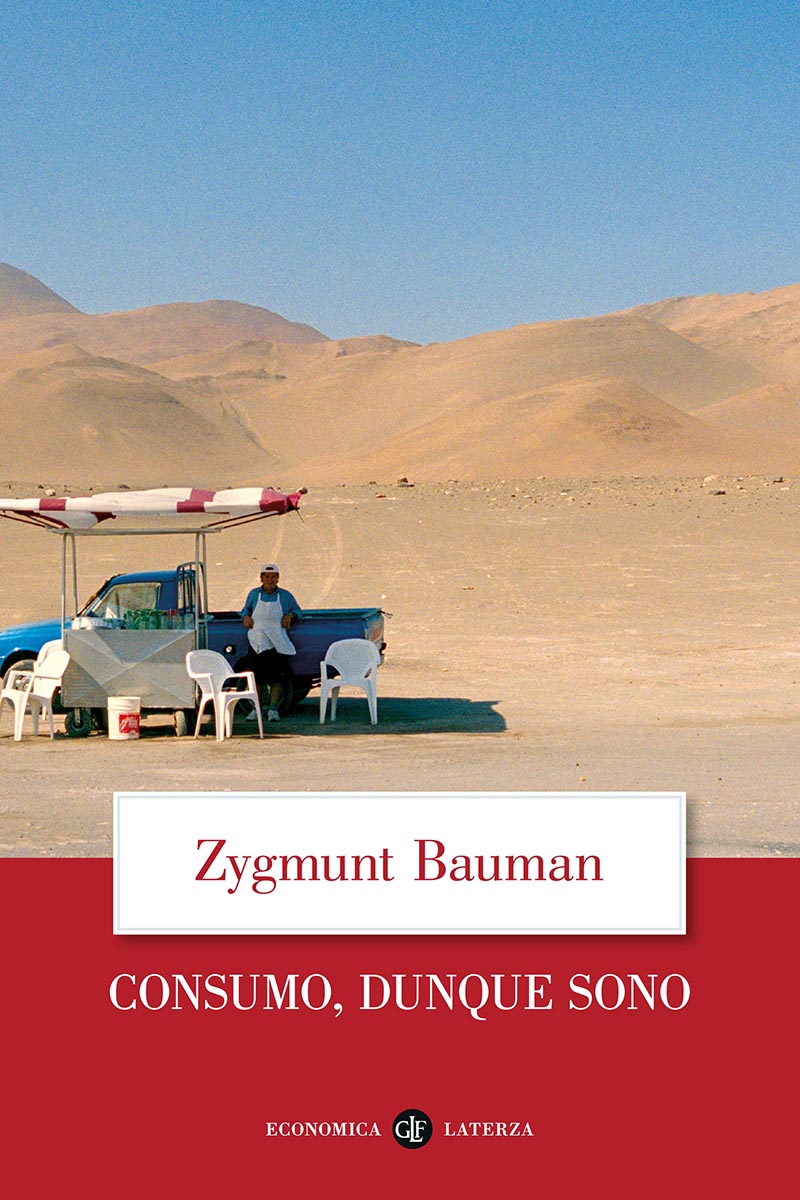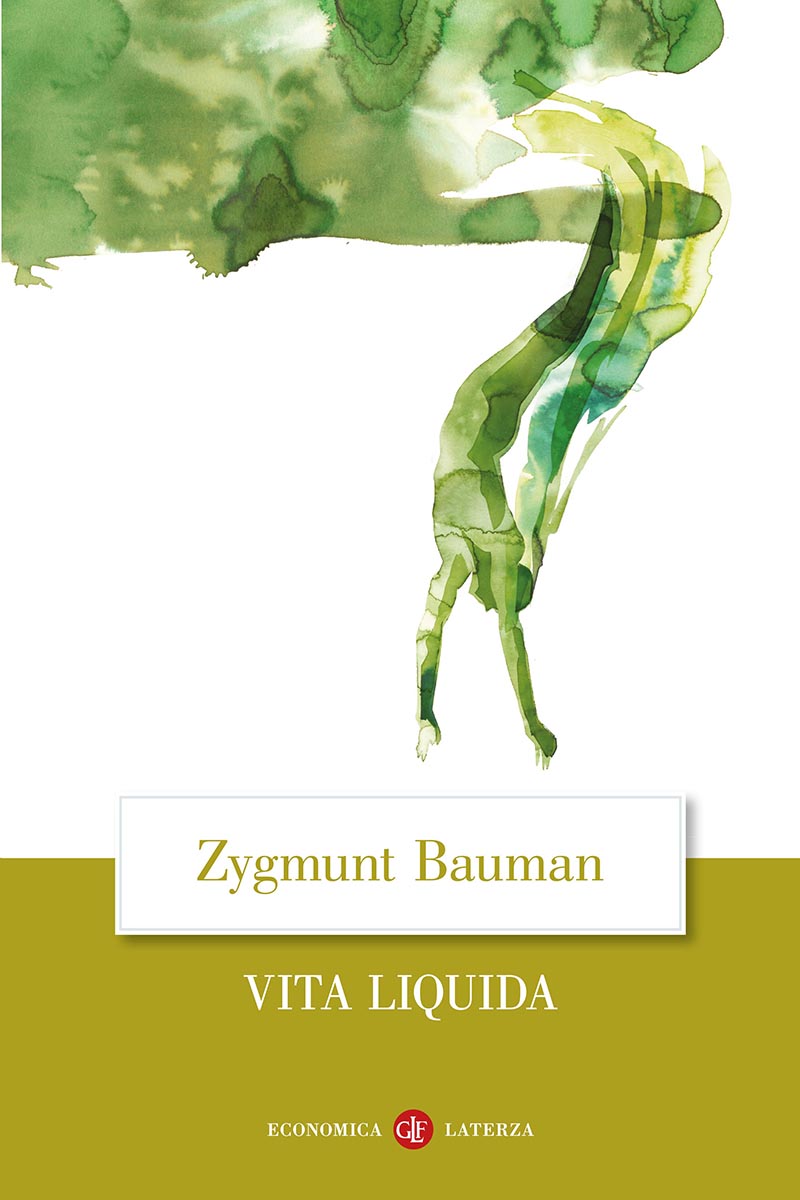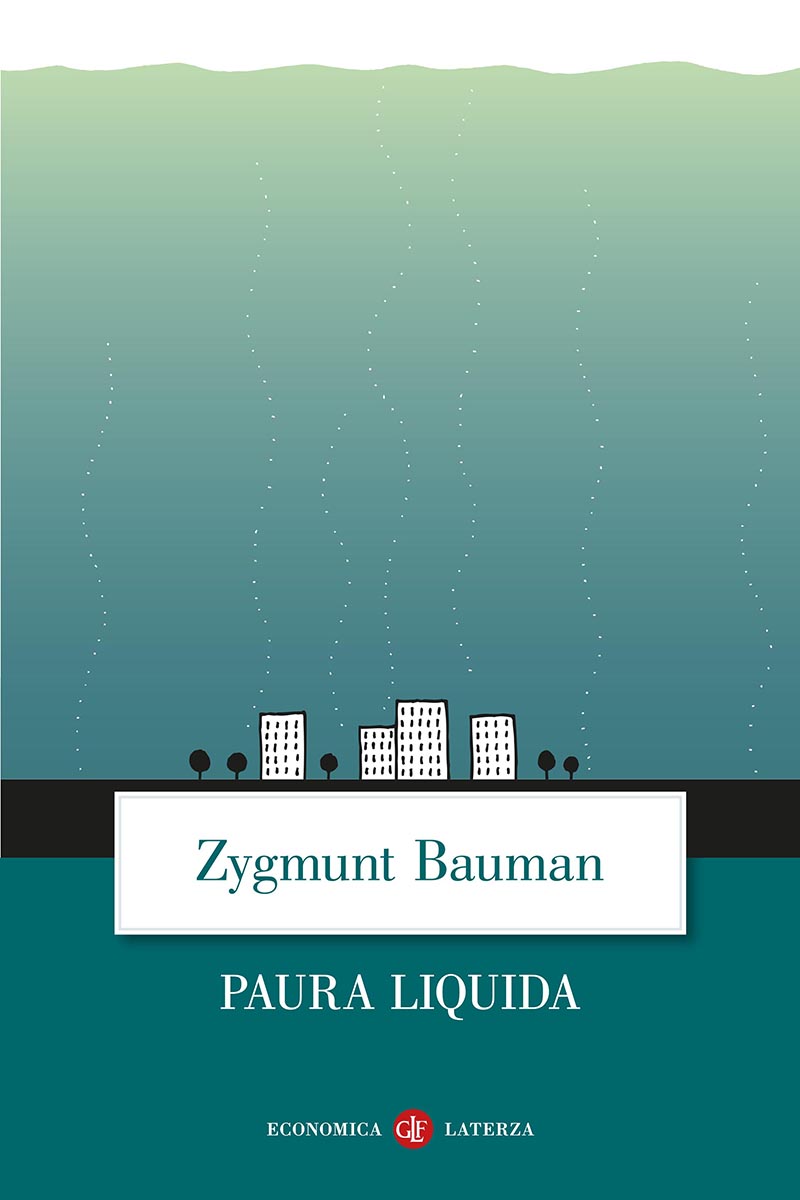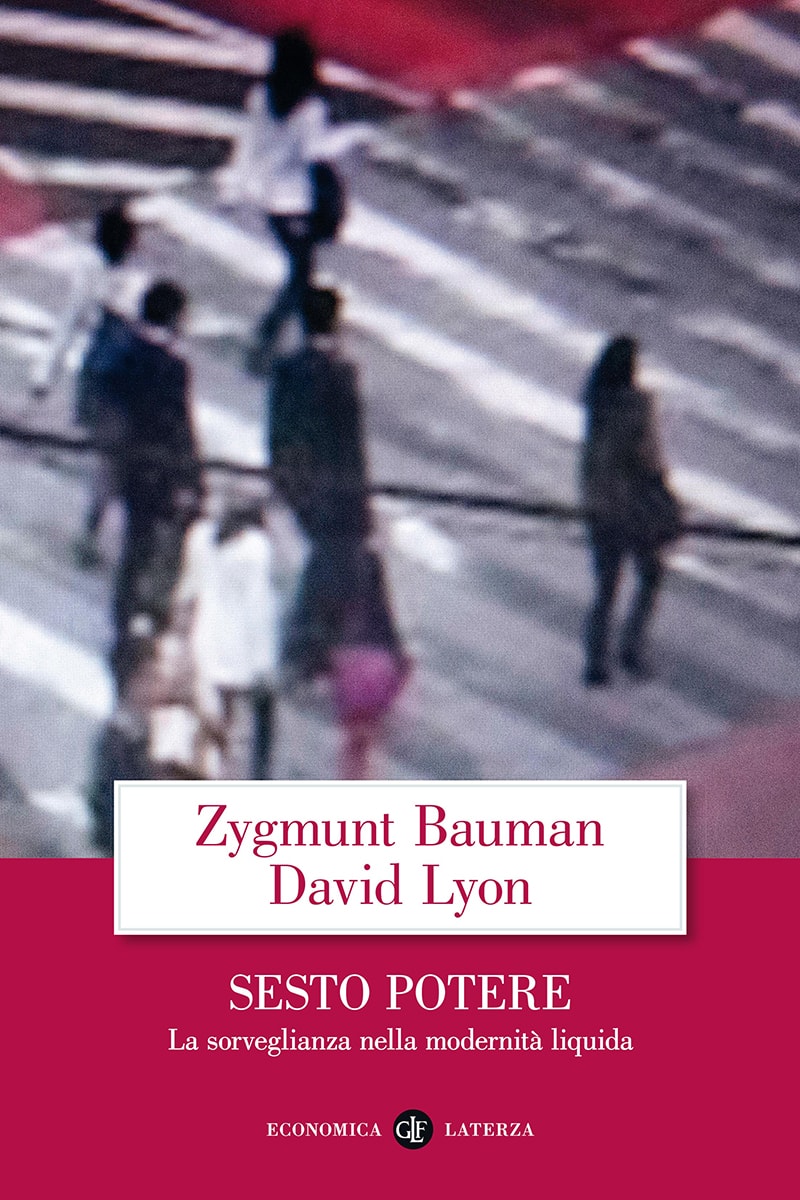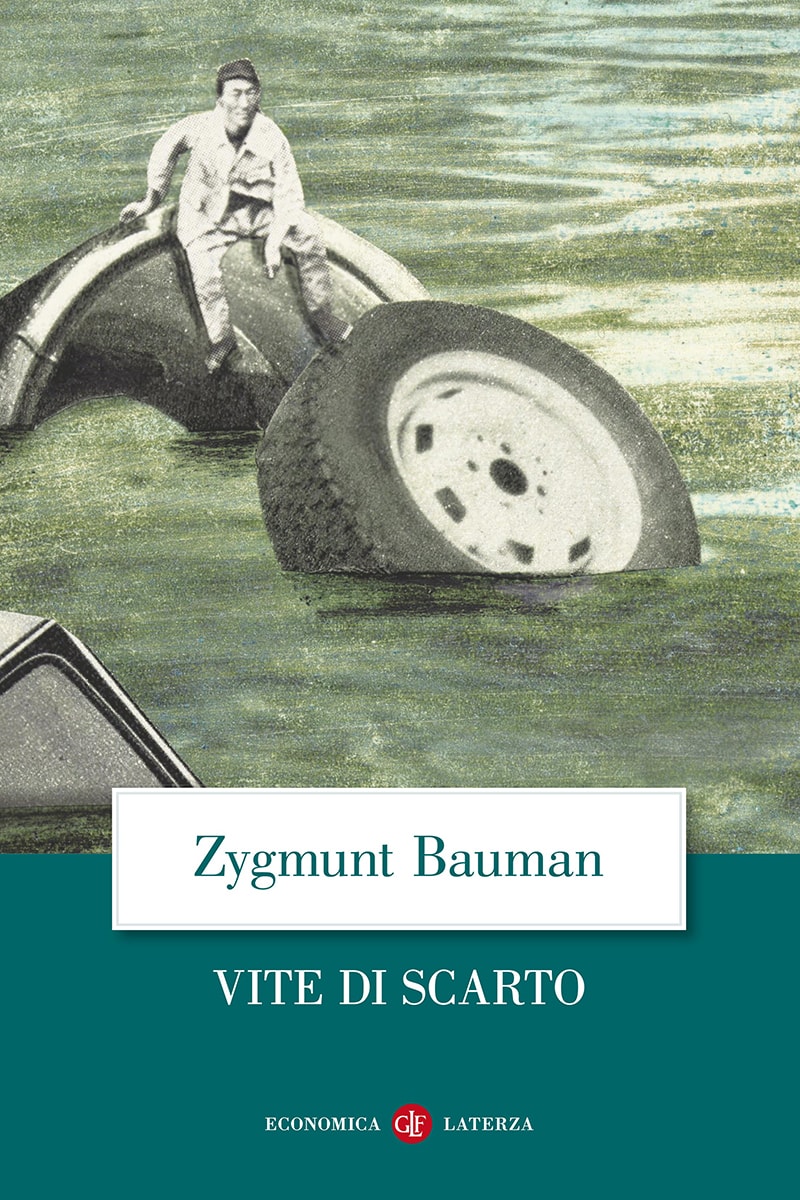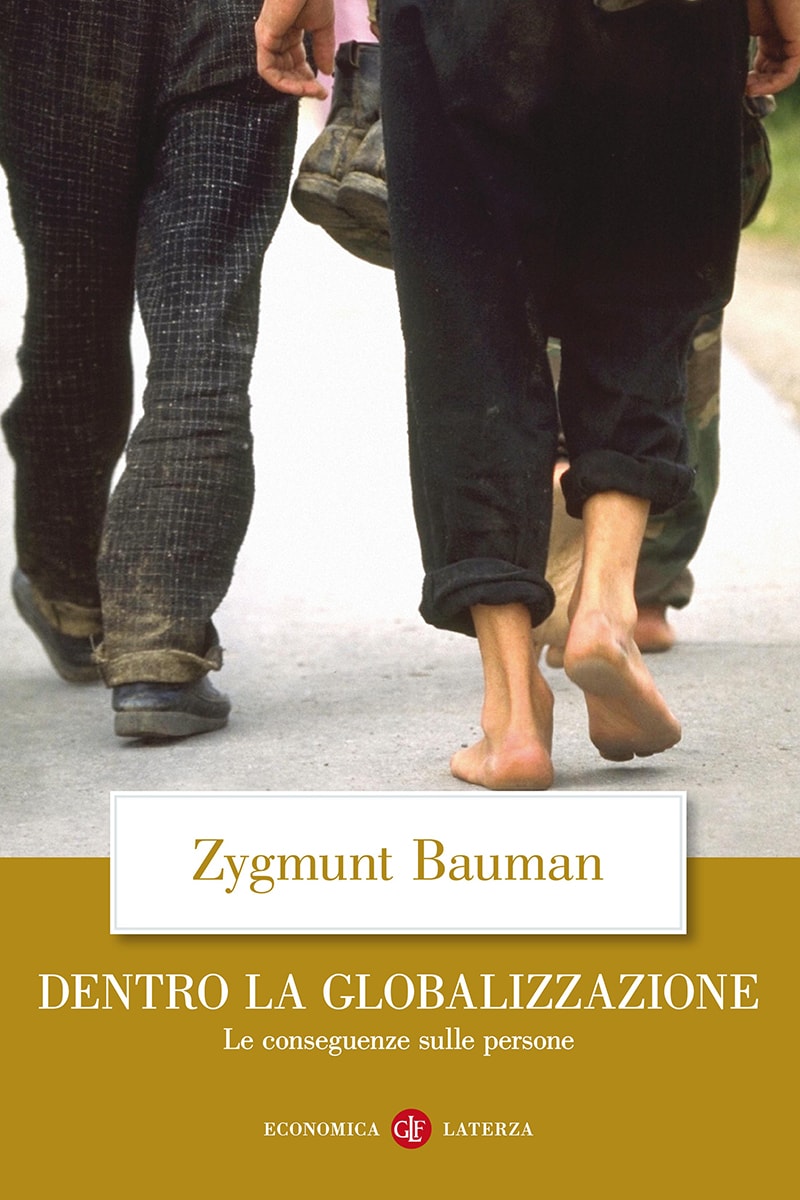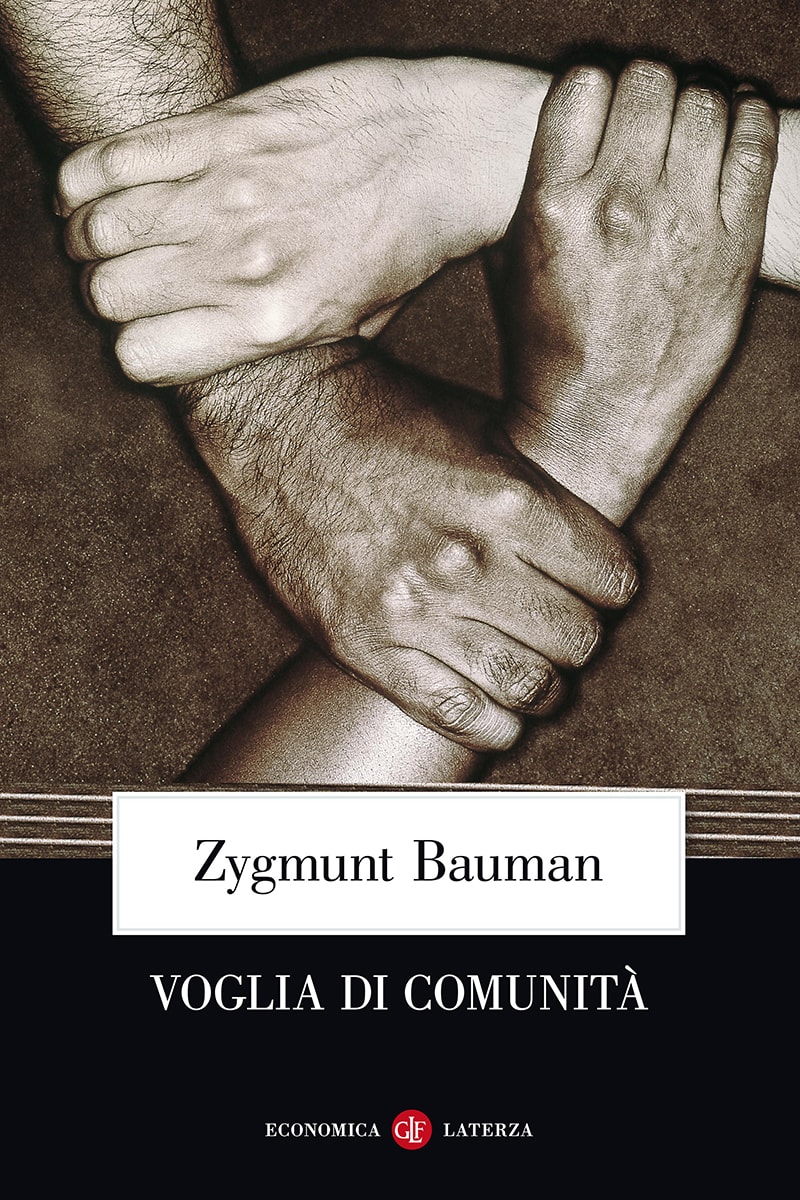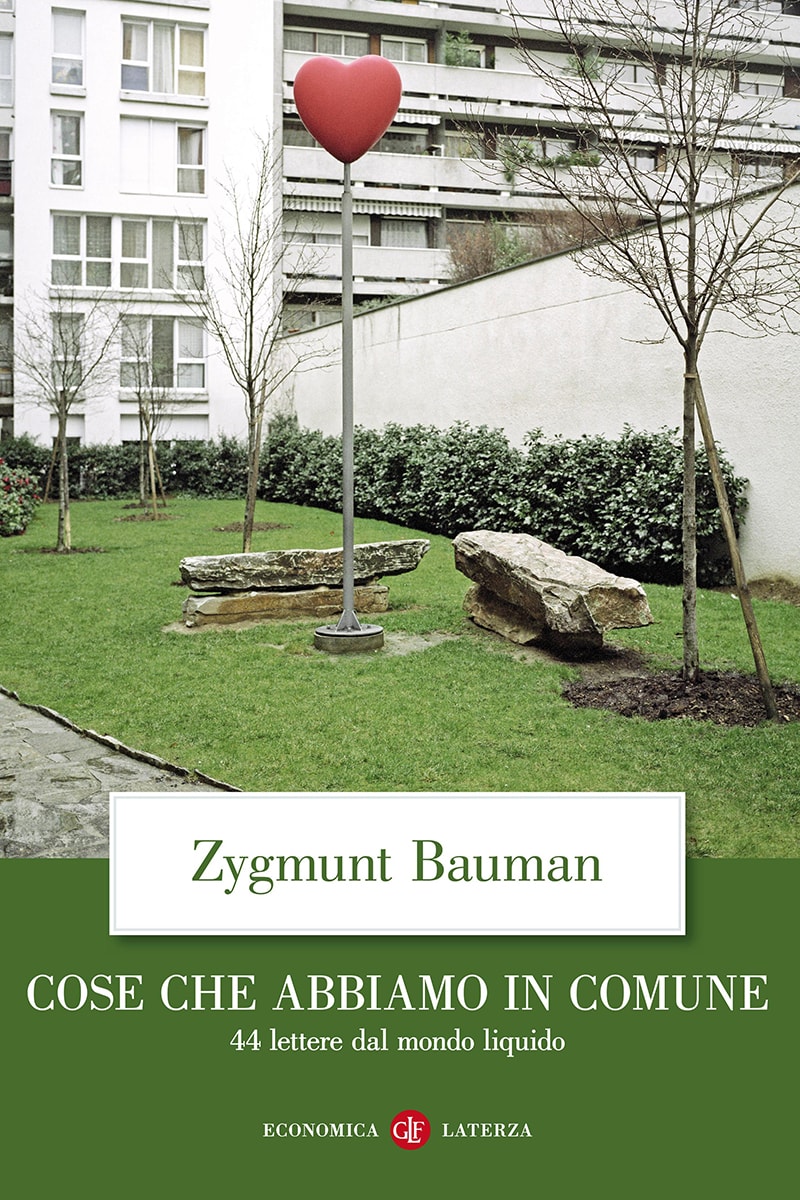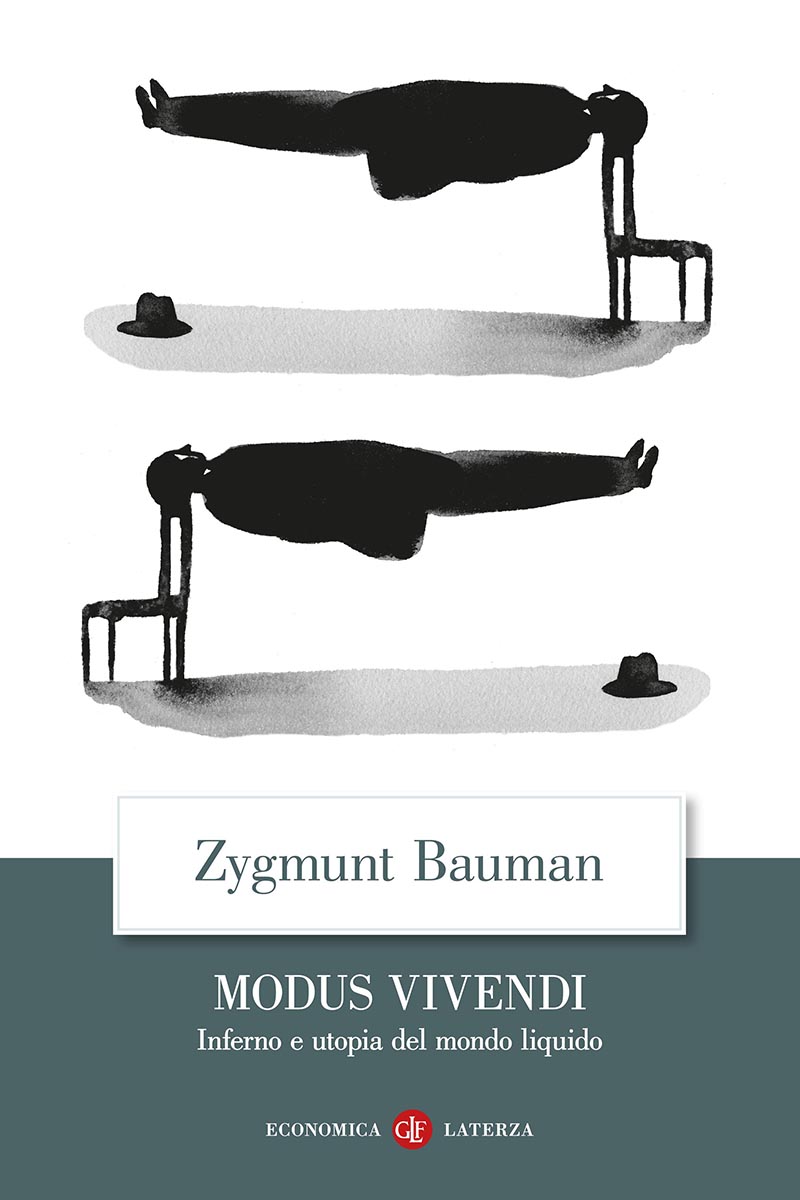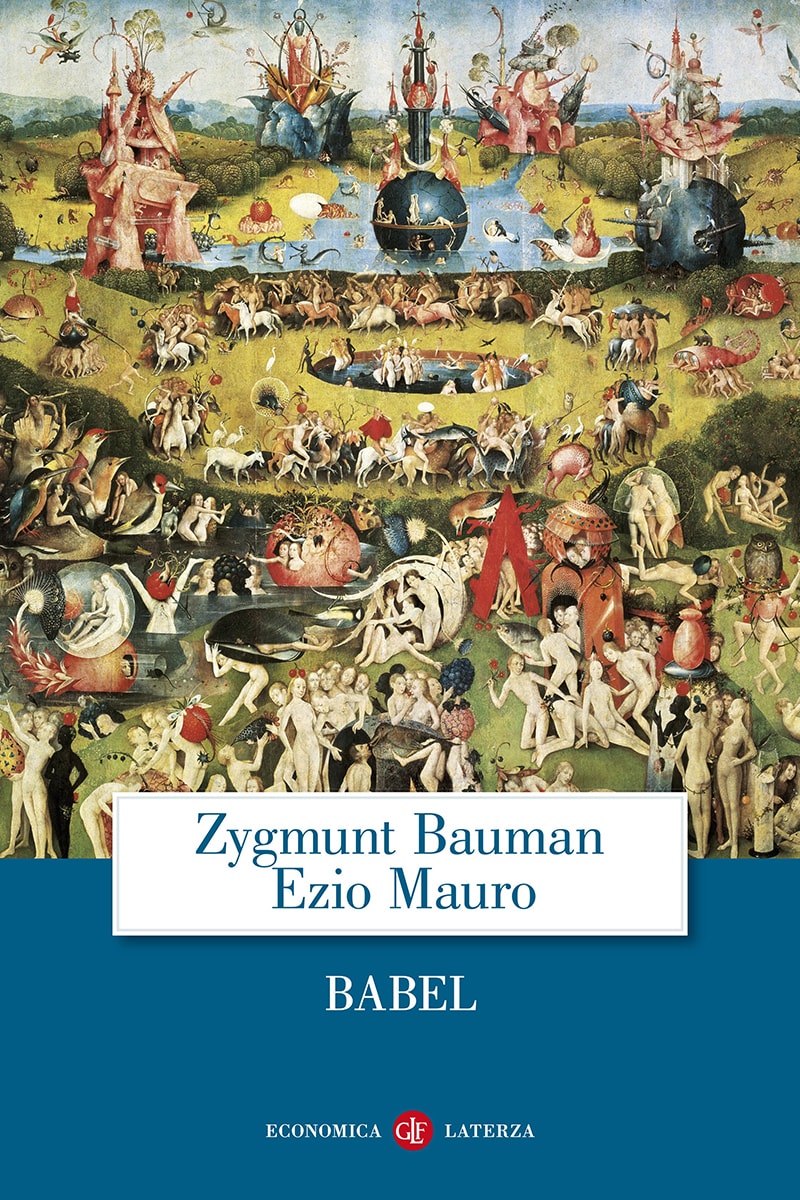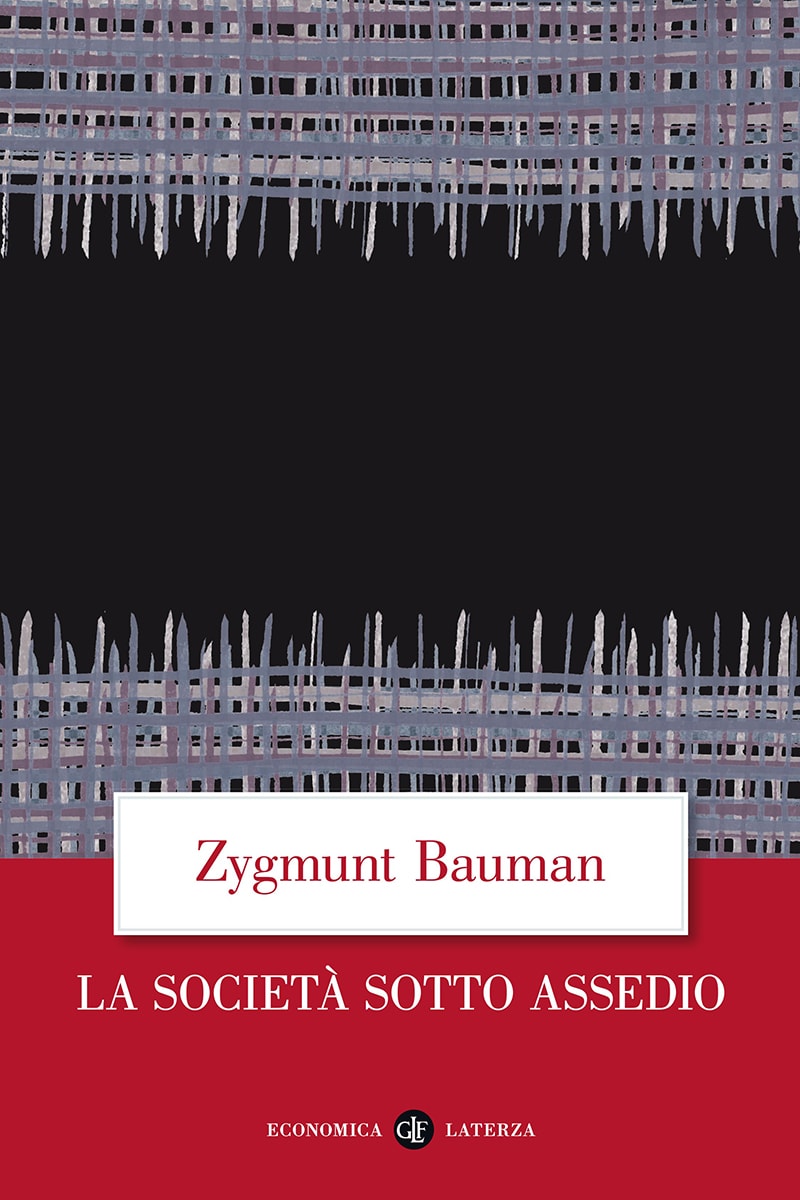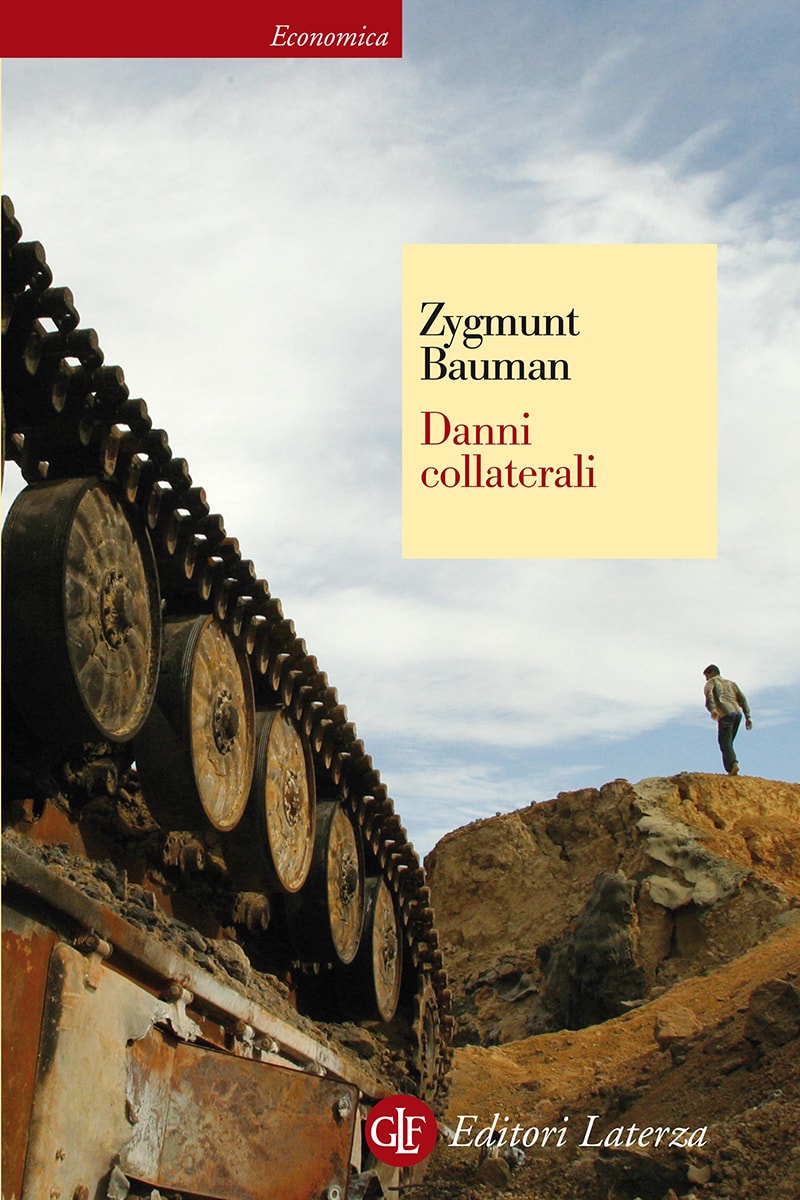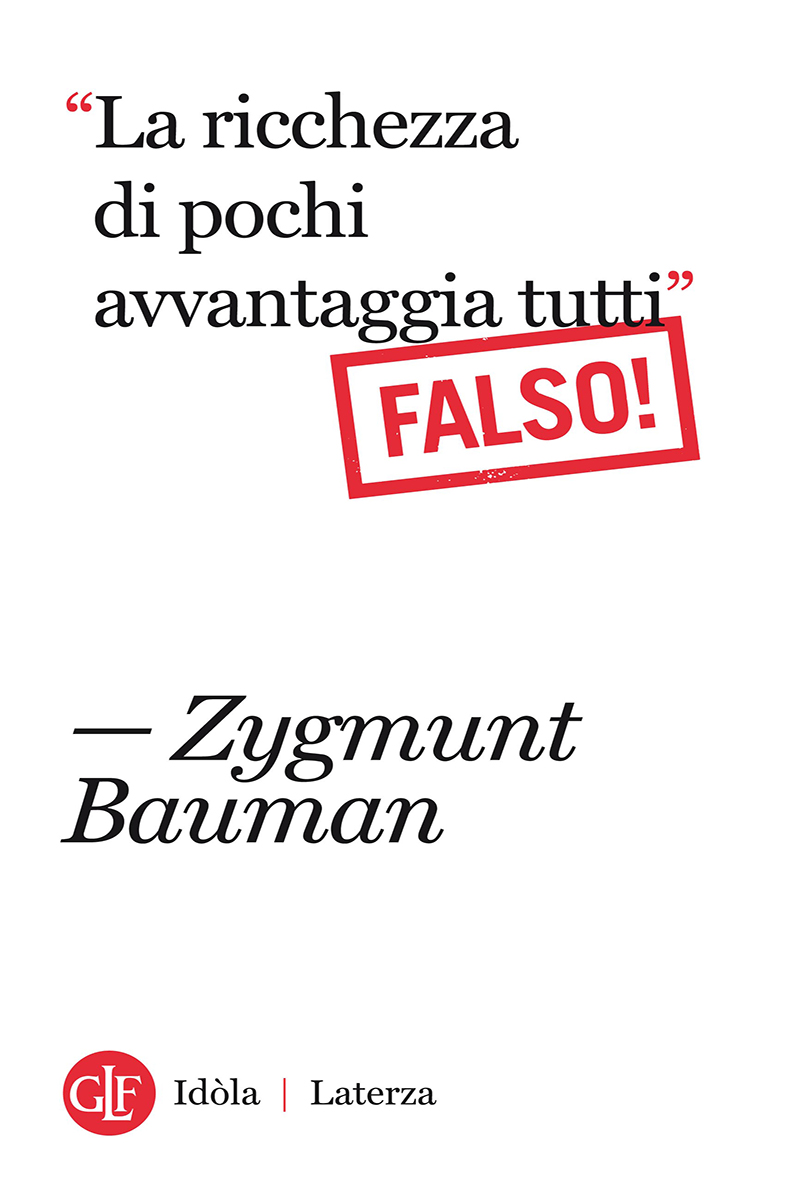Vite che non possiamo permetterci
Il diritto, l'economia, la cultura, la politica, la religione, i sentimenti al tempo nostro e secondo Bauman.
L'arte della nostra vita si può ridurre a una sola tecnica: lo shopping sapiente e coscienzioso. Al quale nemmeno il corpo sfugge. Anche a costo di trasformarci tutti, vecchi e giovani, in una razza di debitori. «Se si potessero paragonare le teorie sociali o i teorici della sociologia a utensili da cucina, Zygmunt Bauman sarebbe sicuramente uno dei coltelli più taglienti»: così dice di lui Citlali Rovirosa-Madrazo alla fine delle loro conversazioni sui grandi temi del nostro presente.
Un esempio tra i tanti delle nostre esistenze: nel 2006 solo negli Stati Uniti sono stati eseguiti undici milioni di interventi cosmetici. La pubblicità tipica di una clinica di chirurgia cosmetica (attività che ha ormai dato vita a una enorme e lucrosa industria) è carica di tentazioni cui difficilmente una donna preoccupata per il proprio aspetto riesce a resistere. «E così la storia si ripete per l'ennesima volta: un corpo femminile 'non migliorato' è stato scoperto come 'terra vergine' non ancora messa a coltura. Neanche un centimetro quadrato del corpo di una donna è impossibile da migliorare. La vita è incerta – per una donna ancor più che per un uomo – e quell'insicurezza è potenzialmente un capitale che nessun uomo d'affari degno di questo nome terrebbe fermo. Poiché nessuna quantità di Botox, per quanto regolarmente applicata, potrà fugare quell'insicurezza, le aziende possono ben sperare in un flusso continuo e crescente di profitti». L'arte della vita, tanto sfaccettata, si può ridurre (questo il messaggio) a una sola tecnica: lo shopping sapiente e coscienzioso. Al quale nemmeno il corpo sfugge. Anche a costo di trasformarci tutti, vecchi e giovani, in una razza di debitori.
Rassegna stampa
-
Vite che non possiamo permetterci
Alla ricerca dell'utopia perduta
di Olimpia Troili
-
Vite che non possiamo permetterci
Così google ha creato la società della bambagia
di Roberto M. Danese