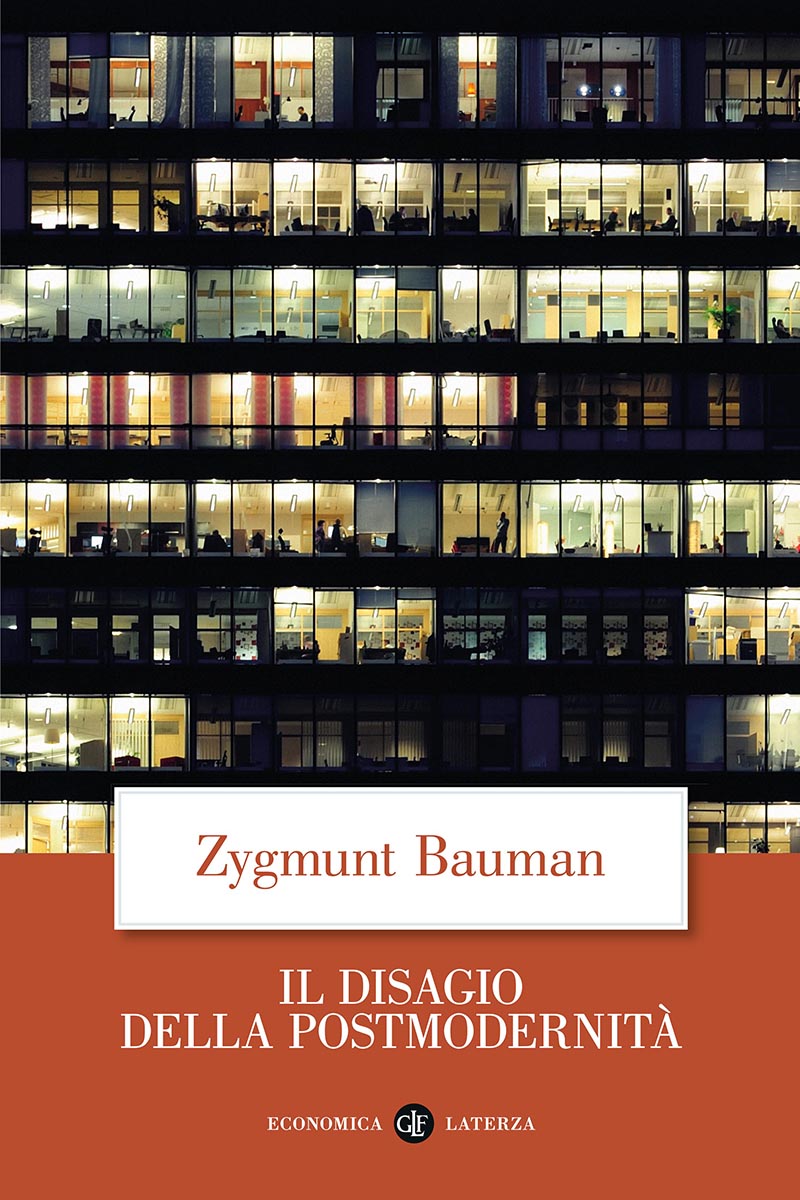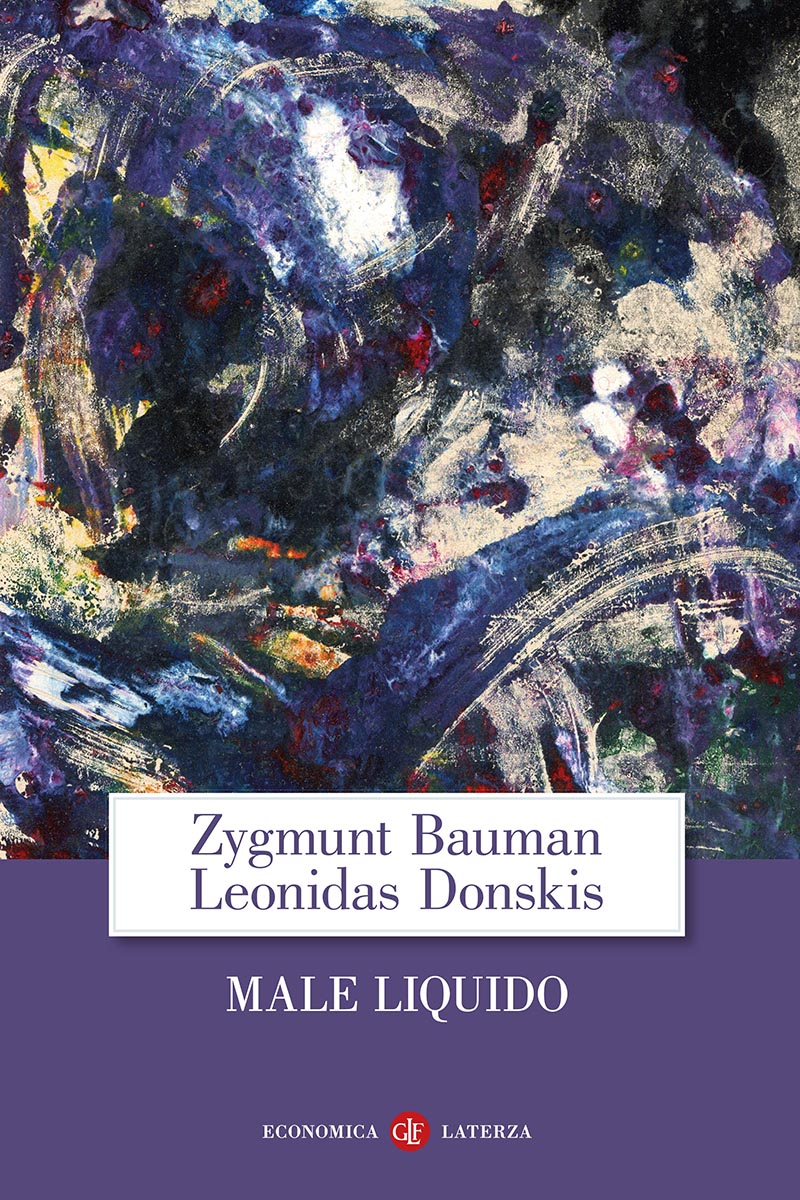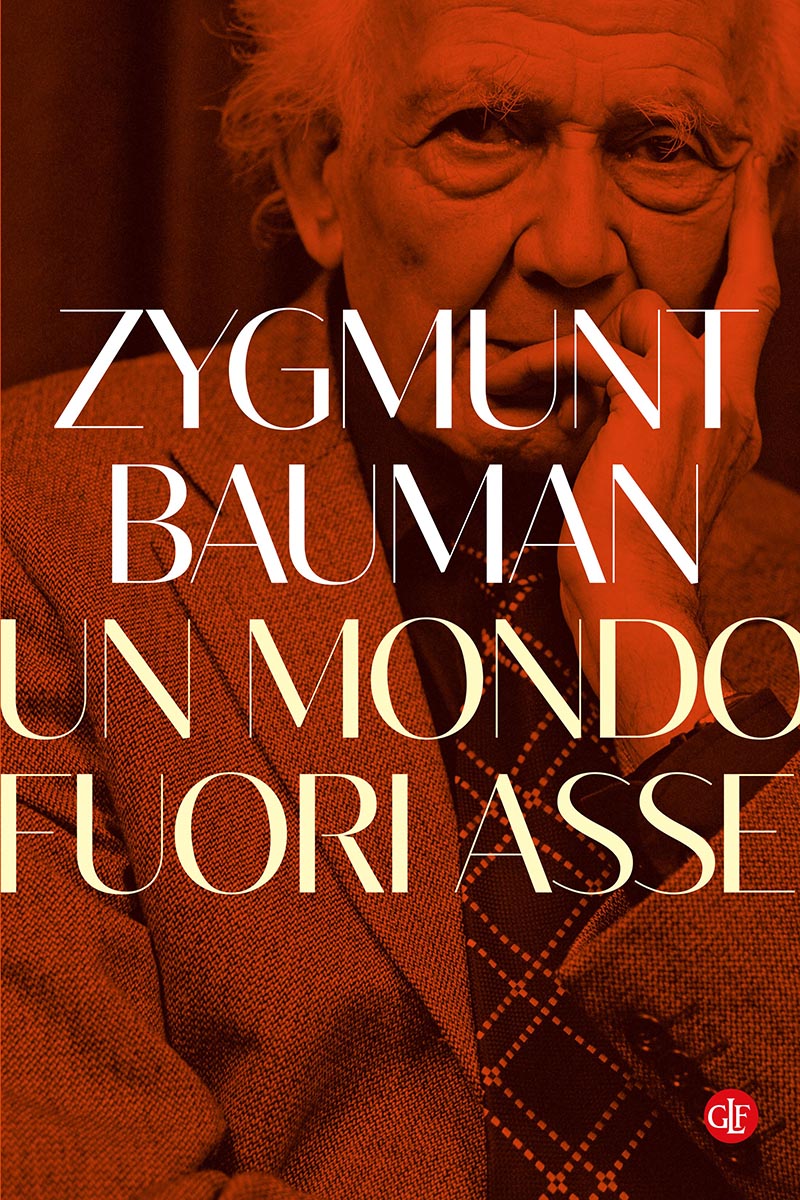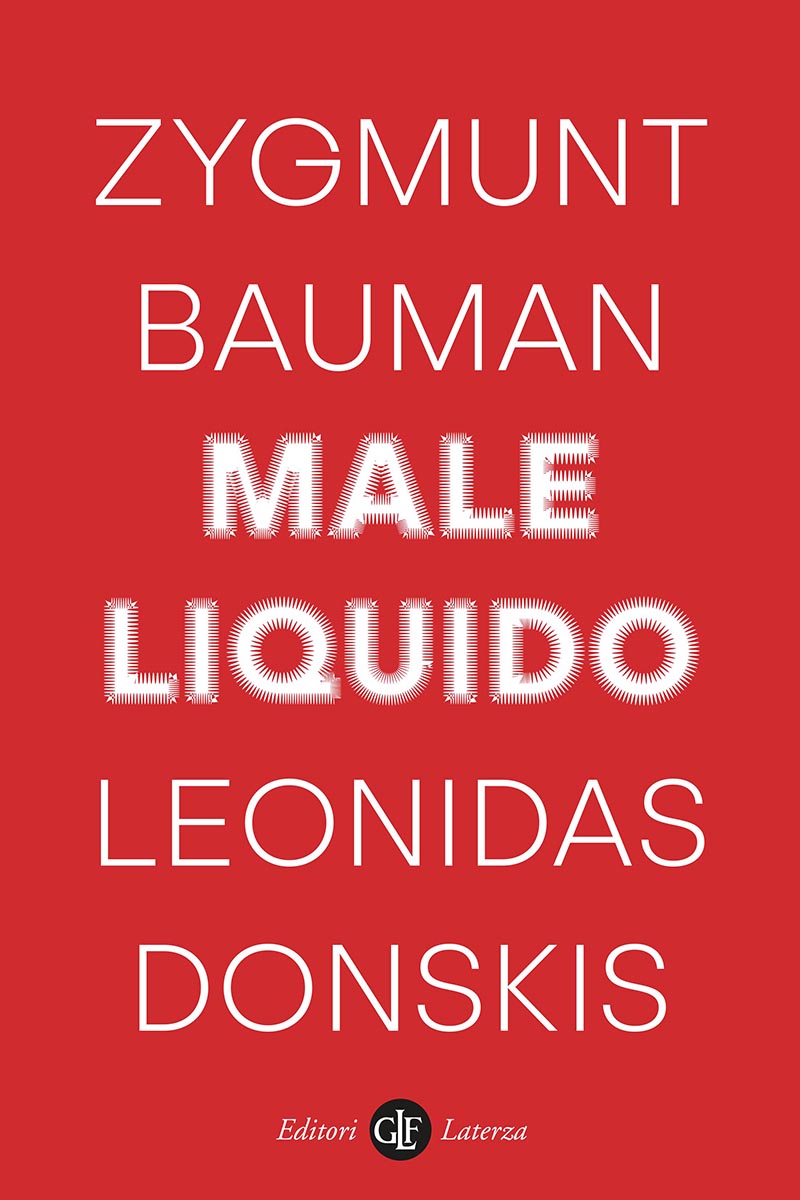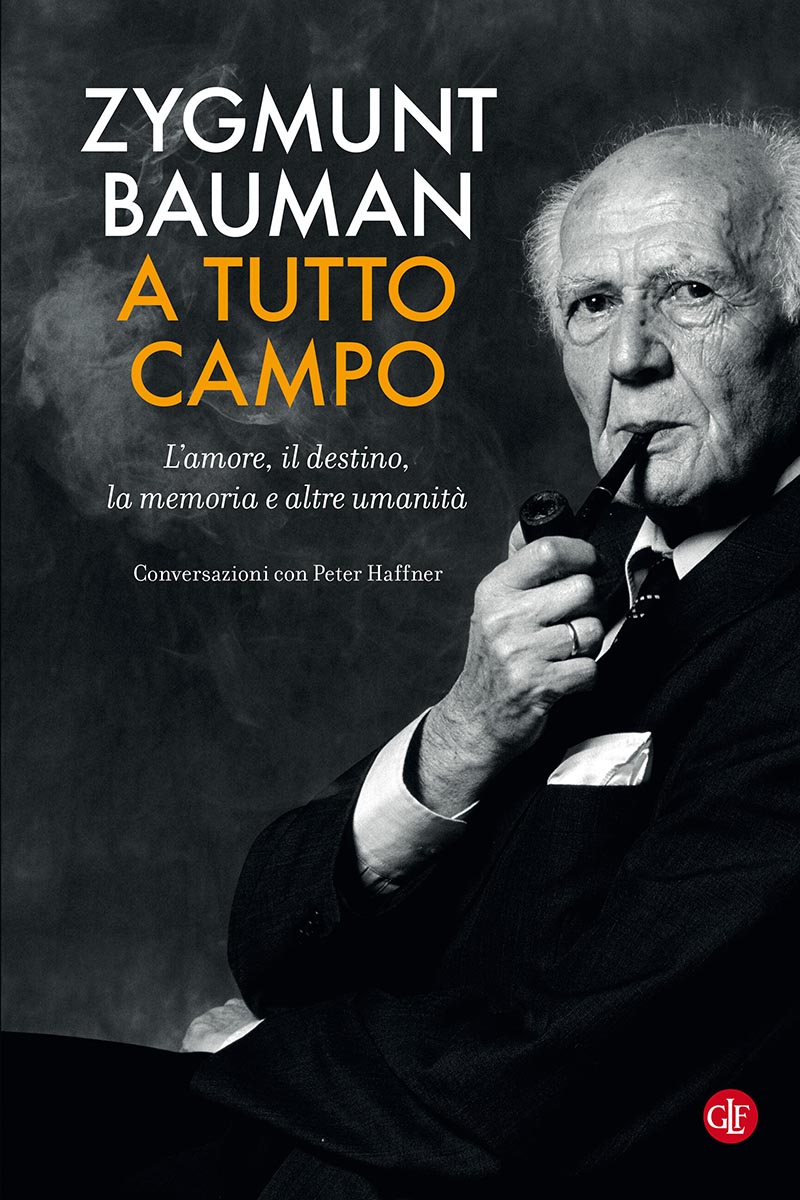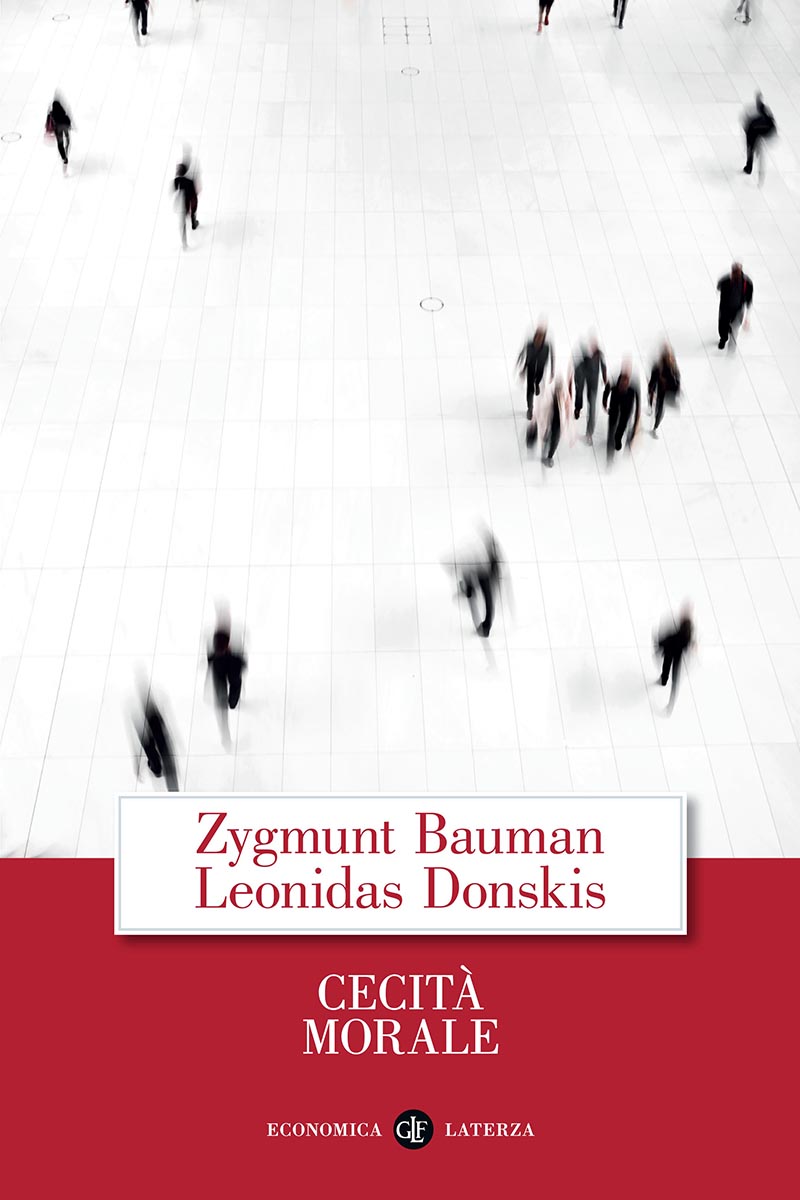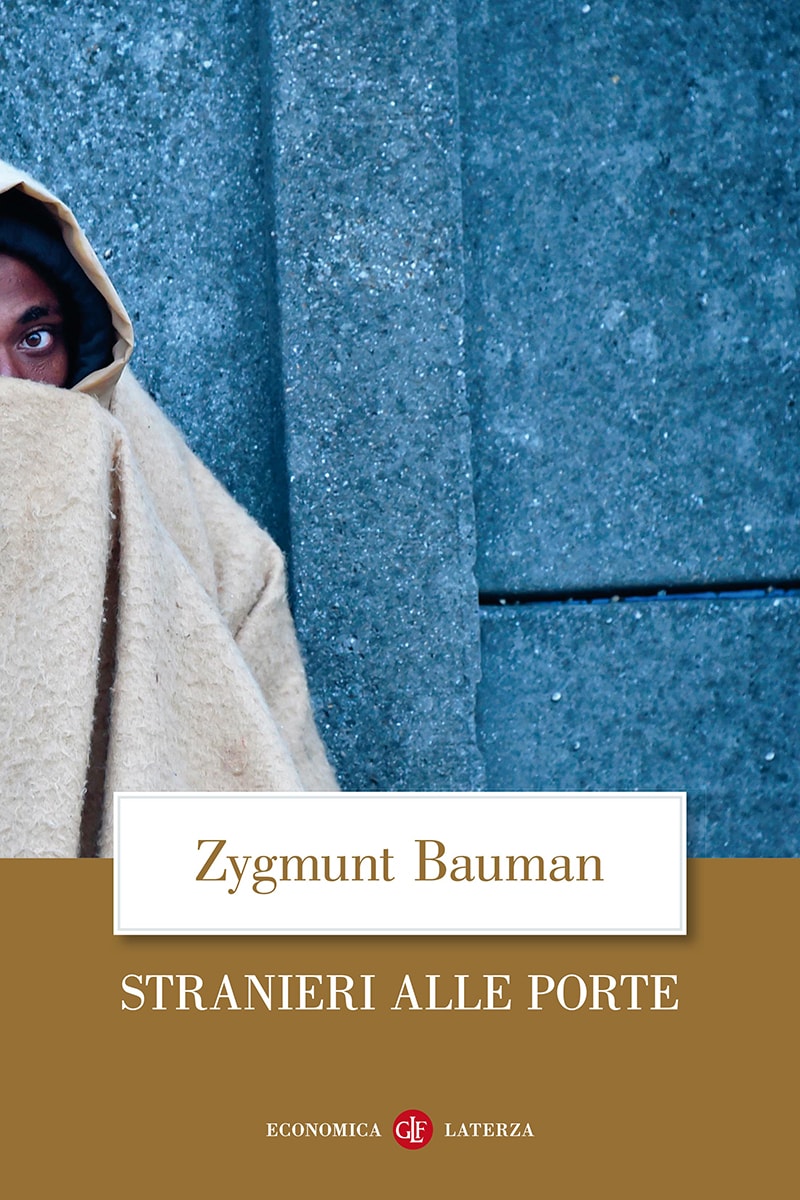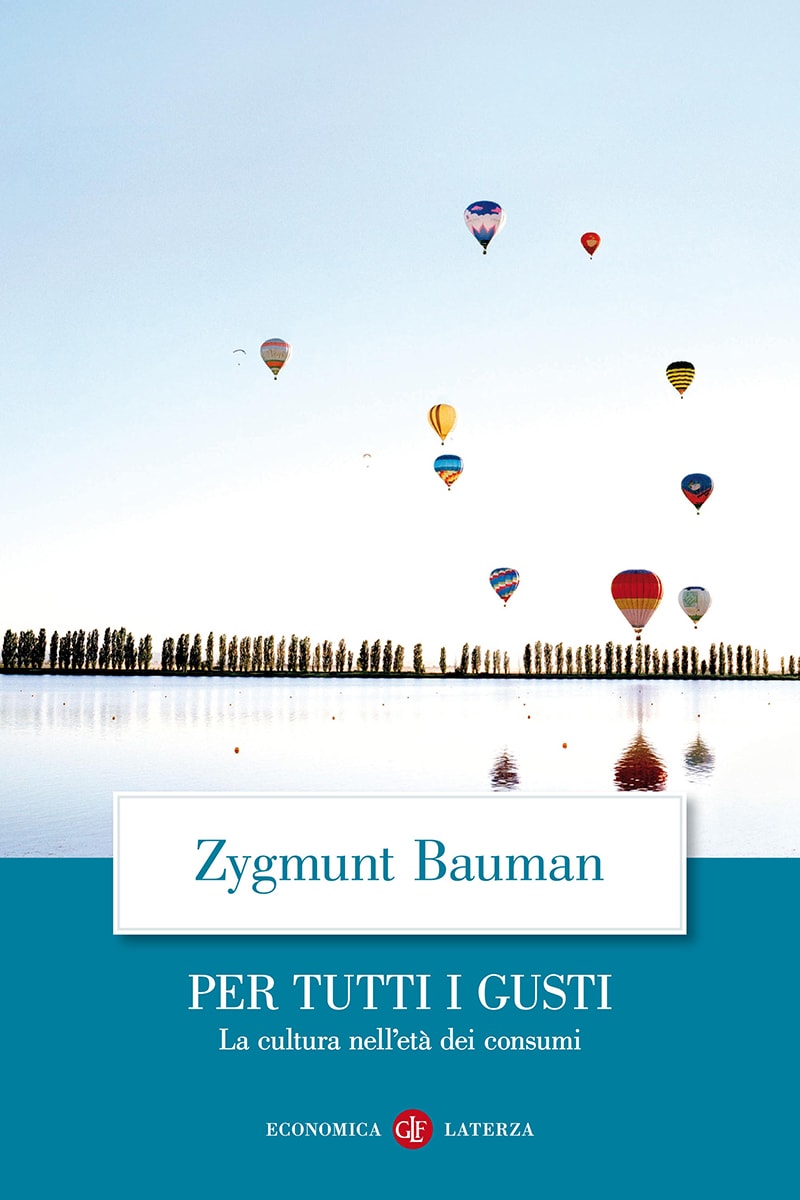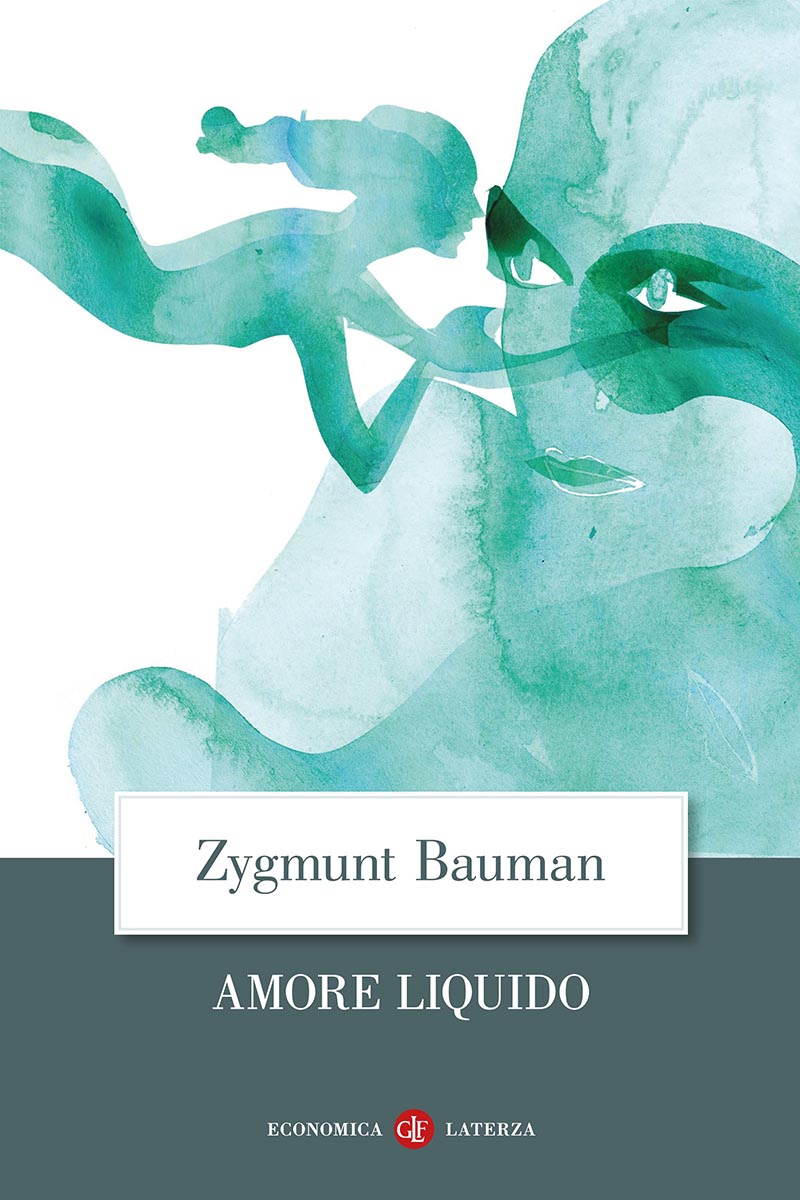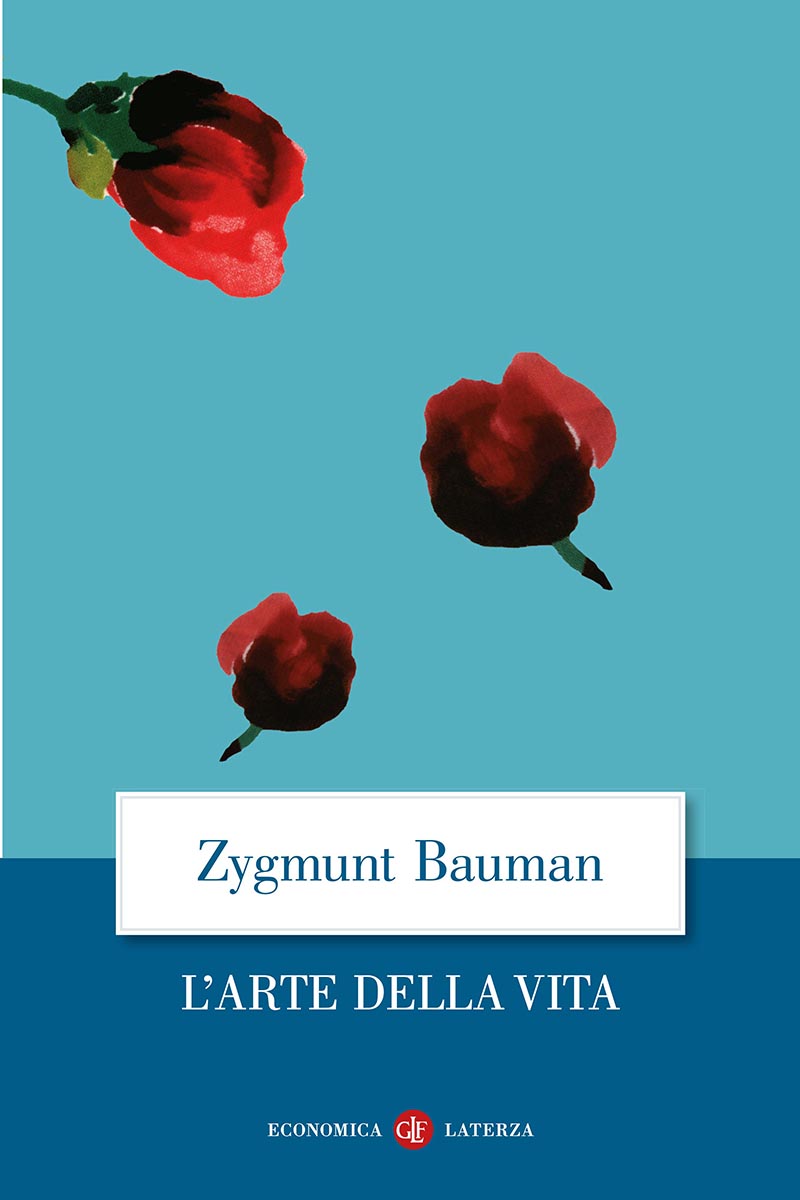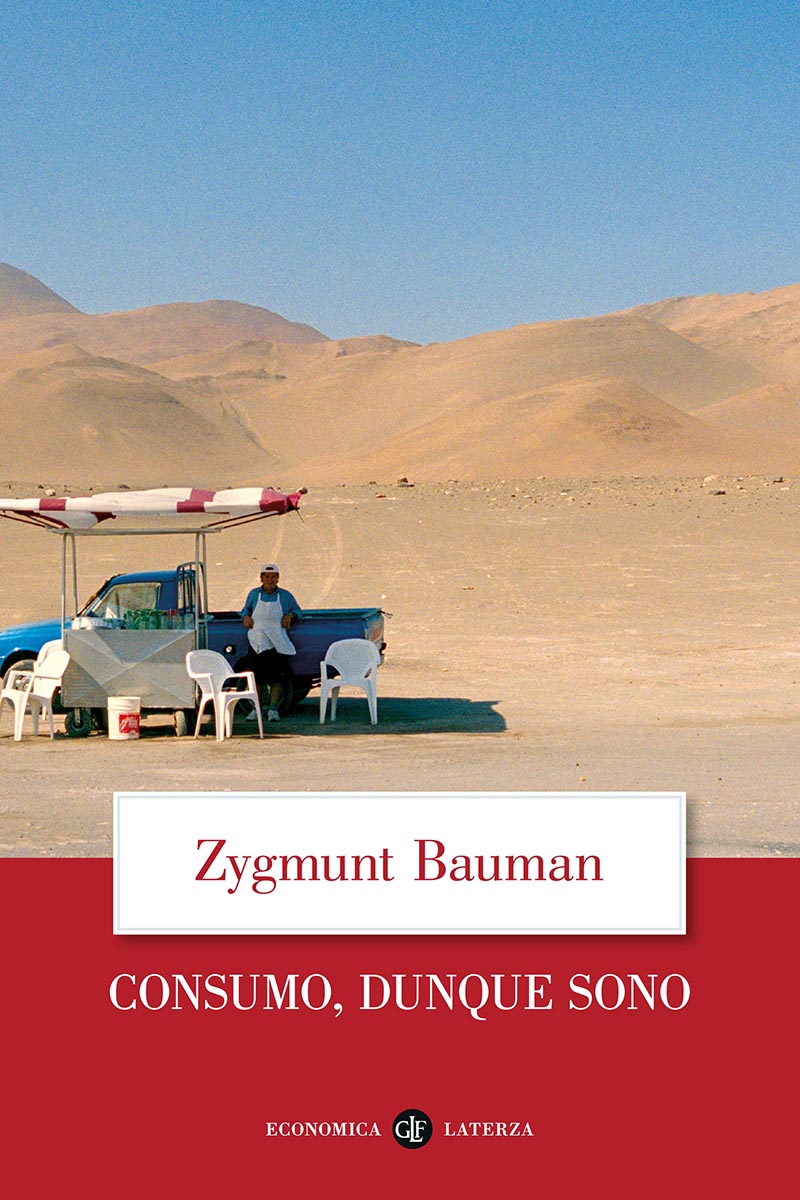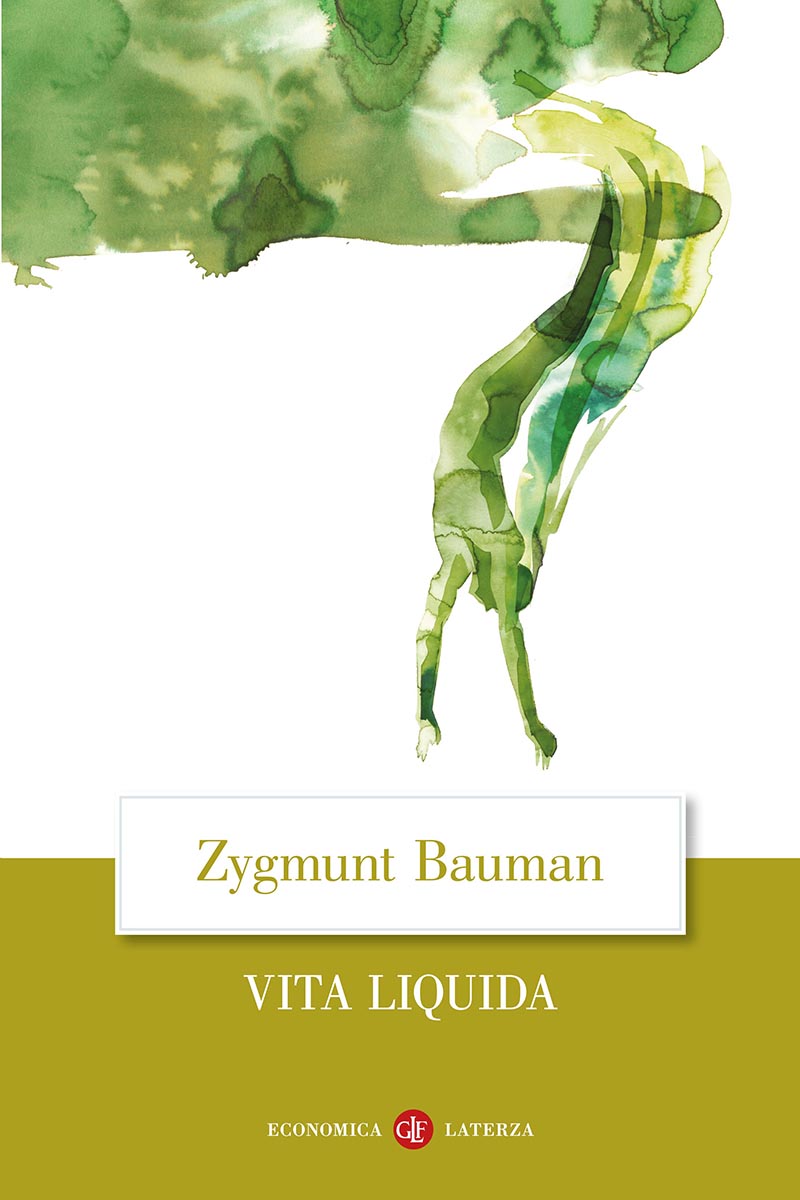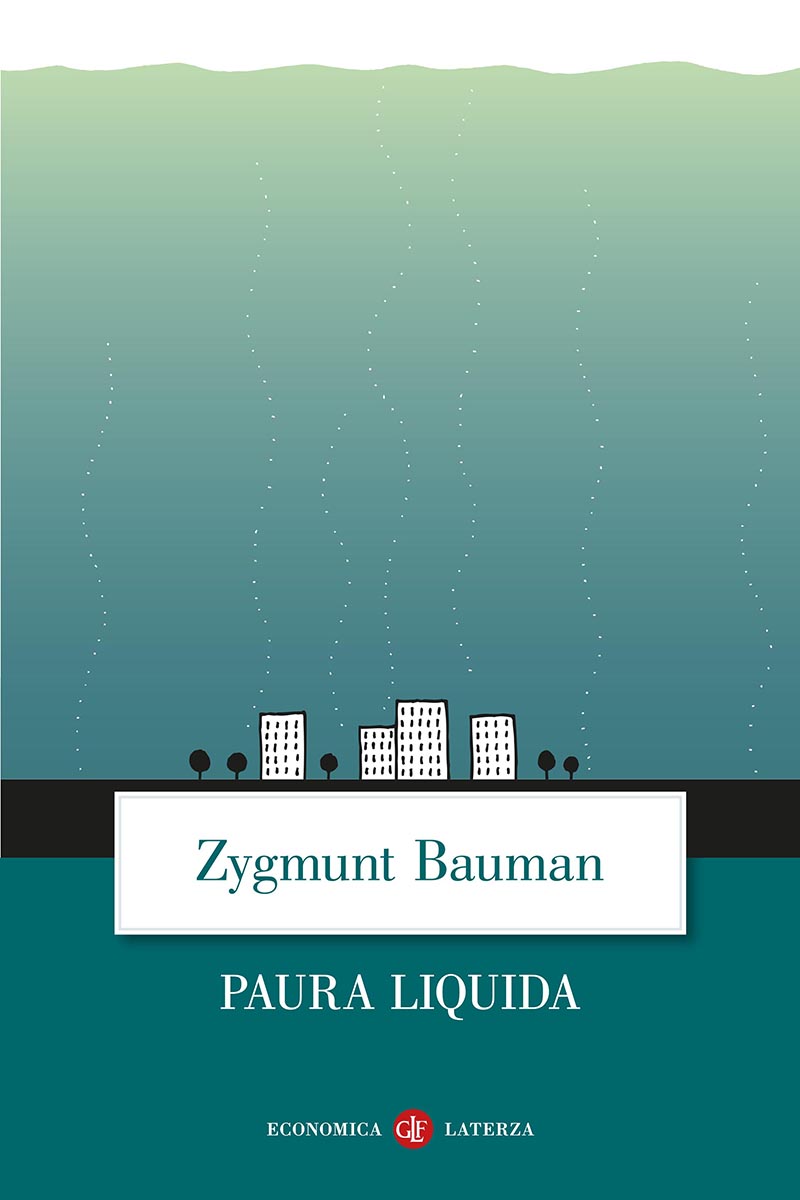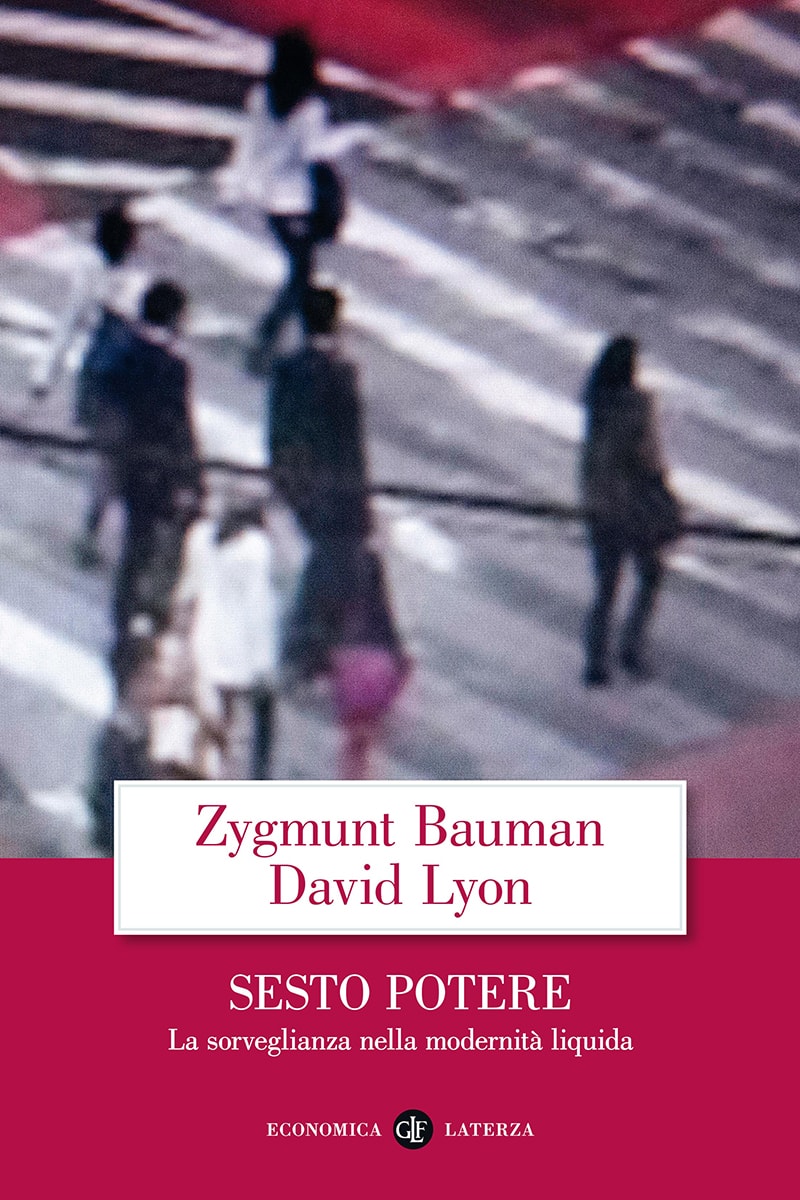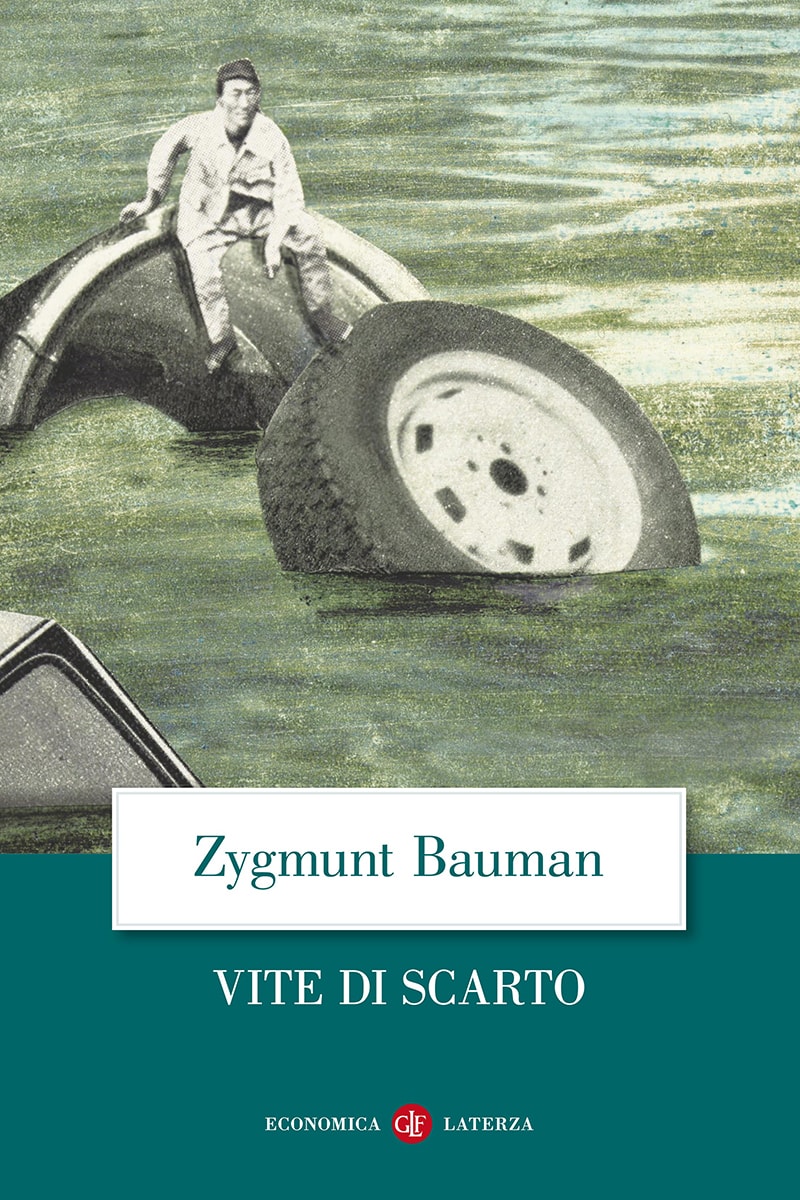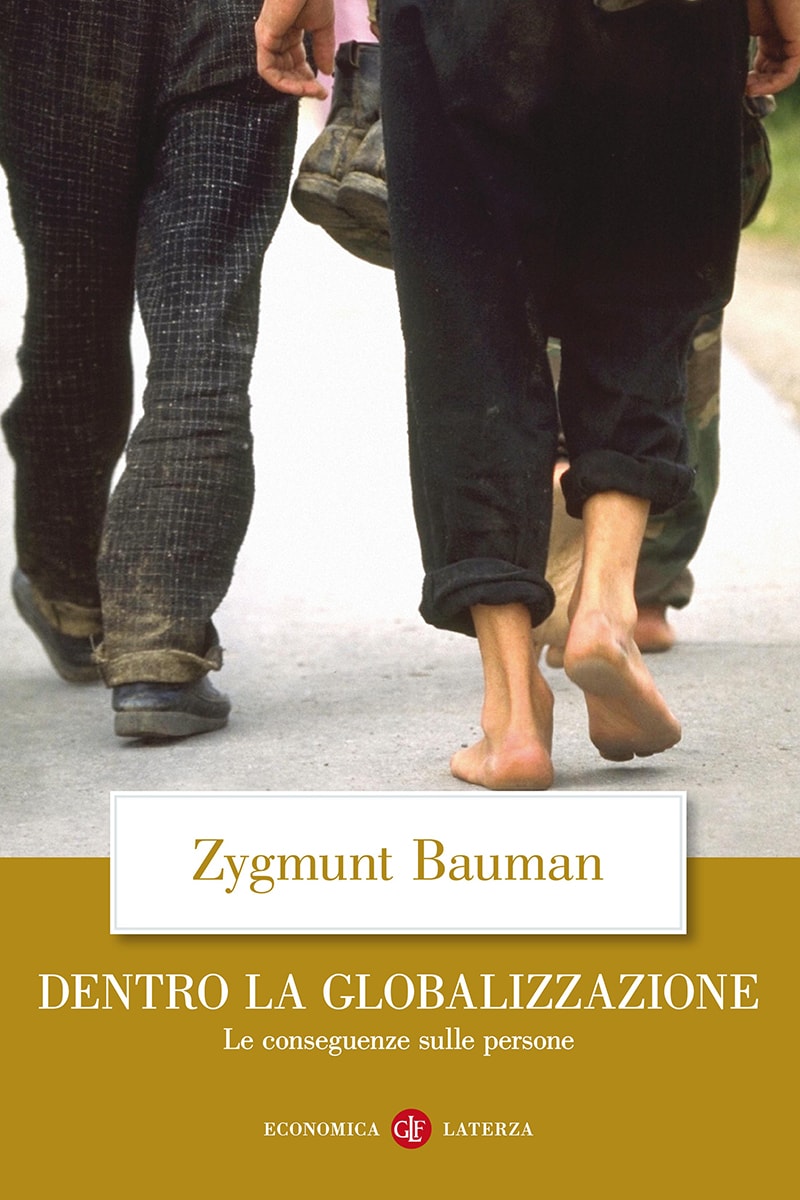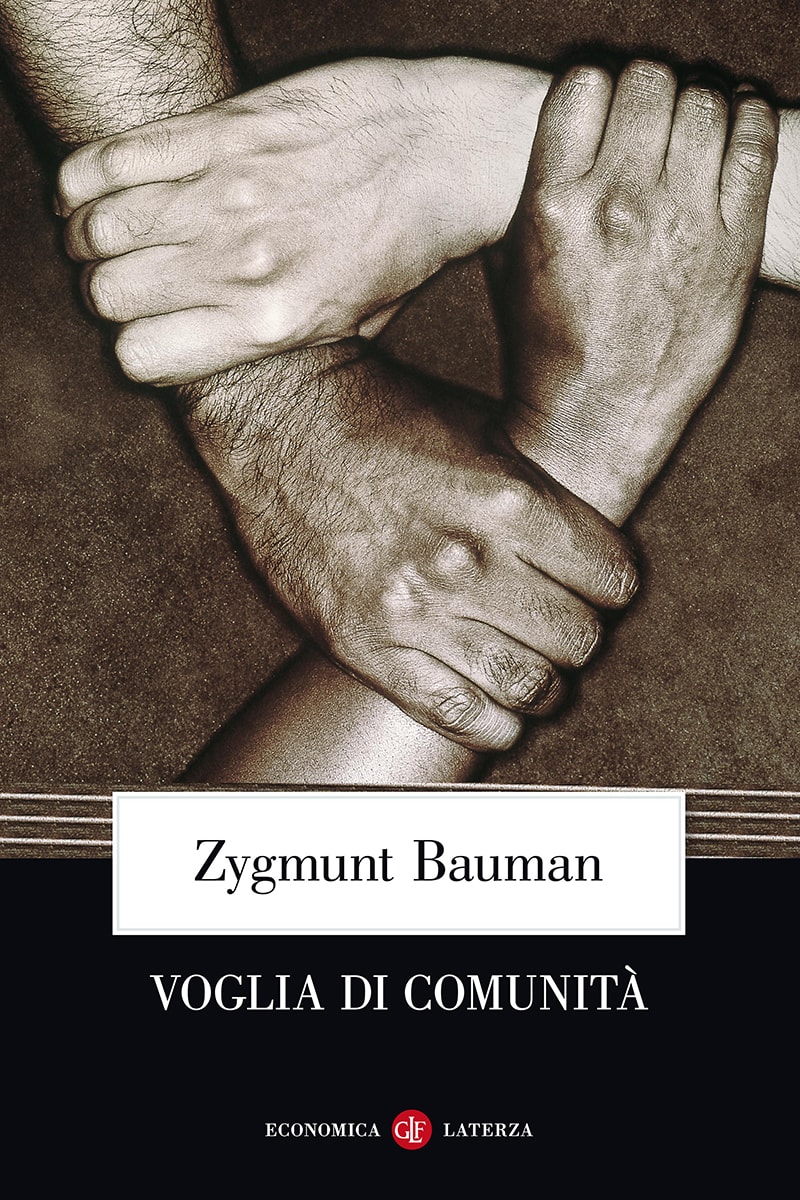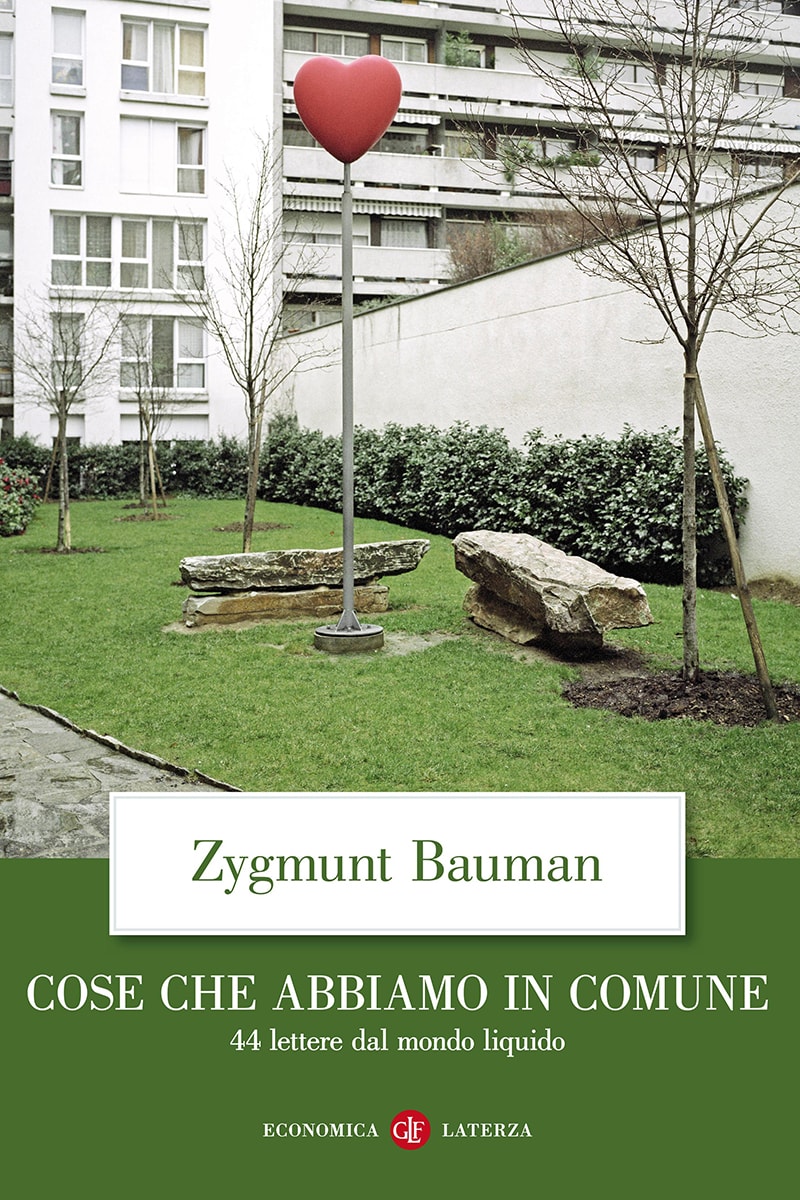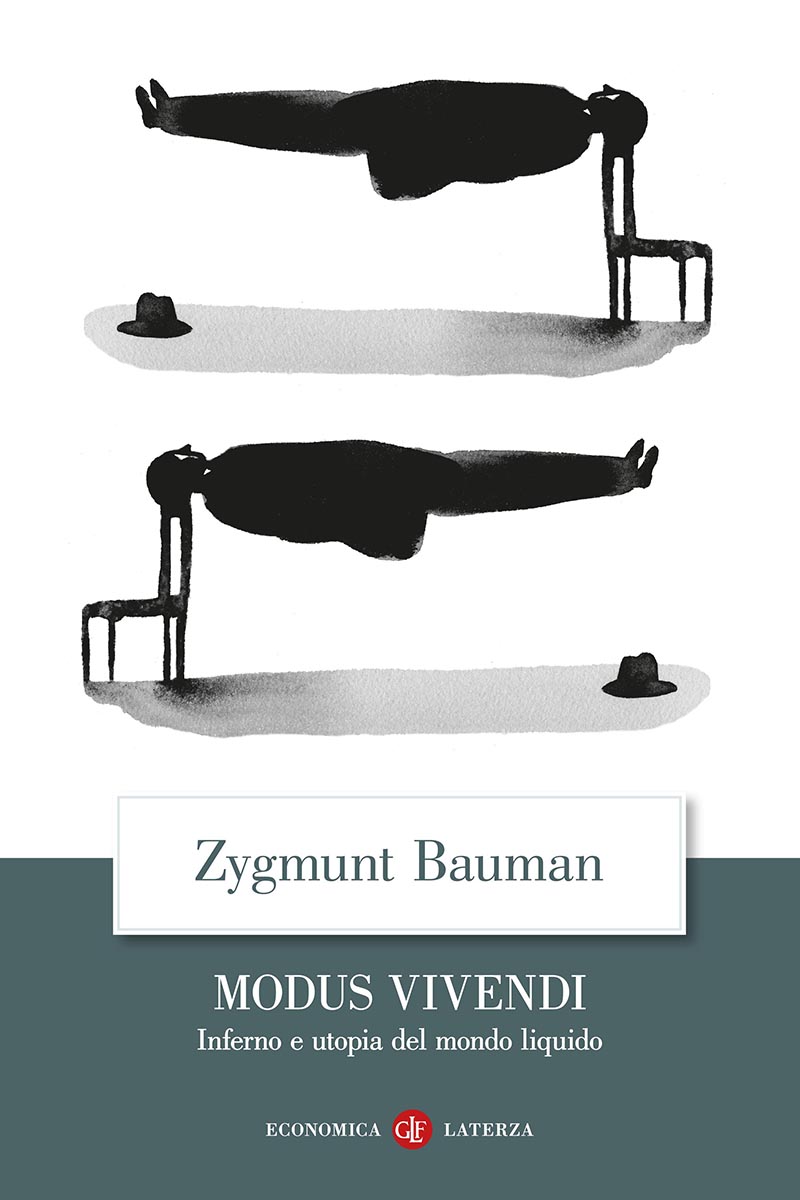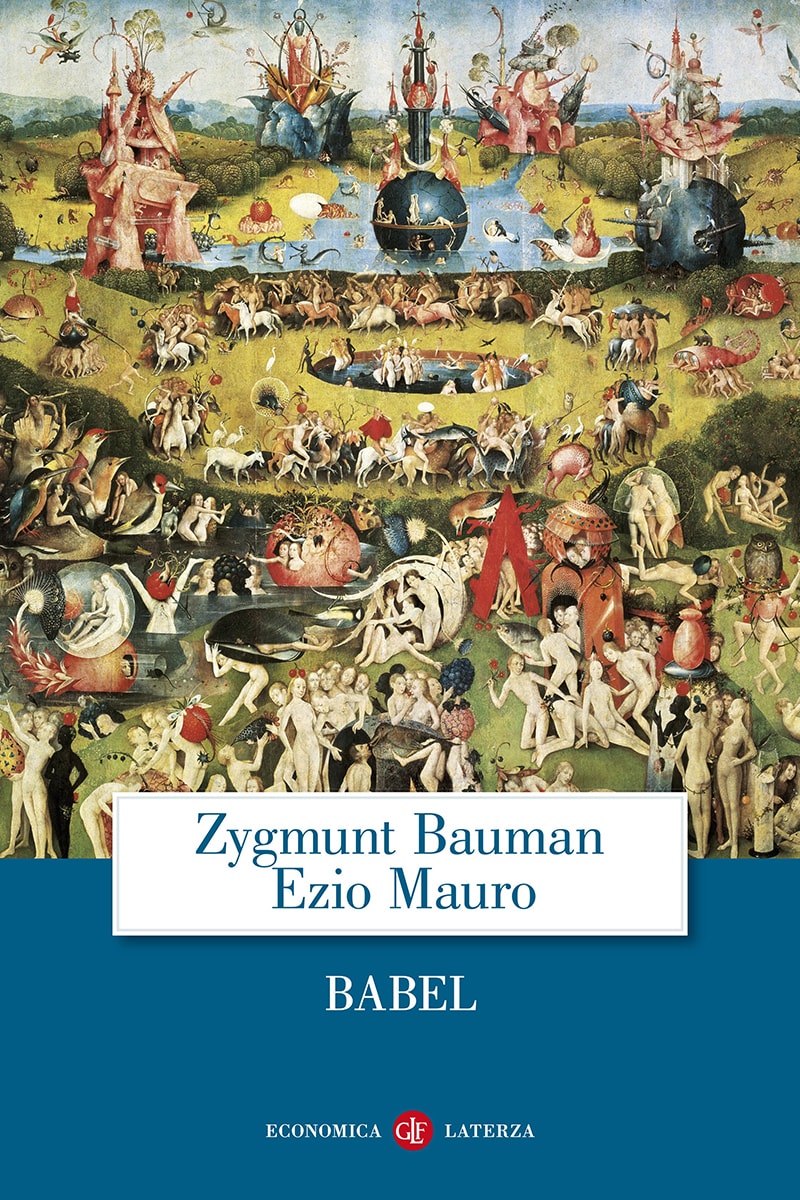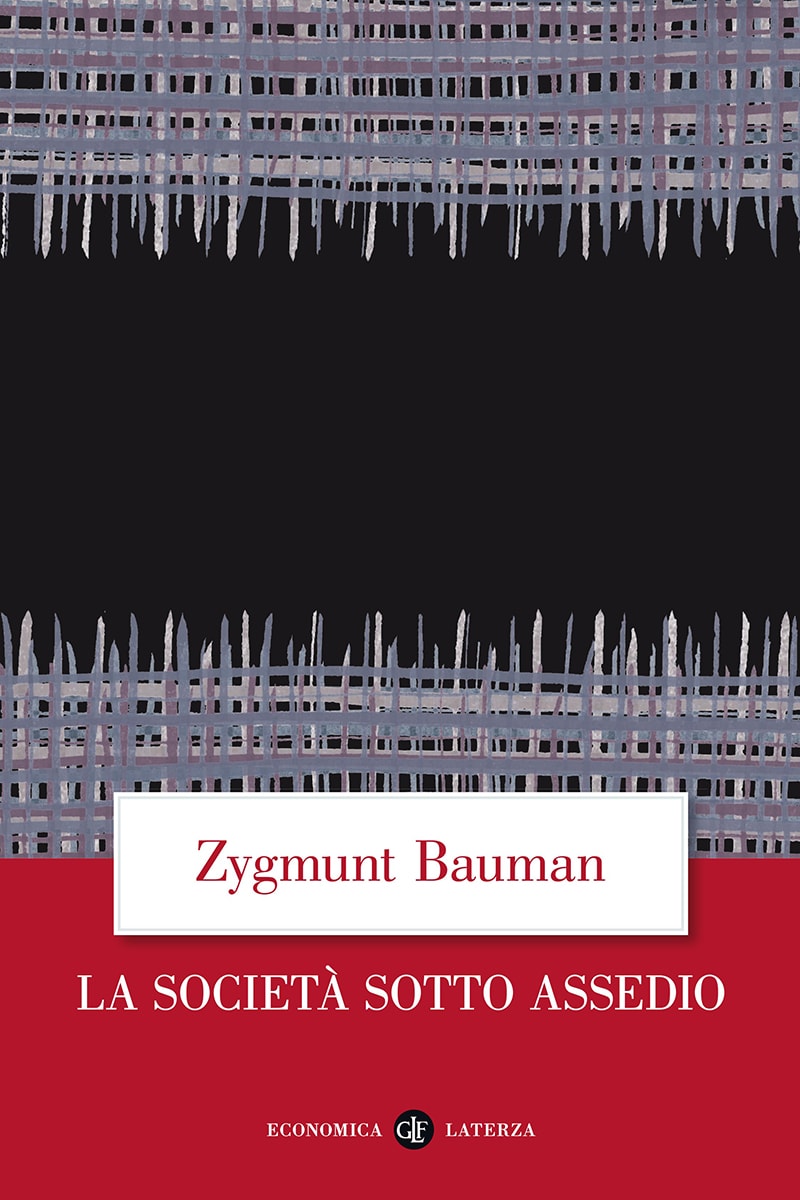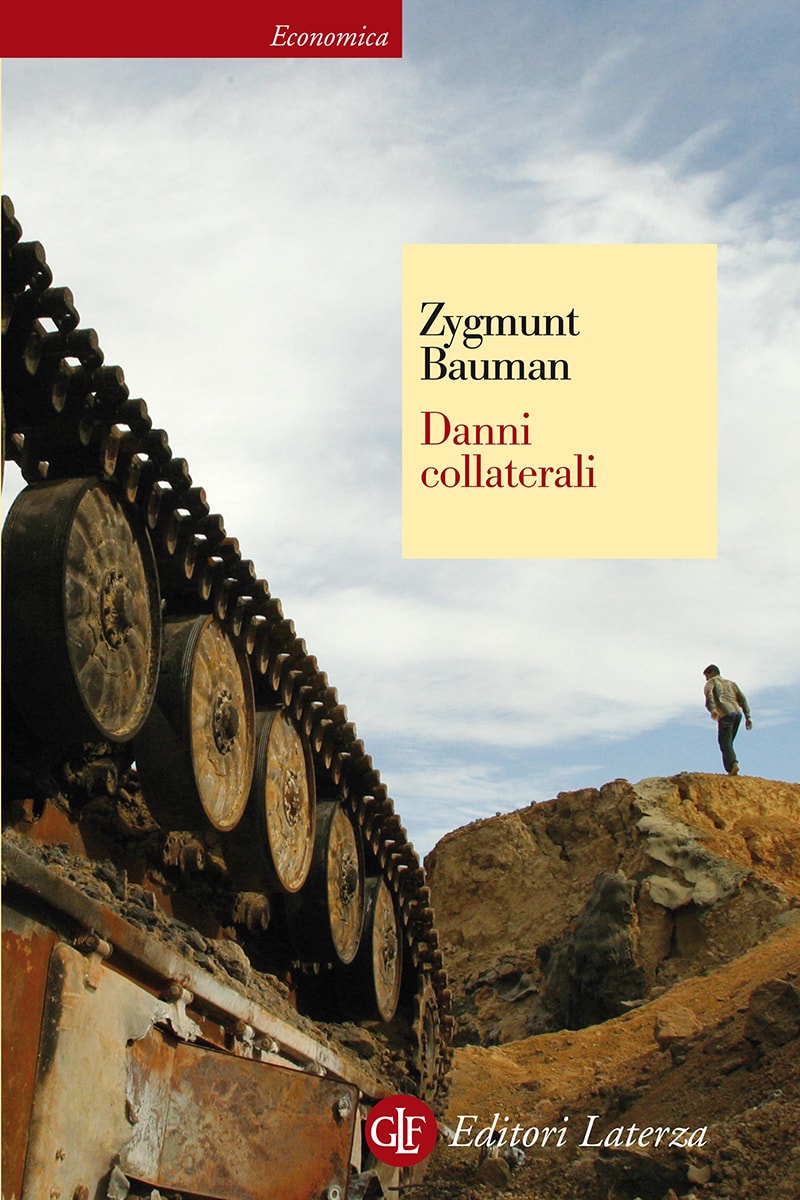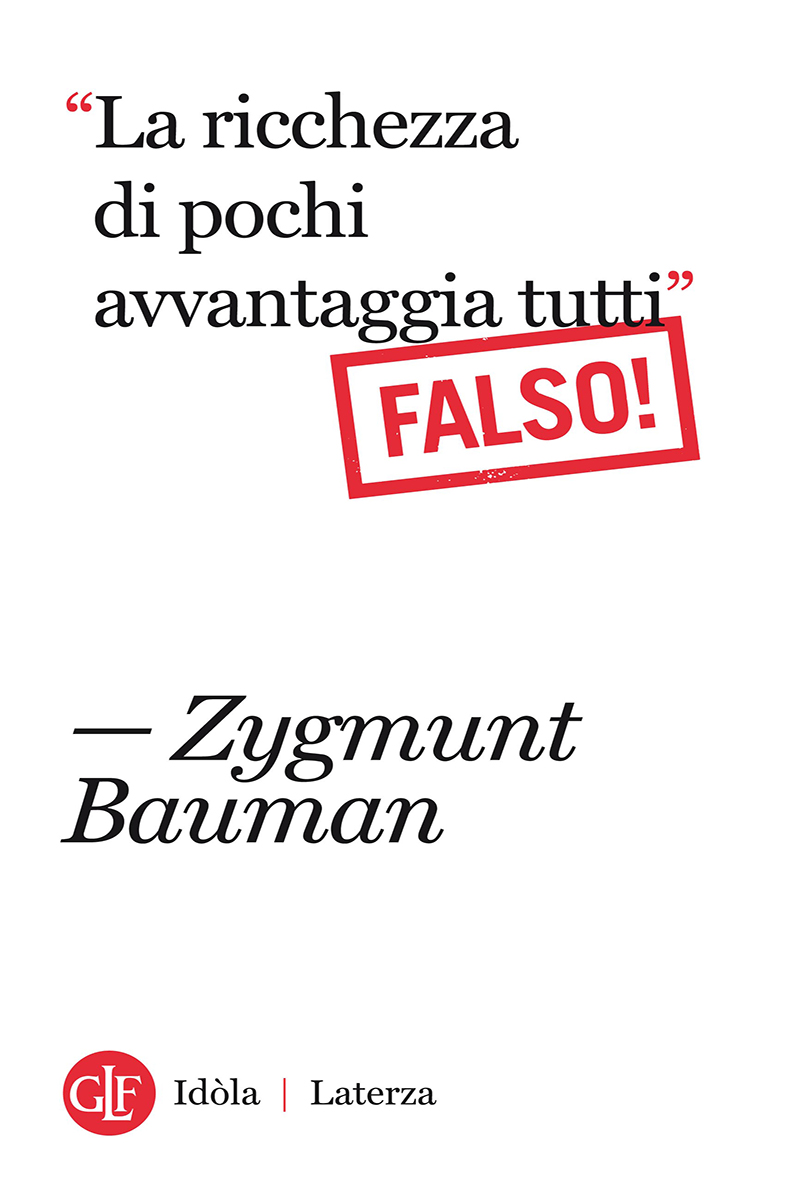Il disagio della postmodernità
Non esistono guadagni senza perdite, e il sogno di una felicità per il guadagno, depurata del dispiacere per la perdita, è altrettanto vano della proverbiale speranza di un pranzo gratis. I guadagni e le perdite connessi a ognuno dei vari sistemi di convivenza umana vanno accuratamente conteggiati, per tentare di pareggiarli il più felicemente possibile. Ma non è mai esistito, e mai esisterà, un bilancio dove ci sia la voce dell’‘avere’, ma non quella del ‘dare’. La gioia della vita civile si ottiene solo insieme alla sofferenza, la soddisfazione va sottobraccio al disagio e l’obbedienza alla ribellione. La civiltà, quest’ordine artificiale imposto sul disordine naturale dell’umanità, è un baratto, un compromesso sempre rimesso in questione e volta a volta rinegoziato. Il disagio della postmodernità è uno dei libri fondamentali di Bauman. Una lettura imprescindibile per chiunque voglia capire il suo tempo in tutte le sue implicazioni e le sue contraddizioni.
Rassegna stampa
-
Il disagio della postmodernità
Gli individui e il confino tra la pulsione e le regole