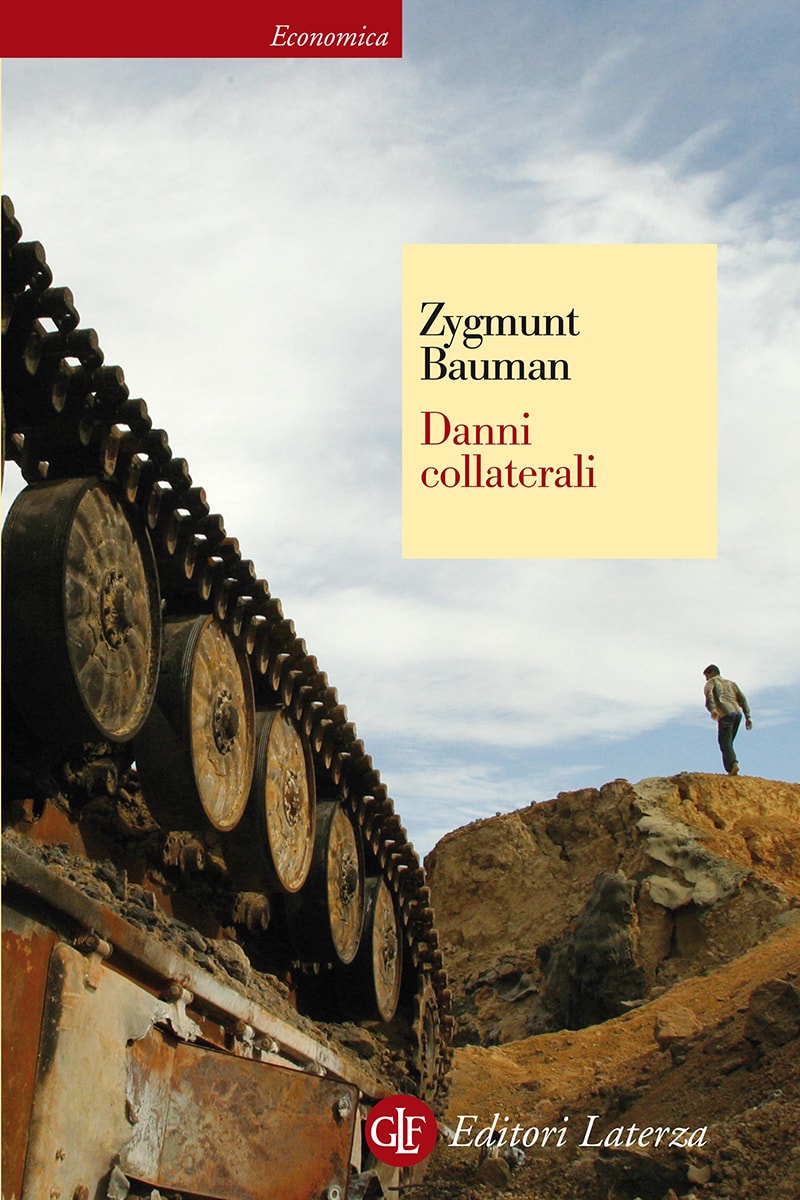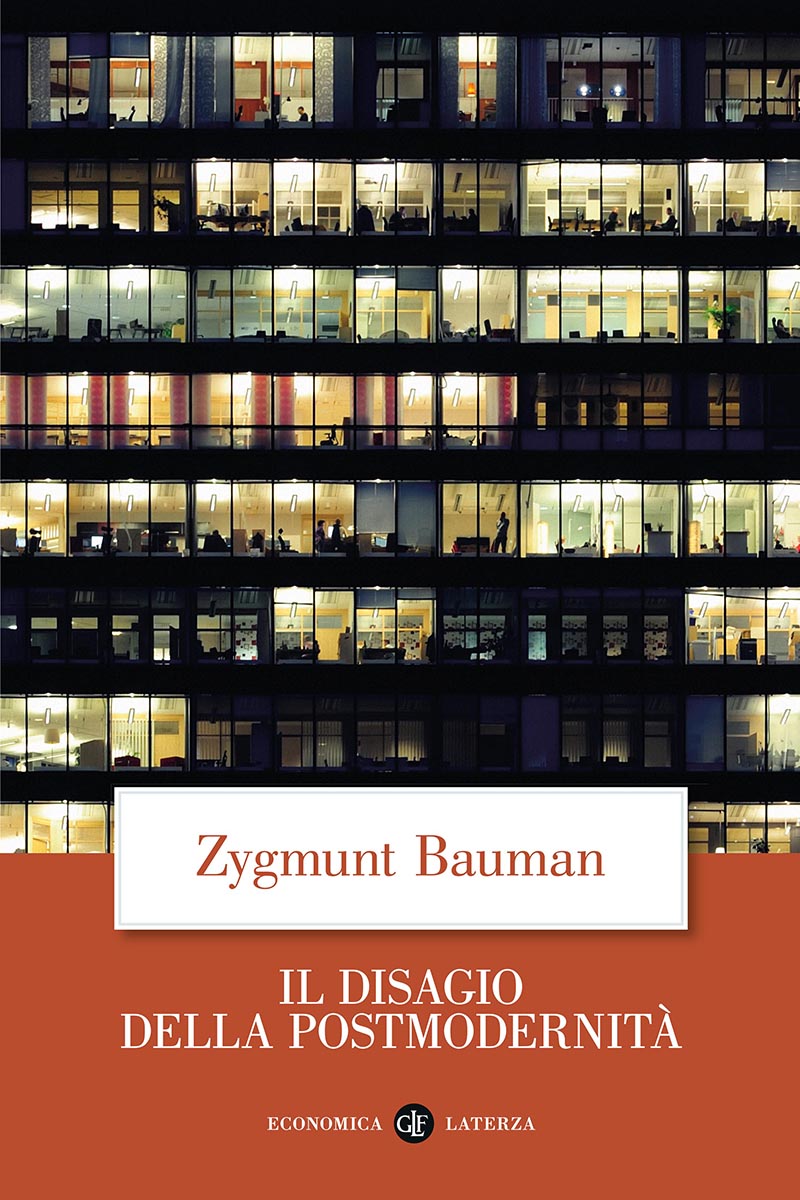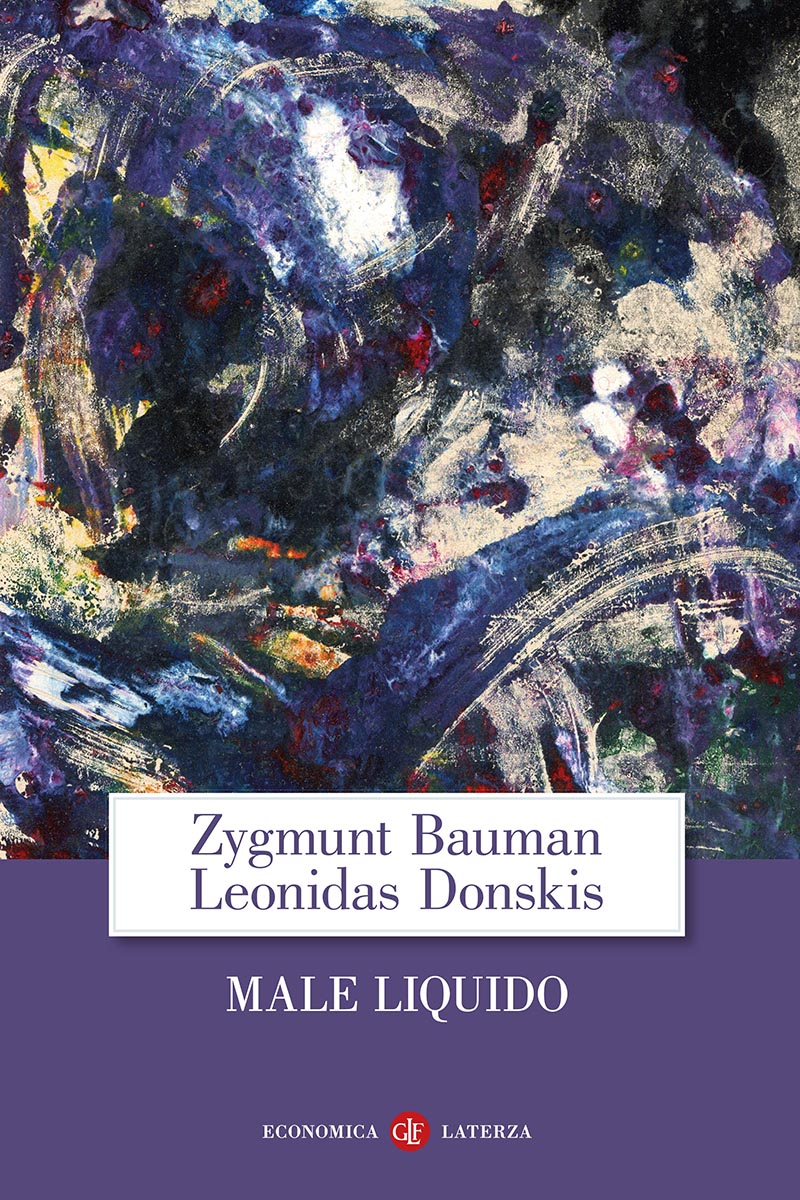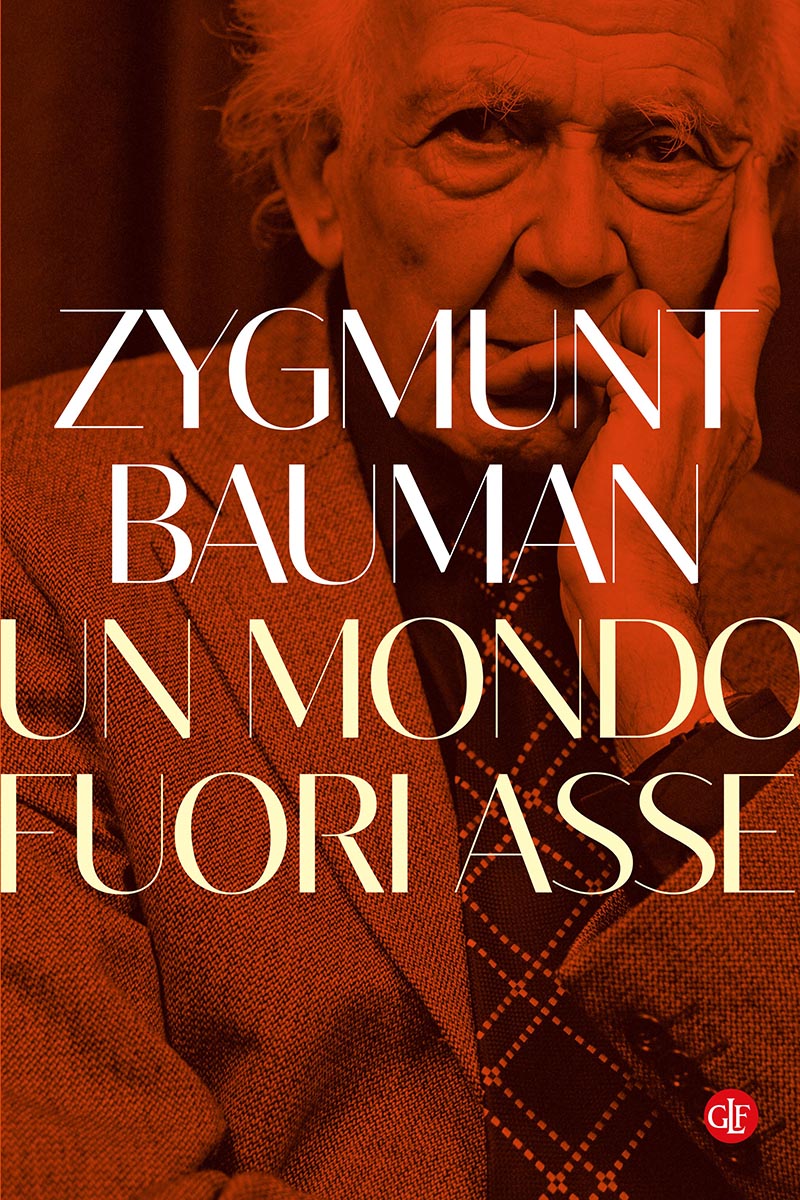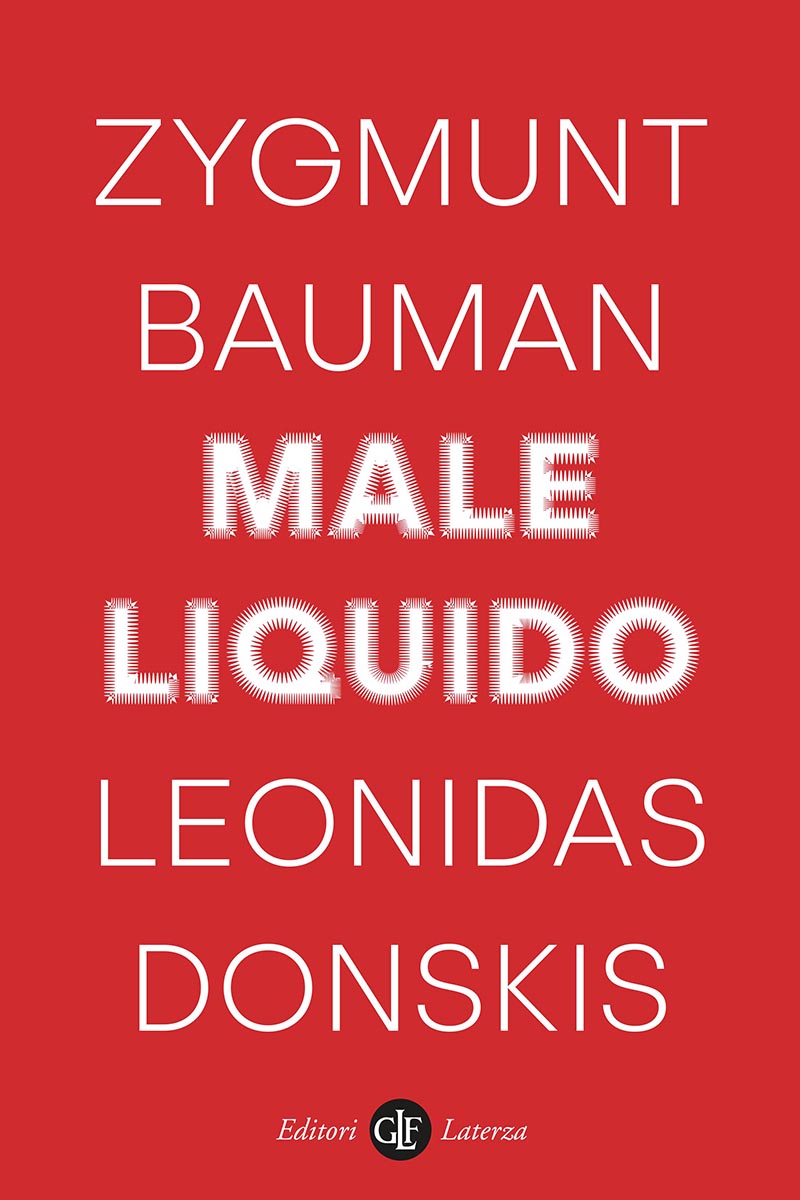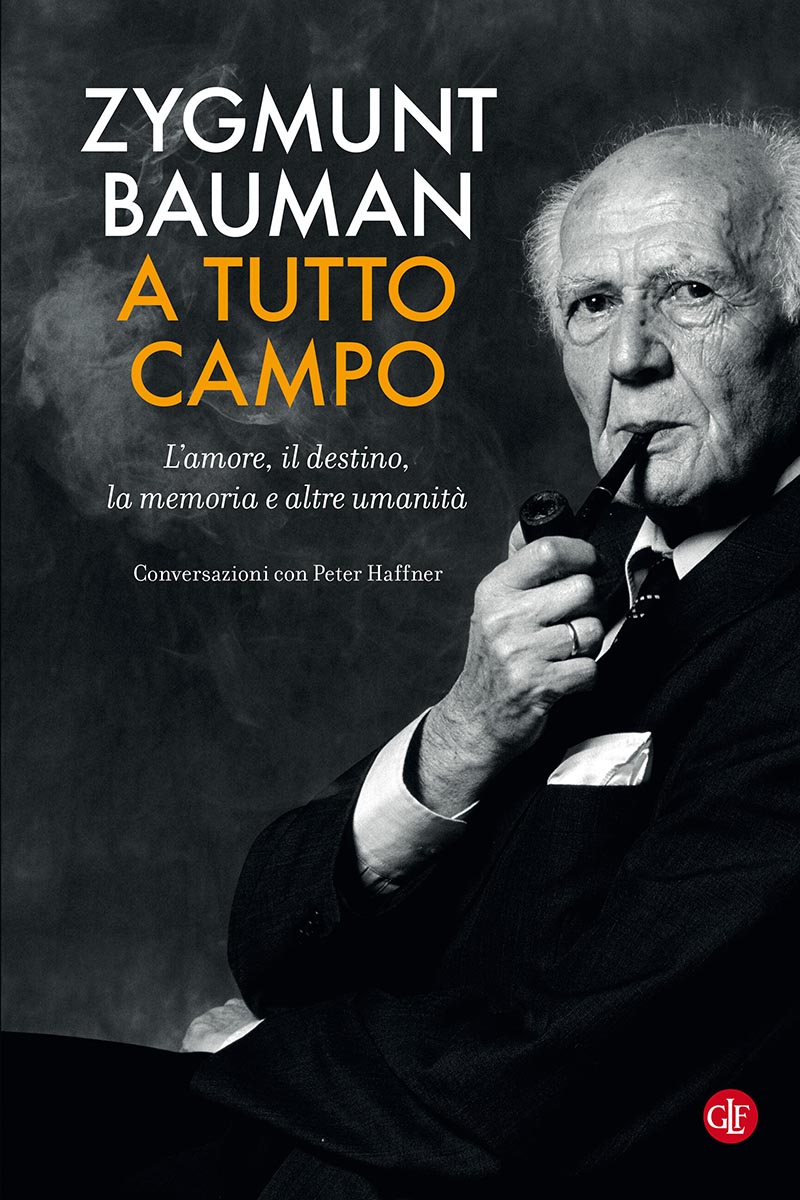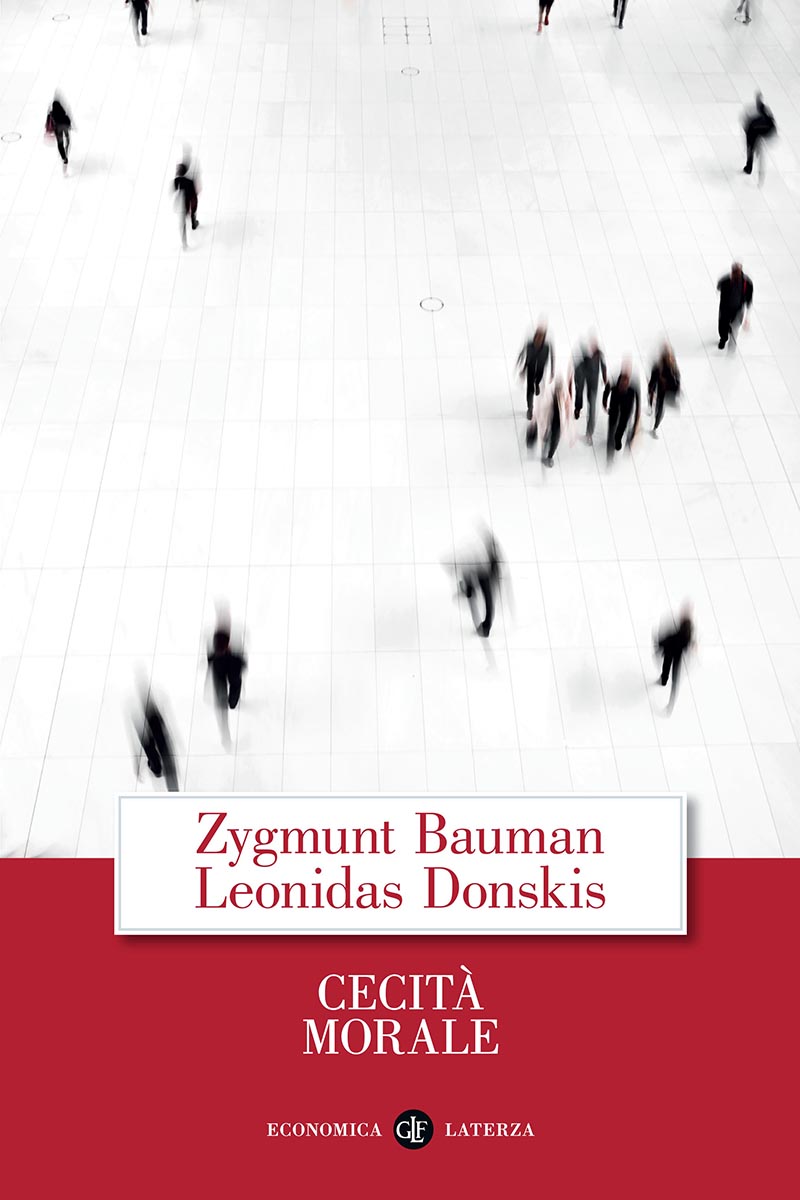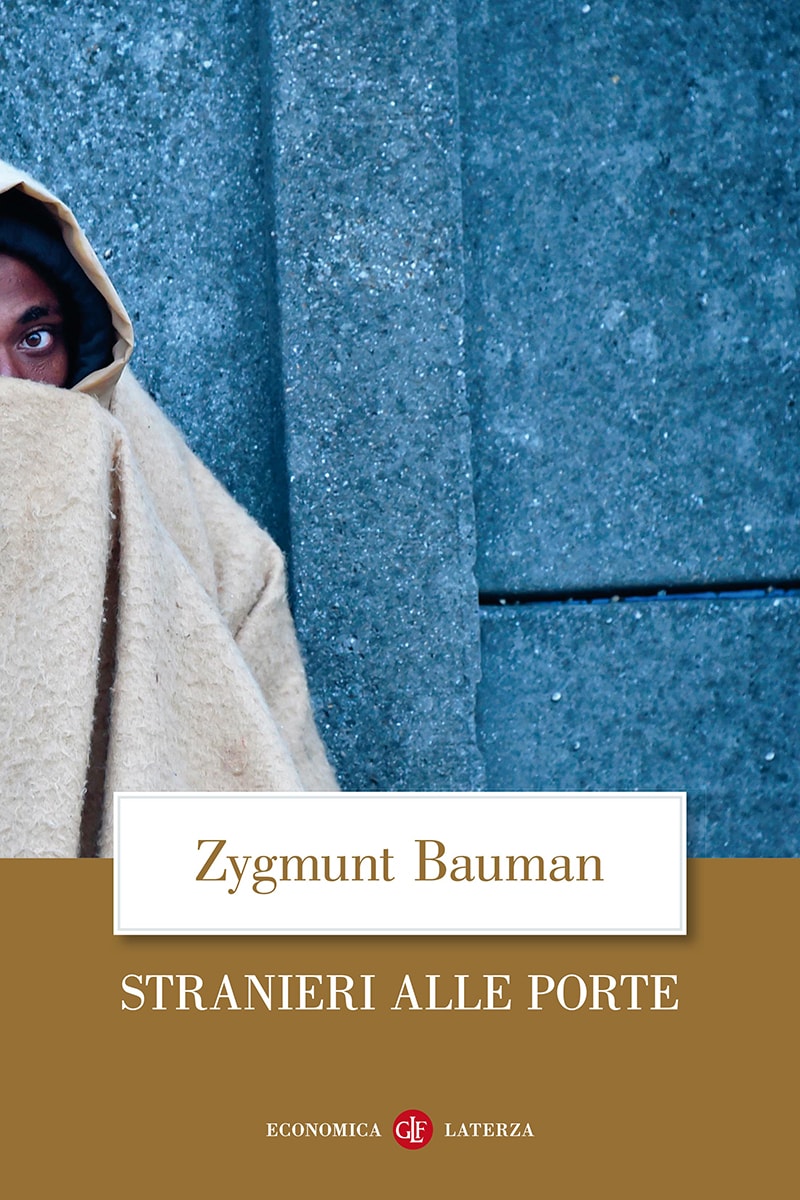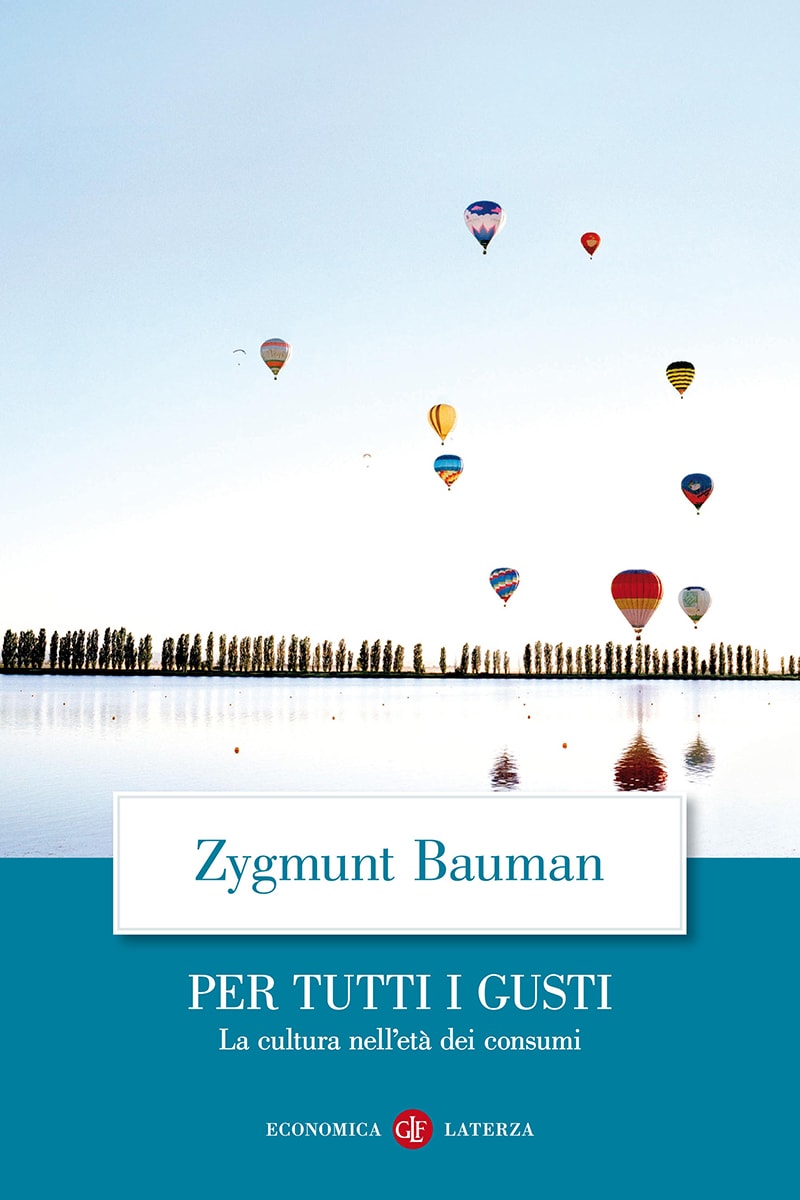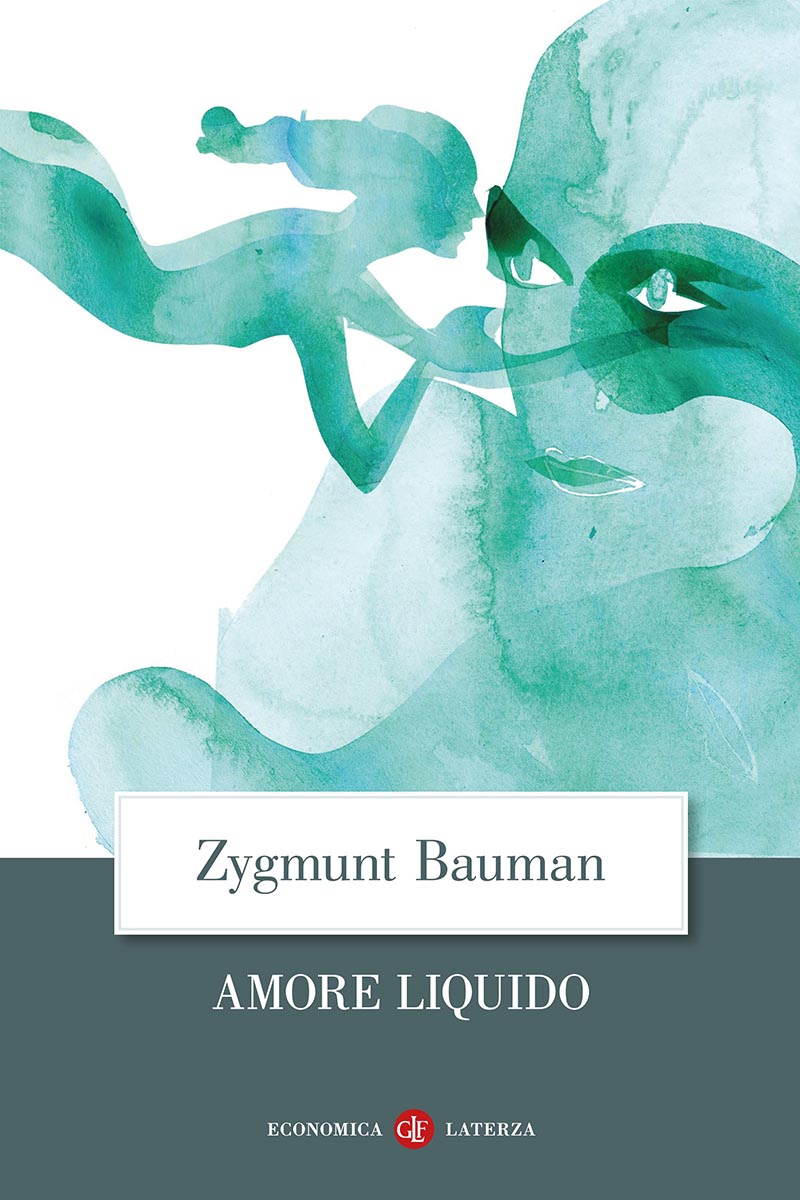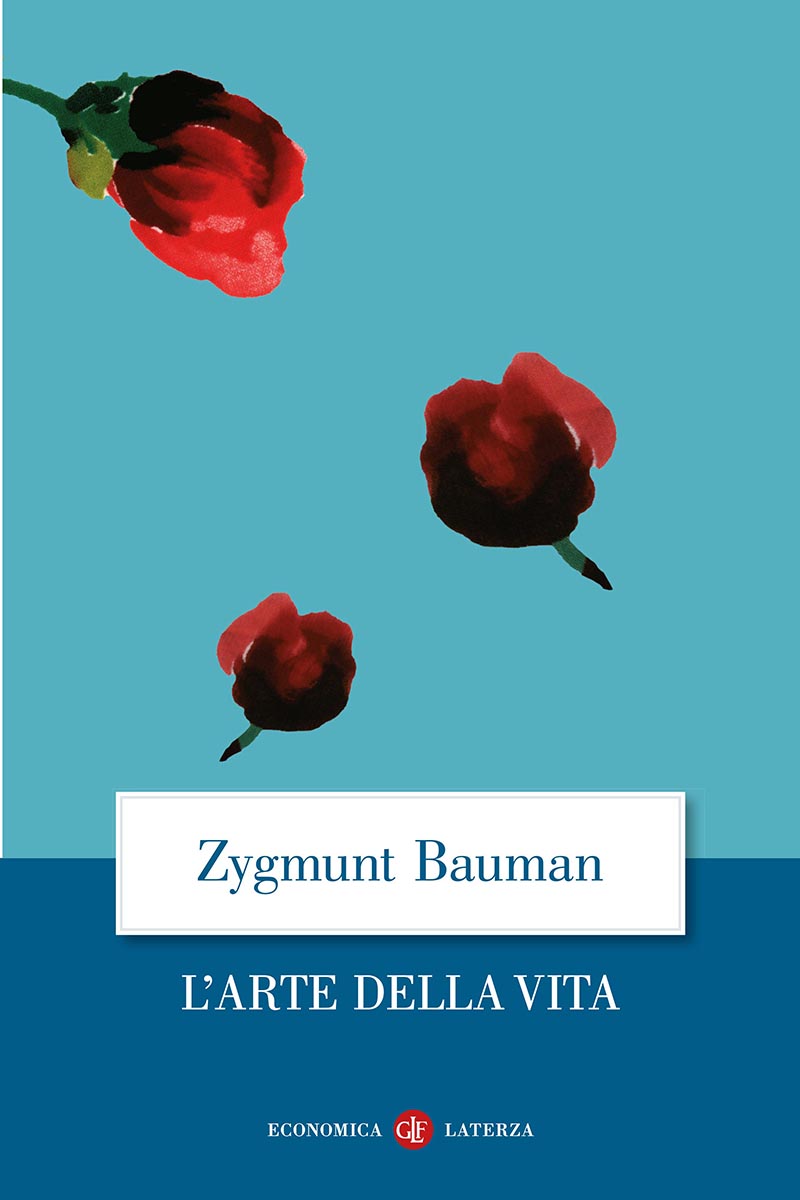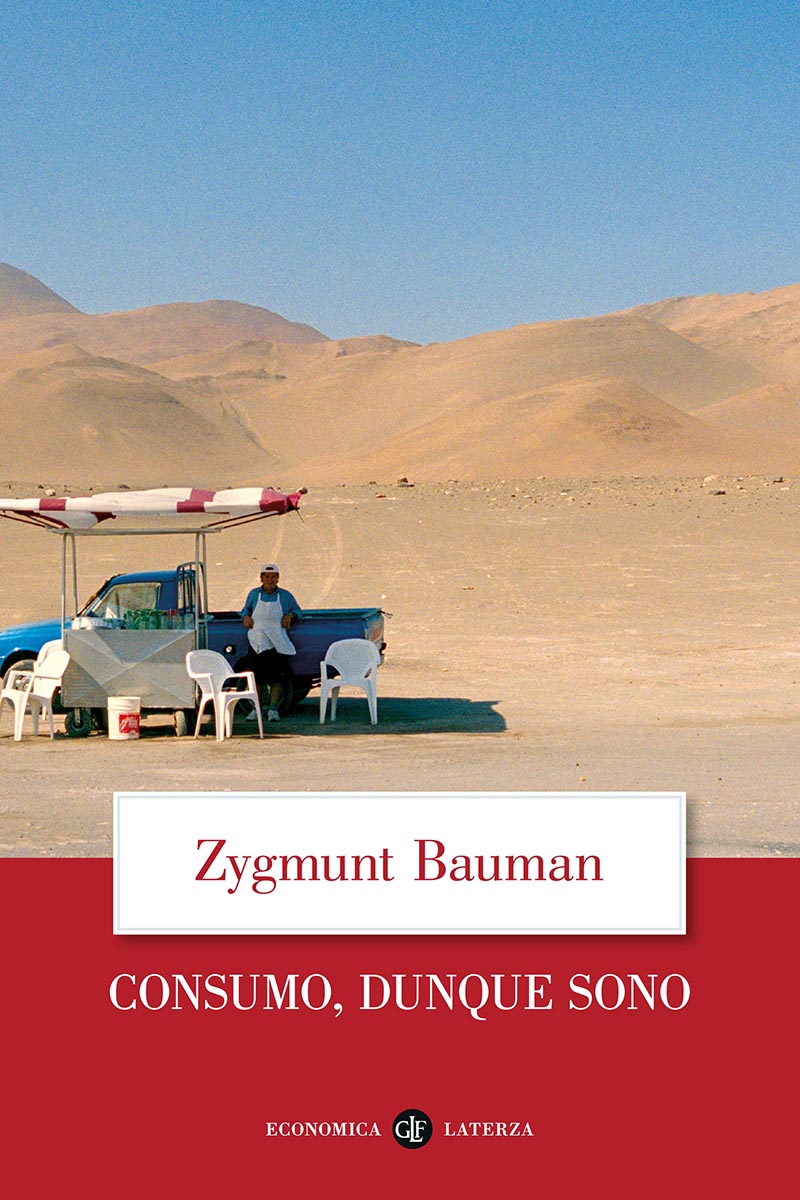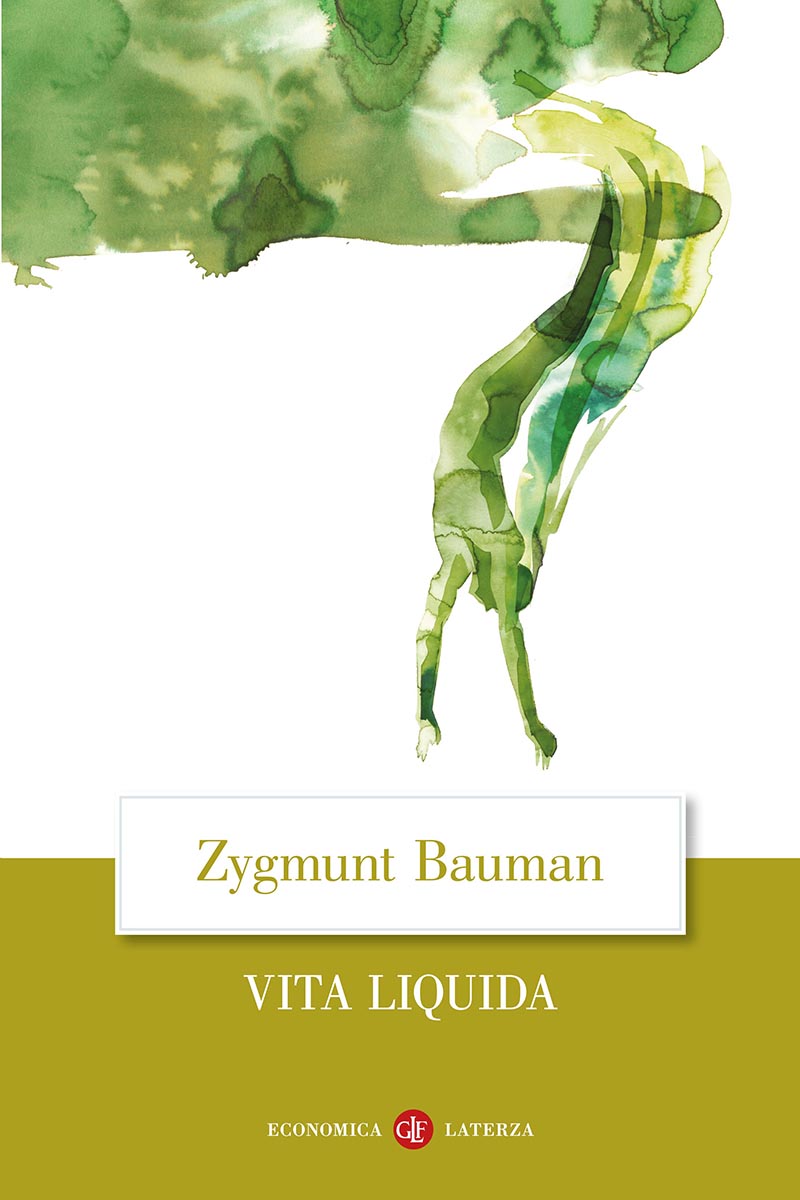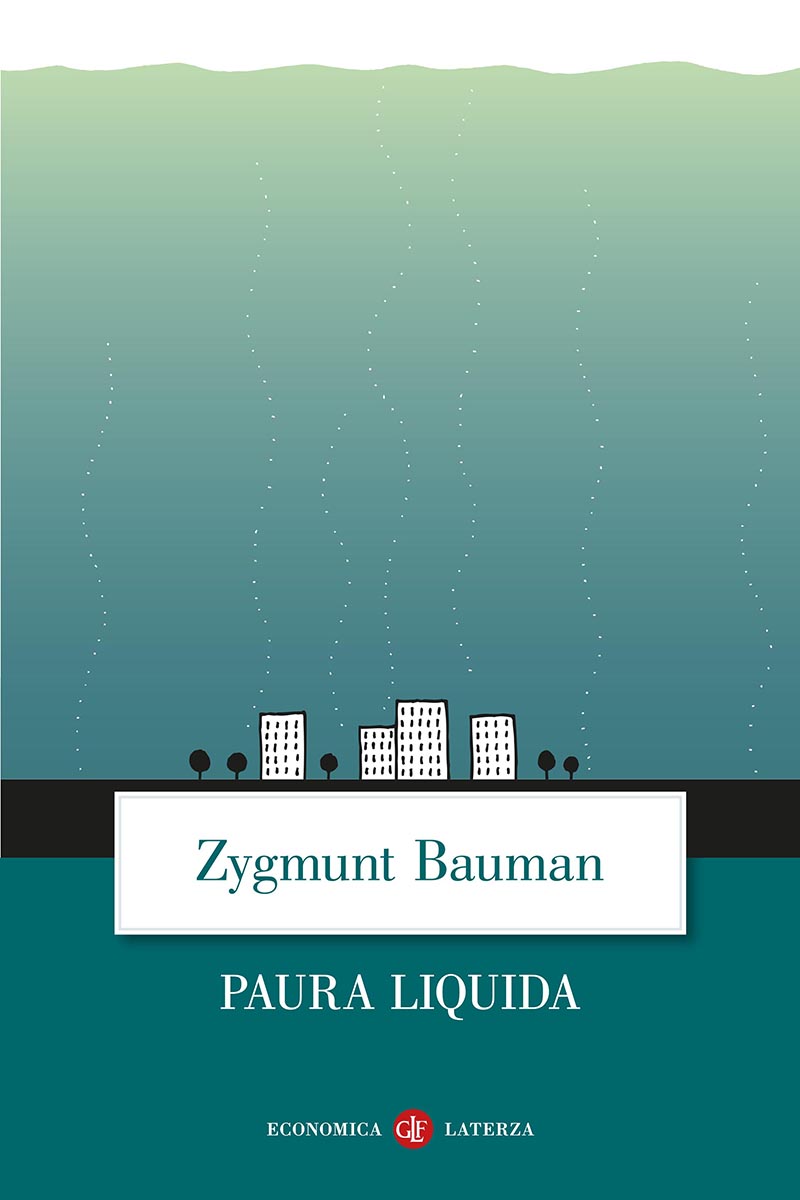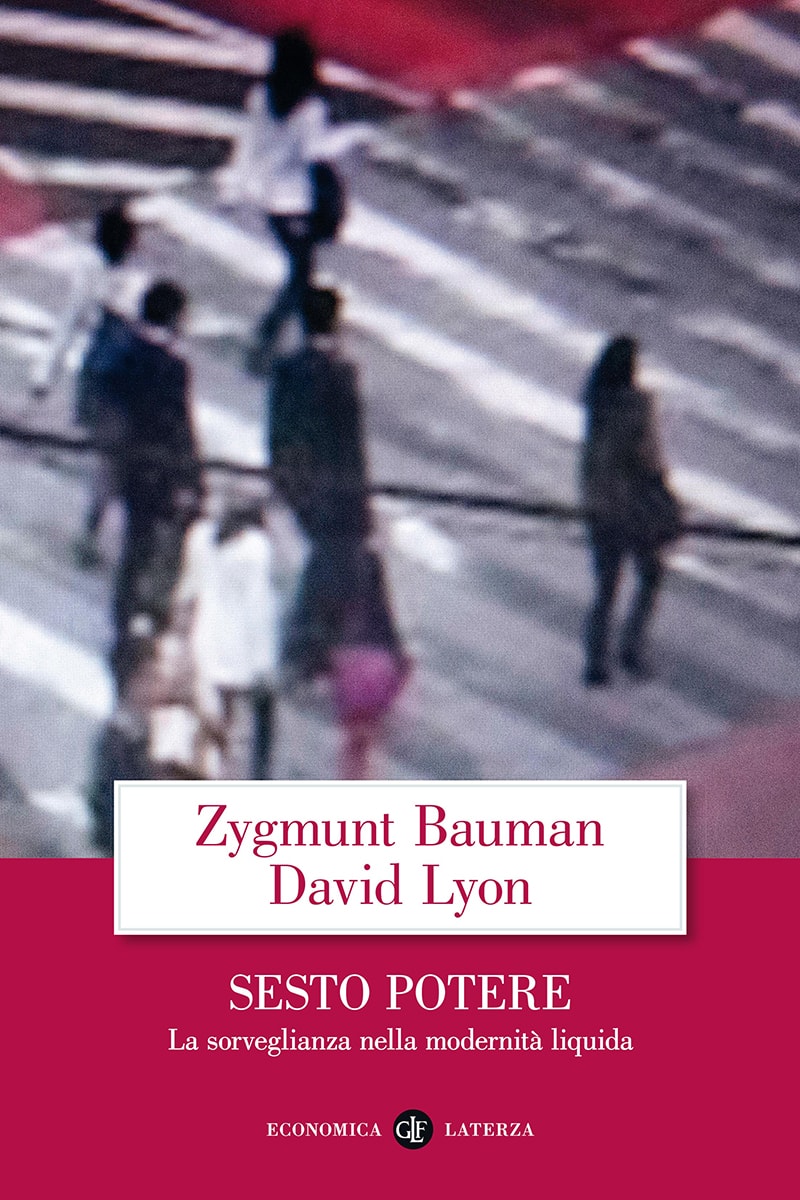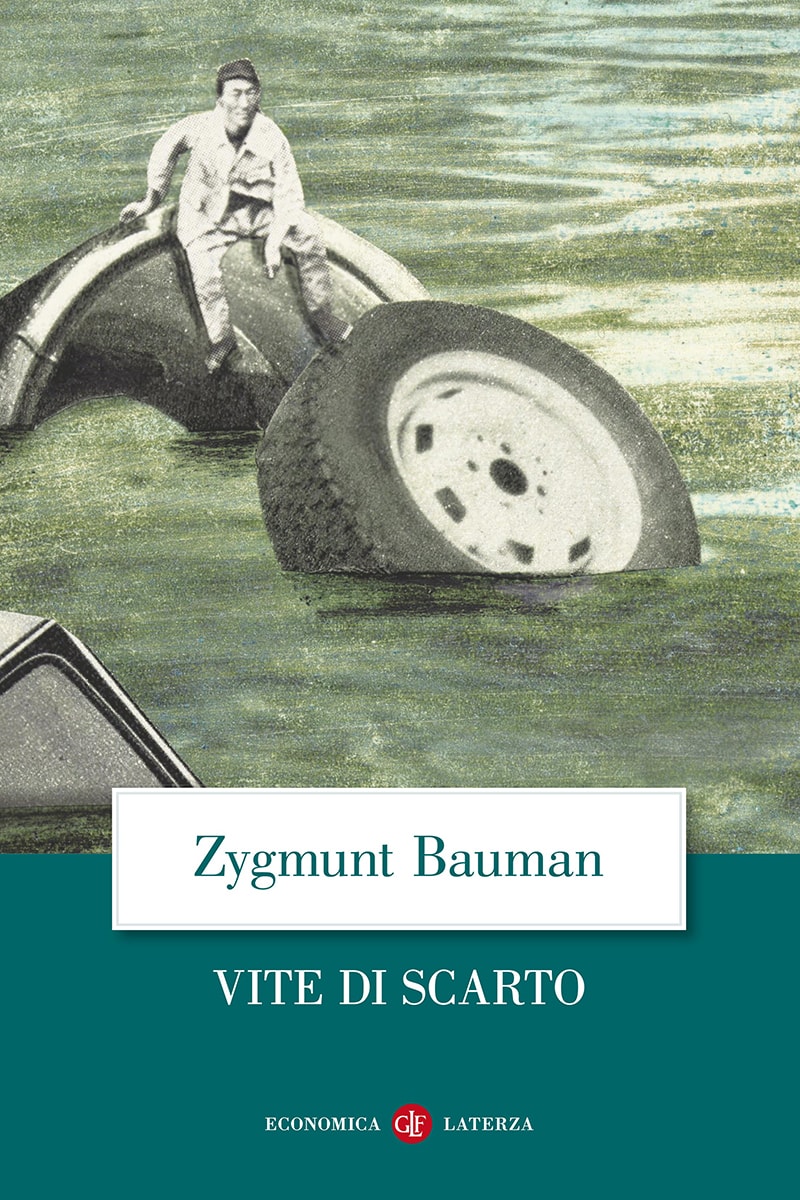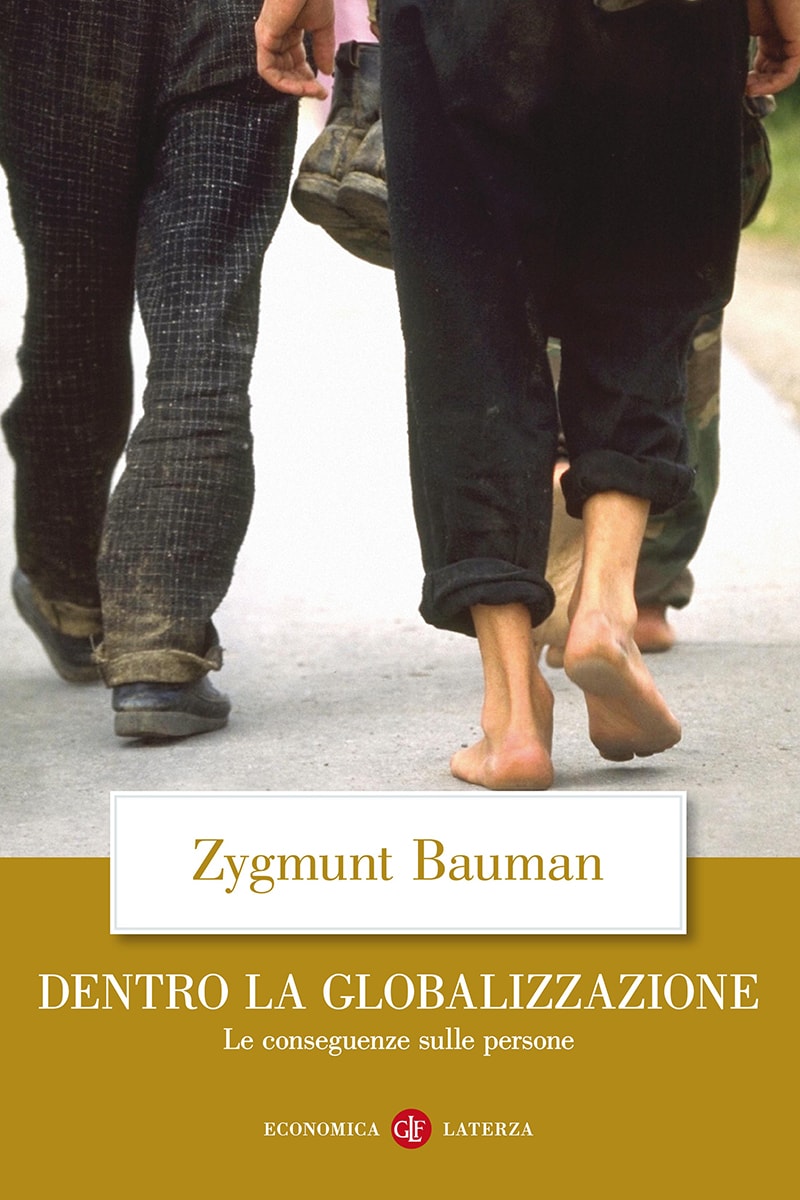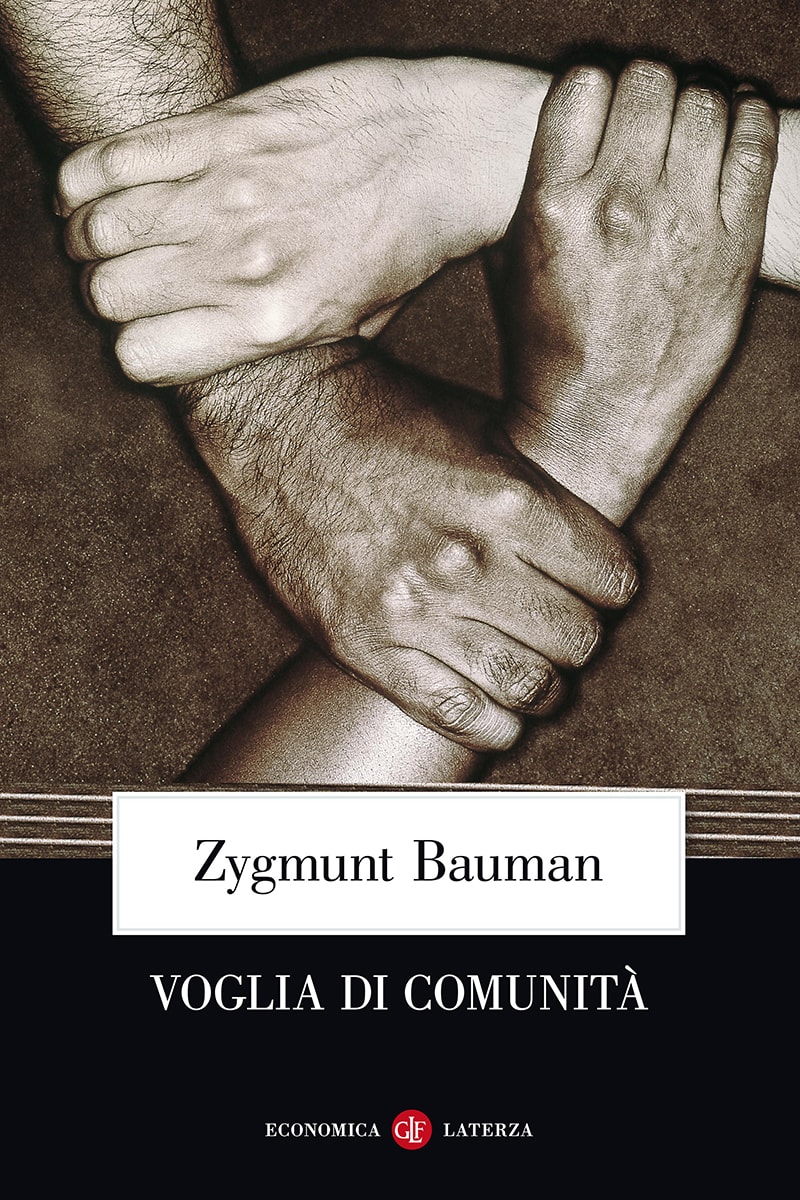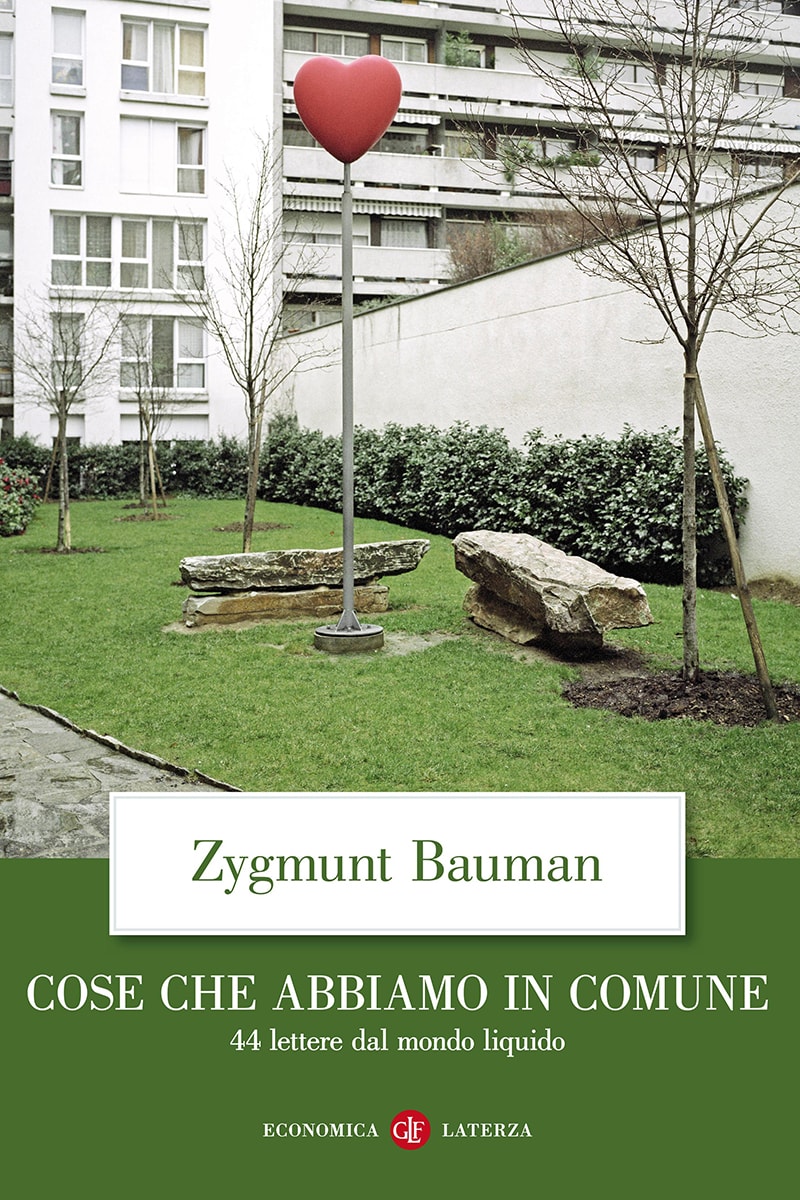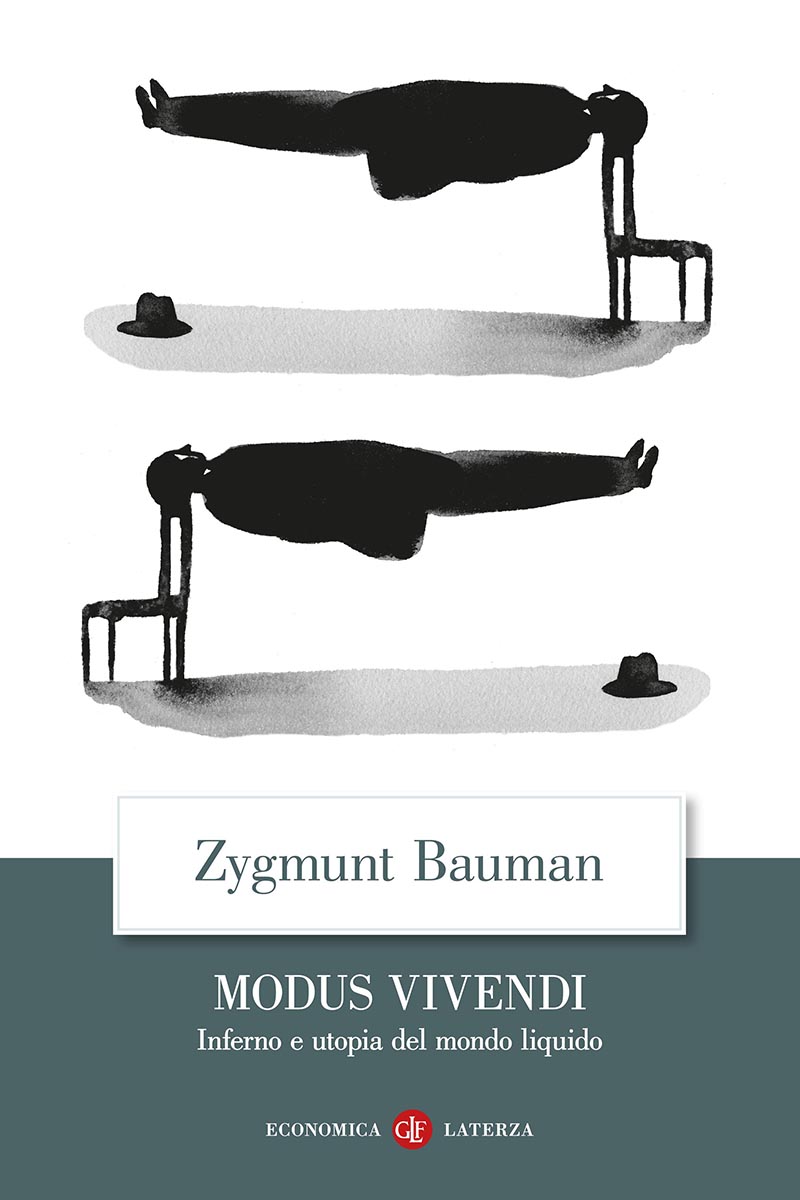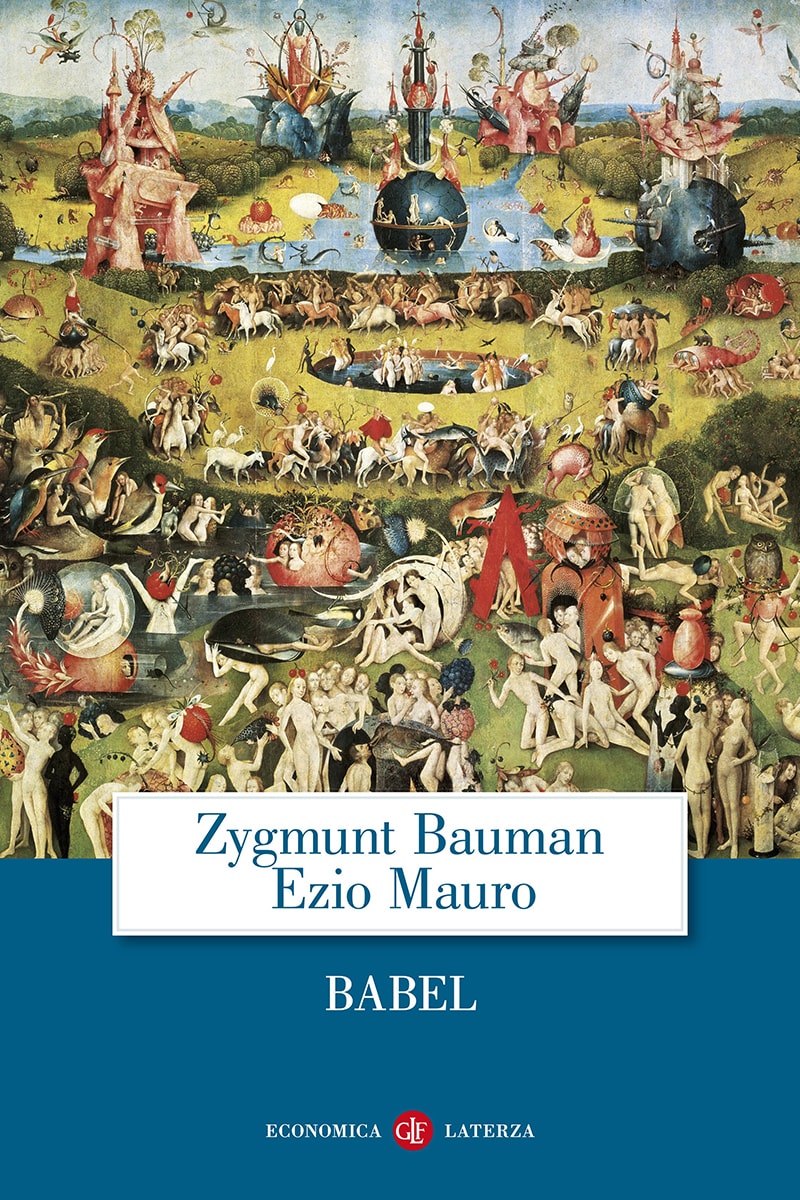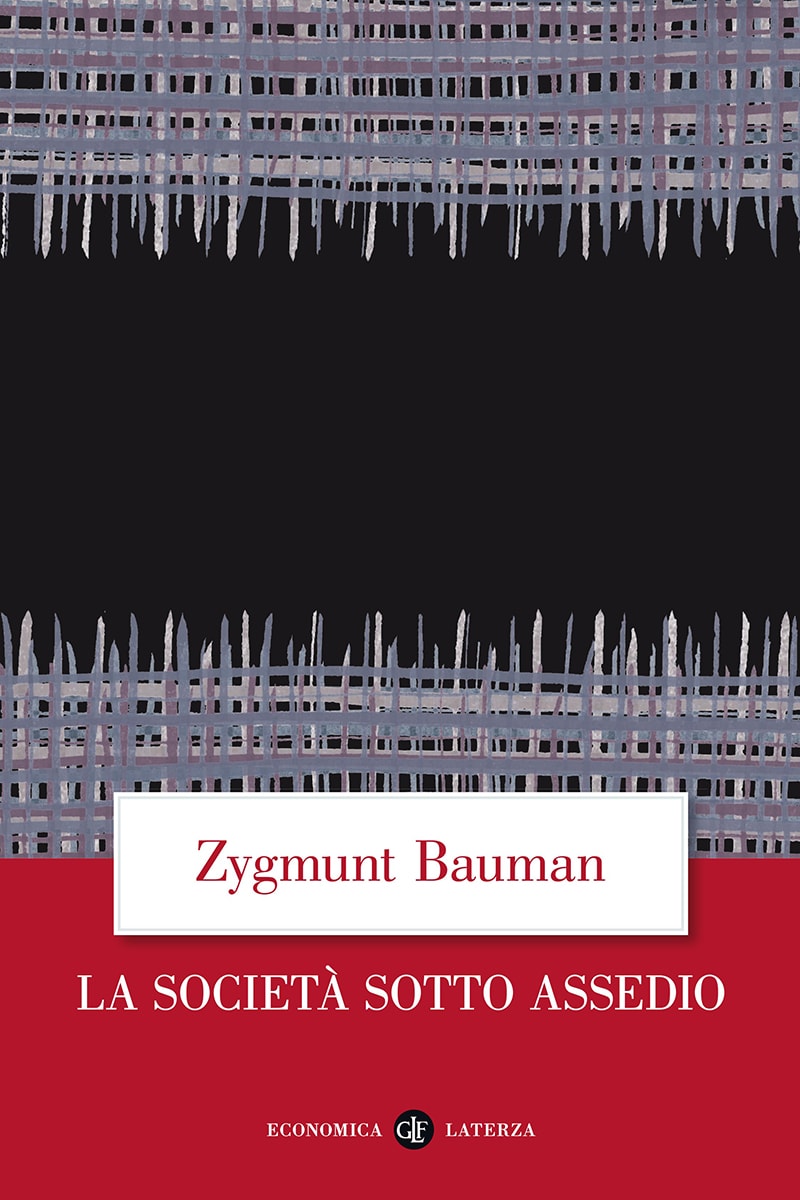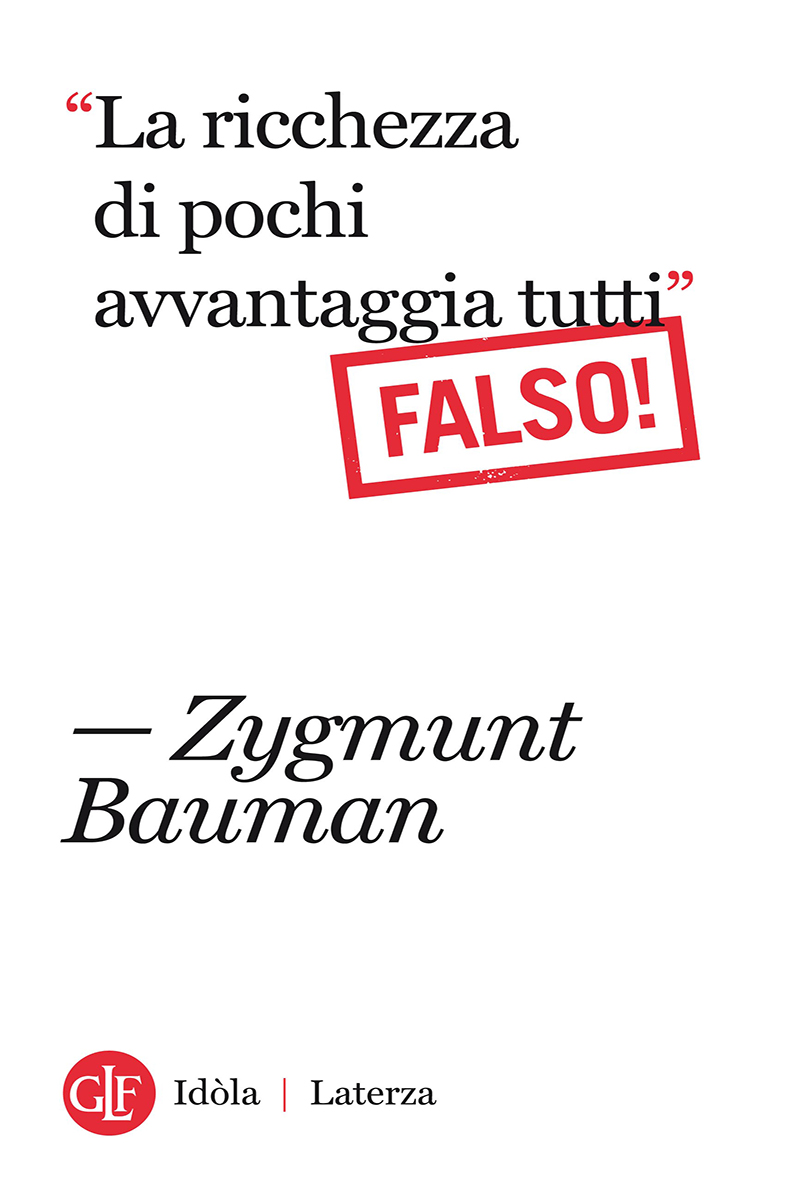Danni collaterali
Il termine ‘danni collaterali’ indica le conseguenze indesiderate delle operazioni belliche. Non sono però prerogativa esclusiva della guerra: i danni collaterali rappresentano uno degli aspetti più diretti e sconcertanti dell’ineguaglianza sociale che caratterizza la nostra epoca.
Perché ad essere intrinsecamente votati ai danni collaterali sono i poveri, per sempre segnati dal duplice marchio dell’irrilevanza e dell’indegnità. Causare danni collaterali è più facile nei quartieri loschi e tra le strade più malfamate delle città che nelle tranquille zone residenziali abitate da uomini potenti e altolocati. Tra l’occupare il gradino più basso della scala della disuguaglianza e il ritrovarsi ‘vittima collaterale’ di un’azione umana o di un disastro naturale esiste lo stesso rapporto che intercorre tra i poli opposti delle calamite, che tendono a gravitare l’uno verso l’altro.