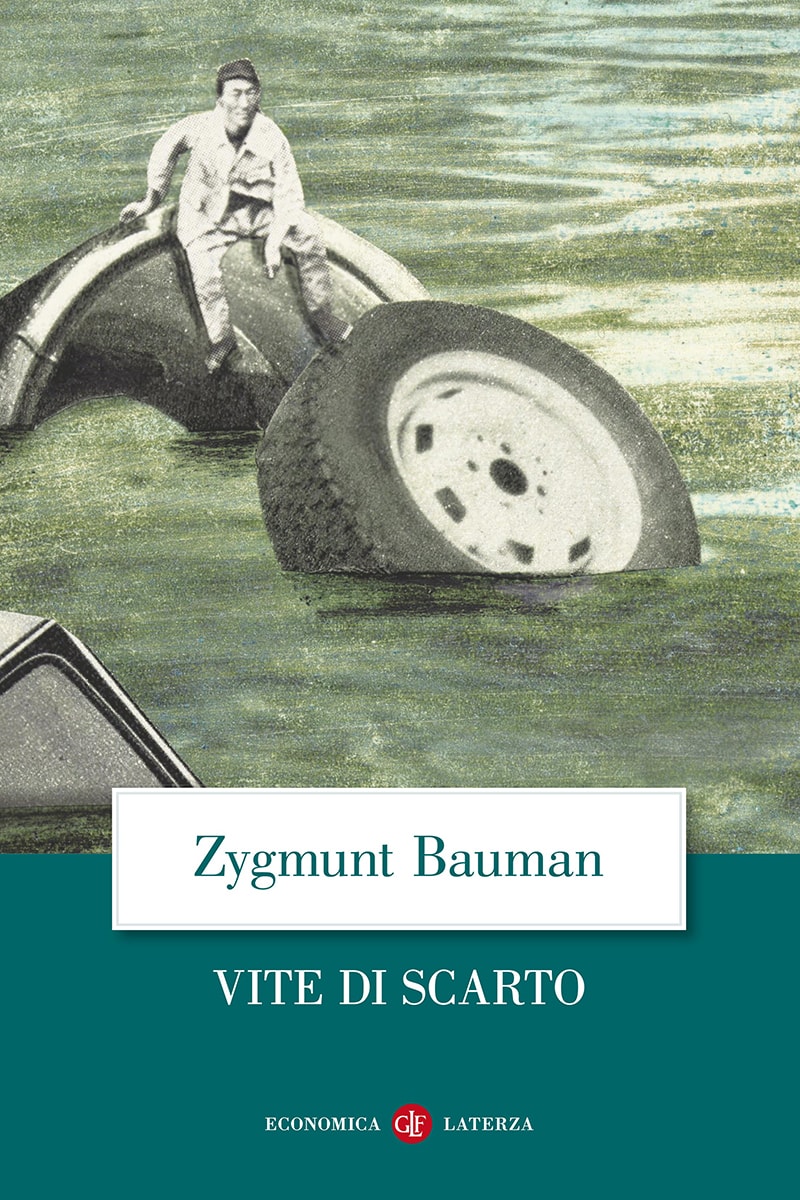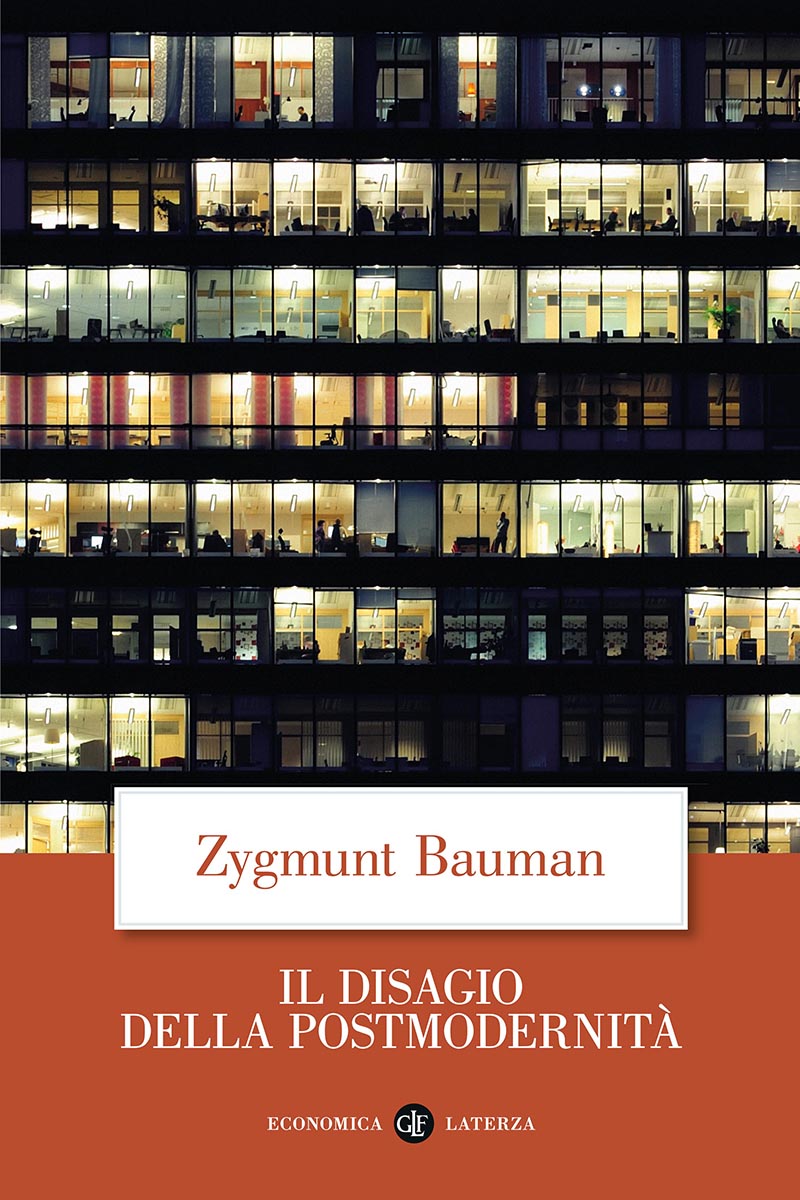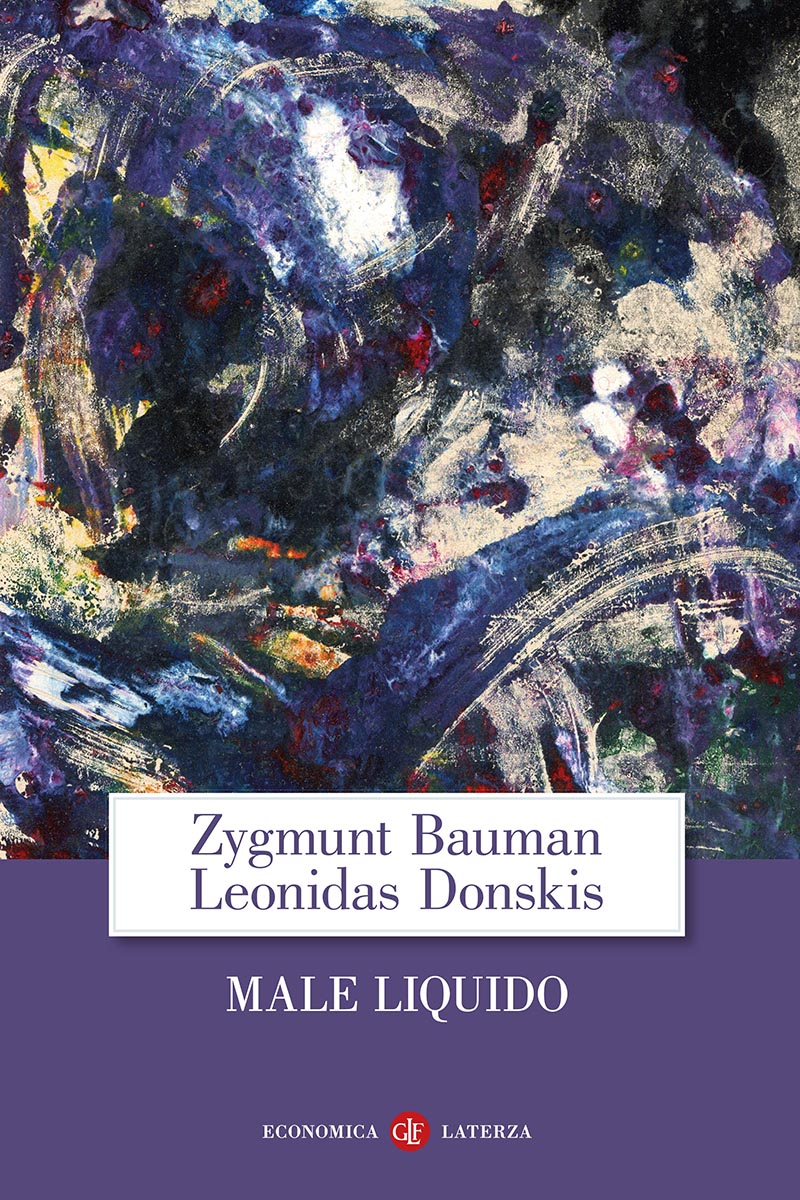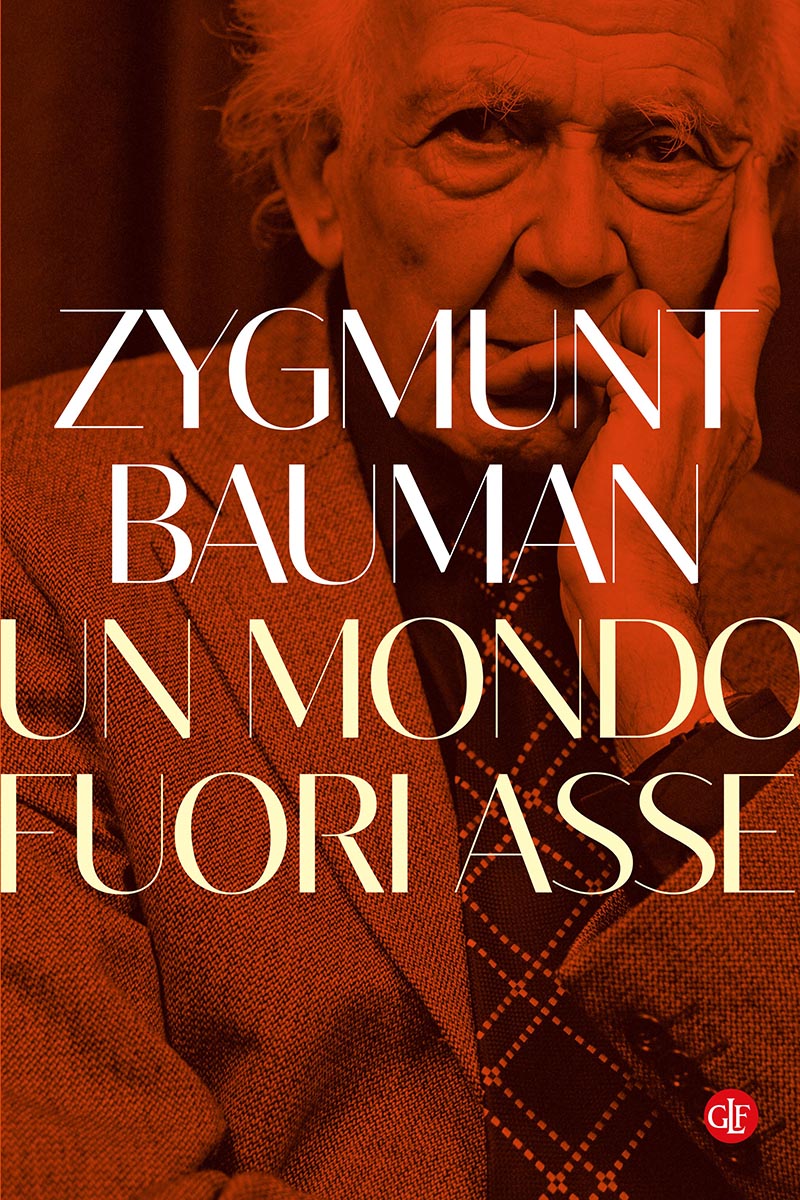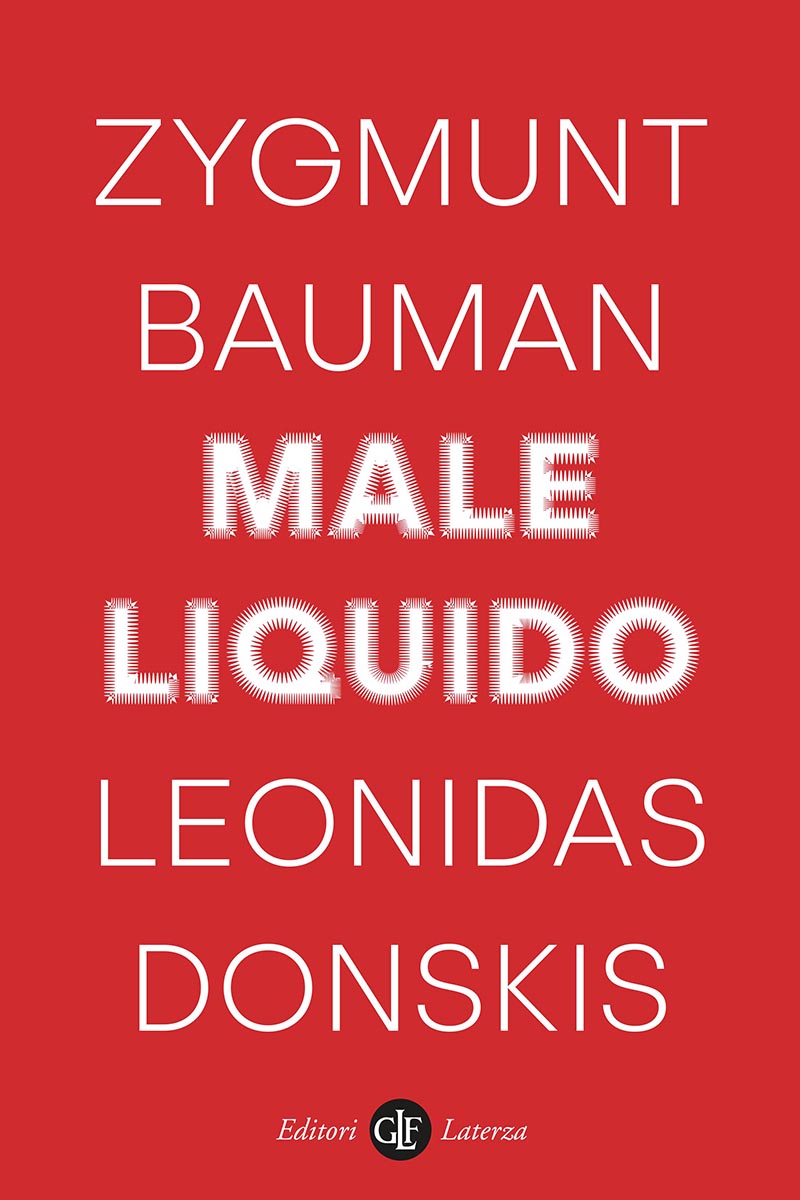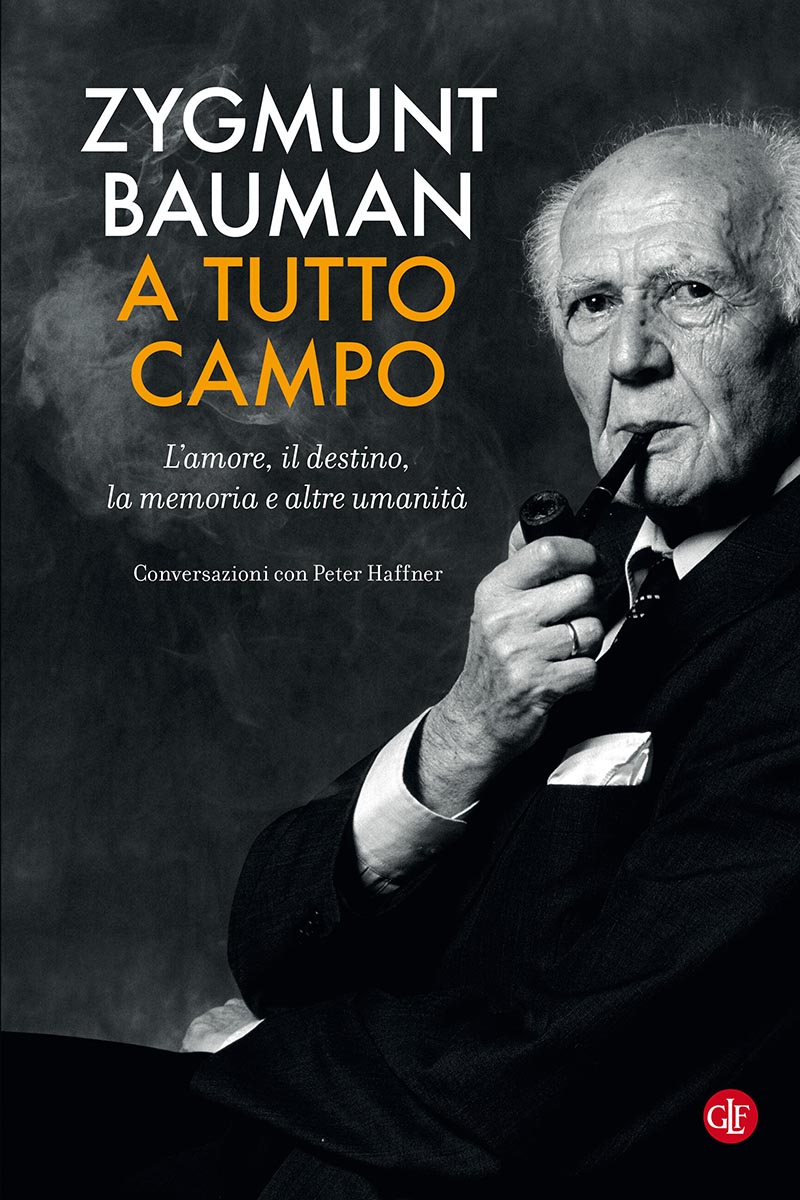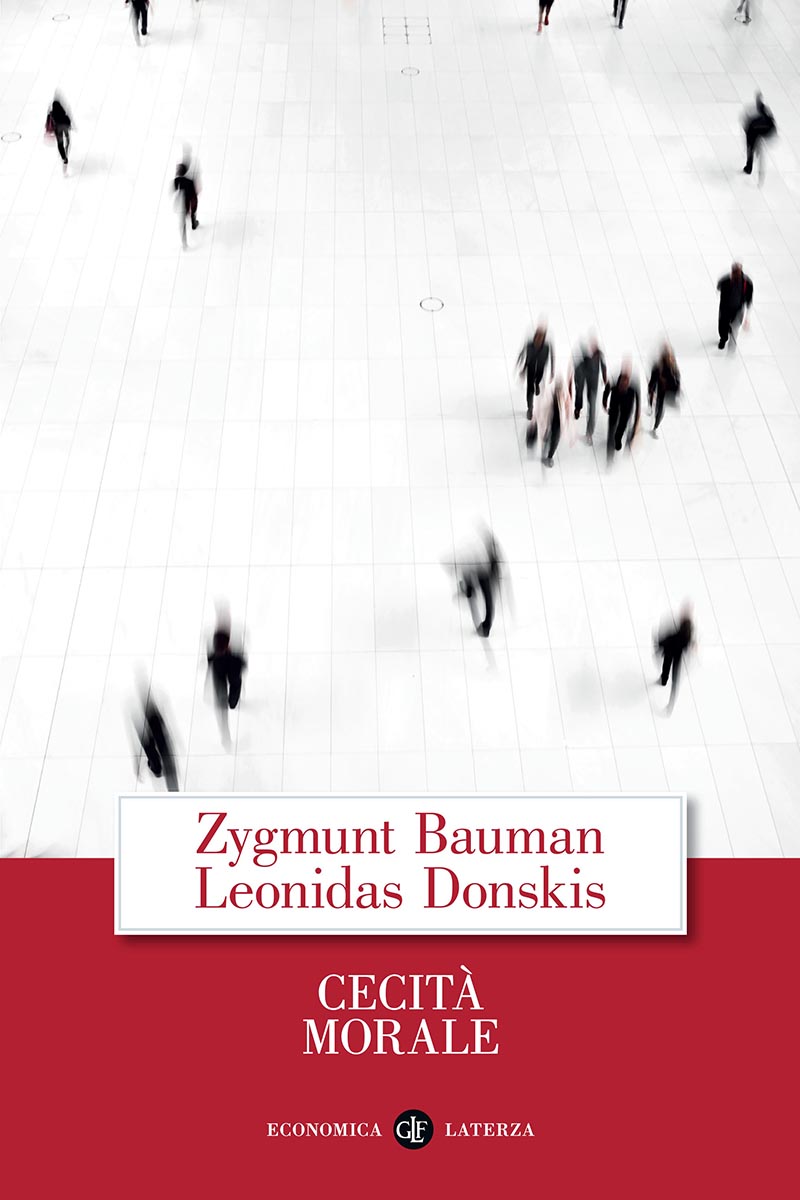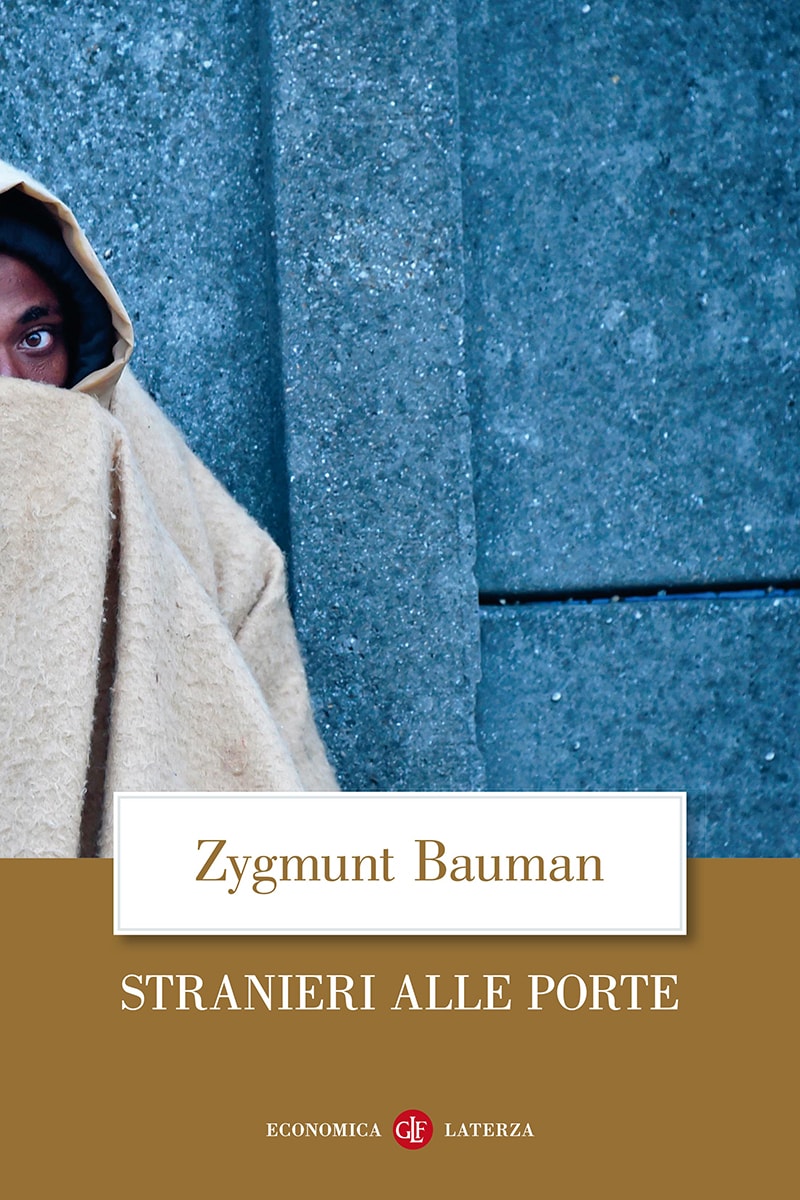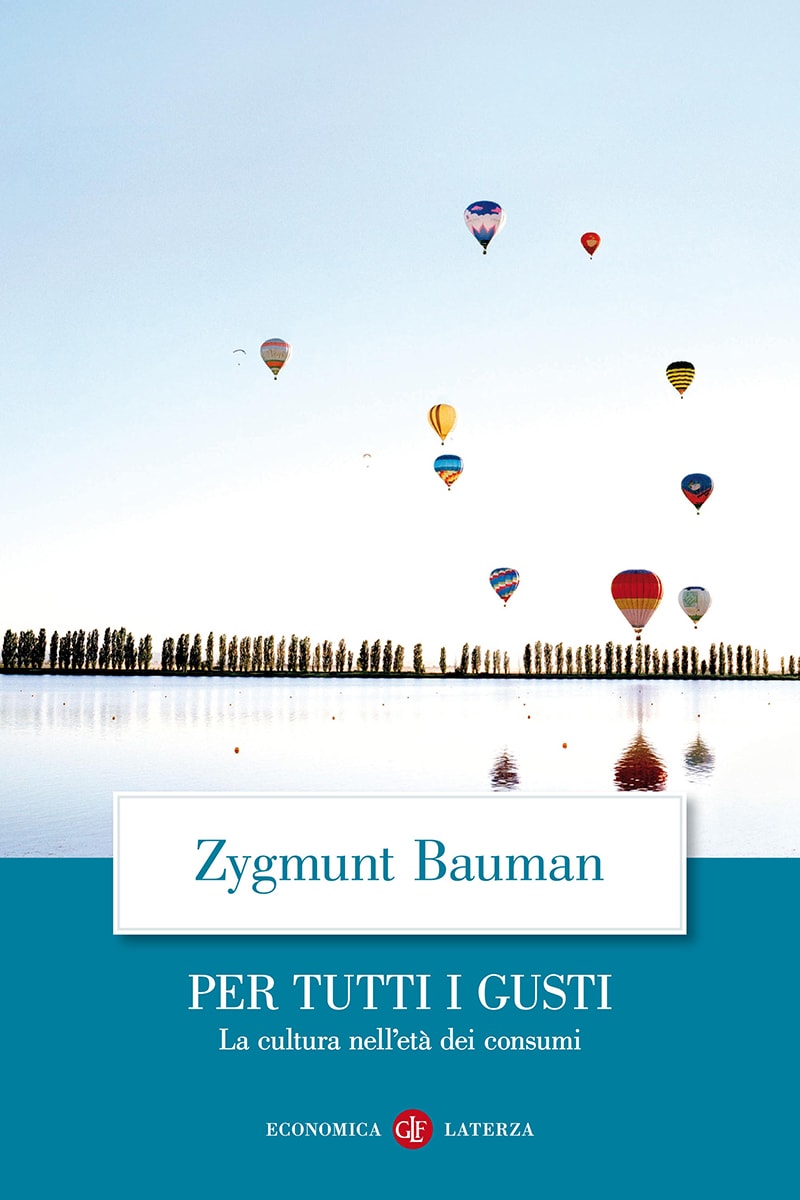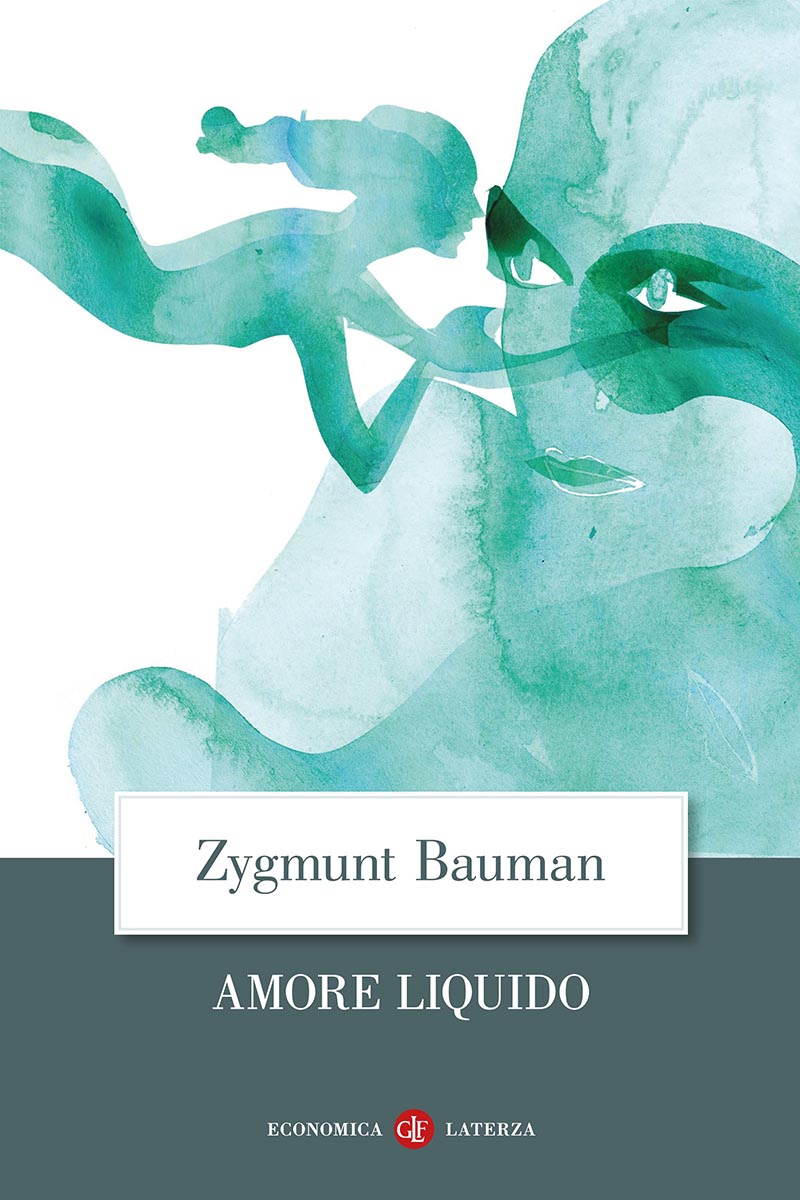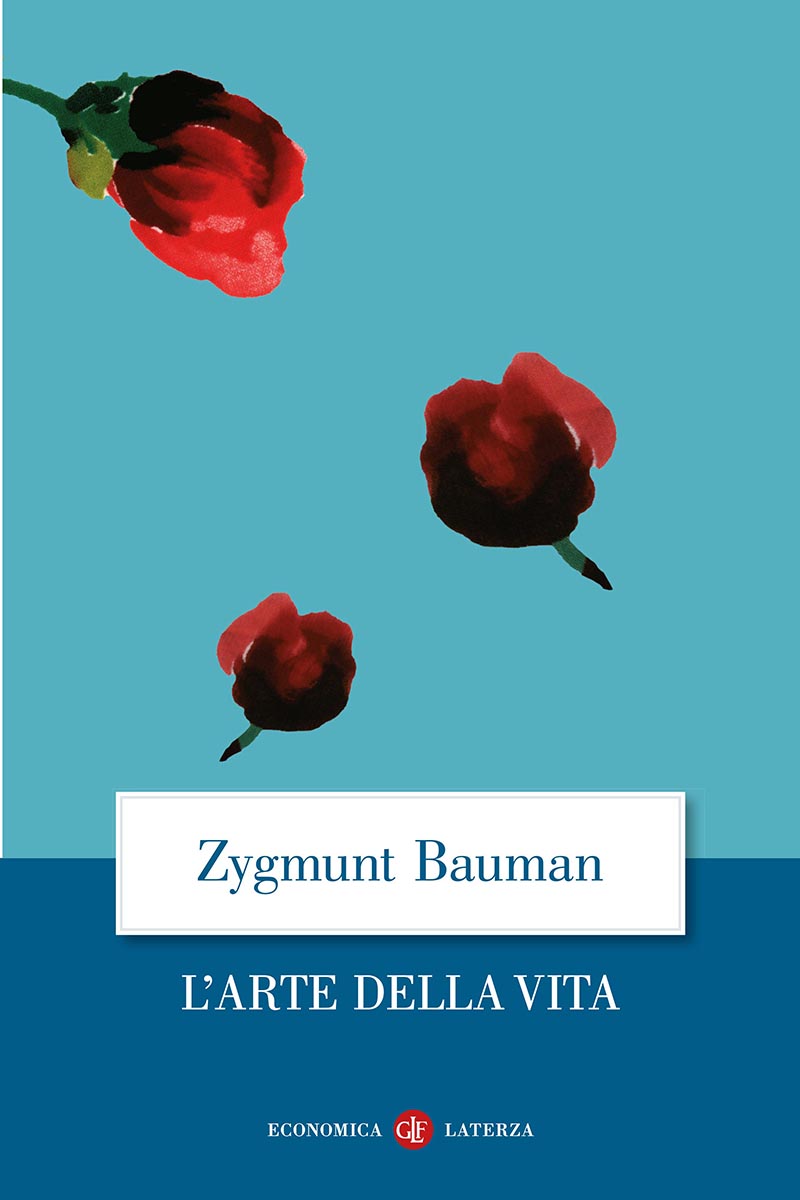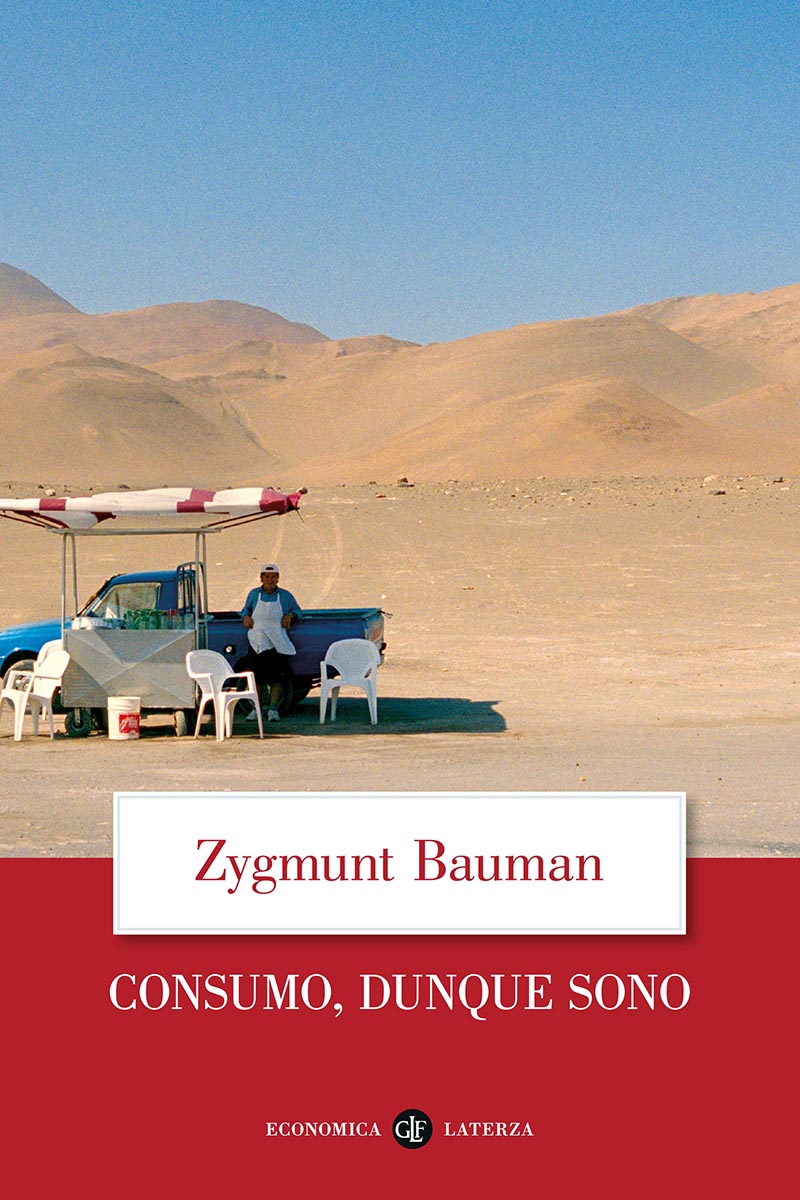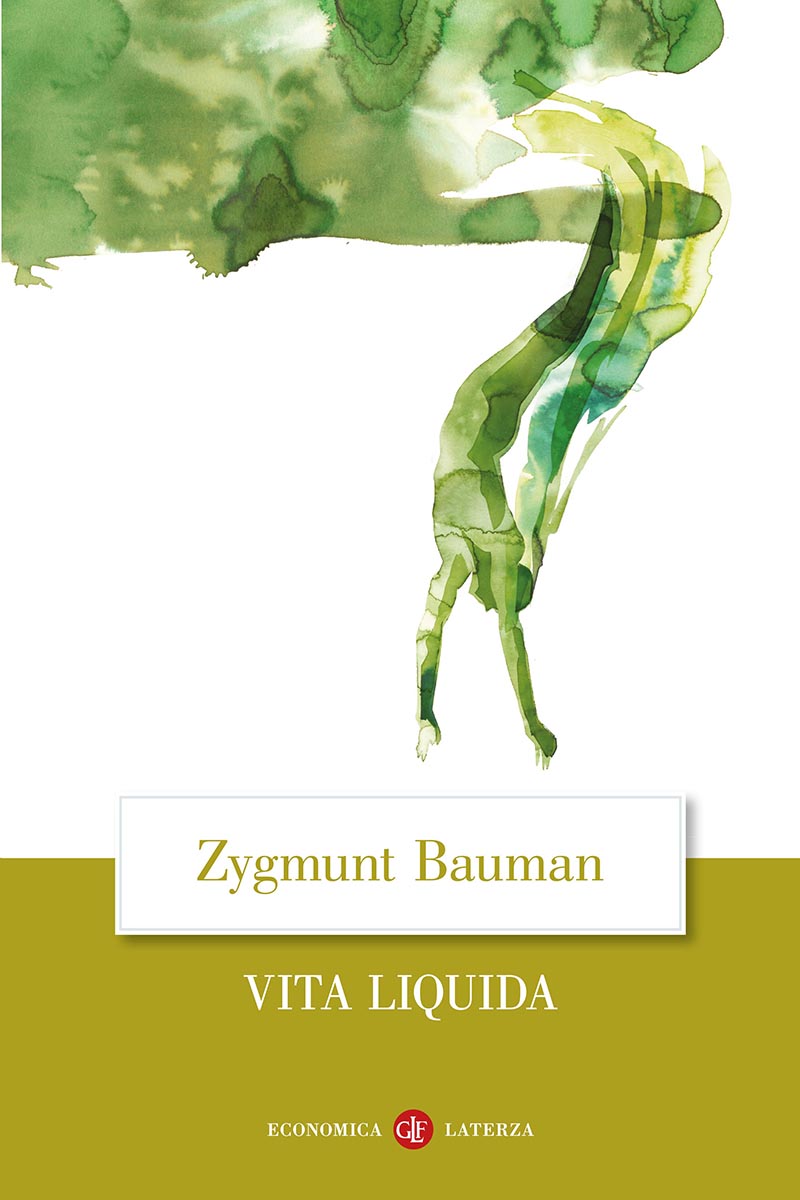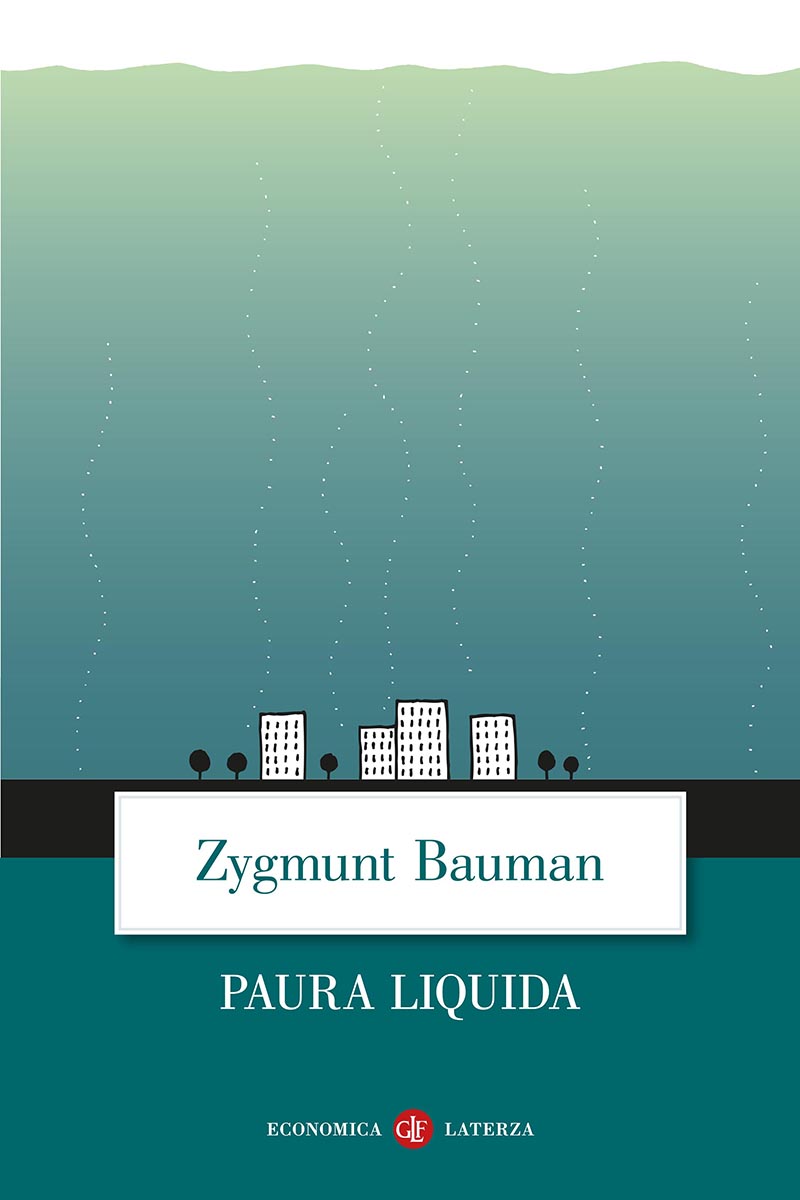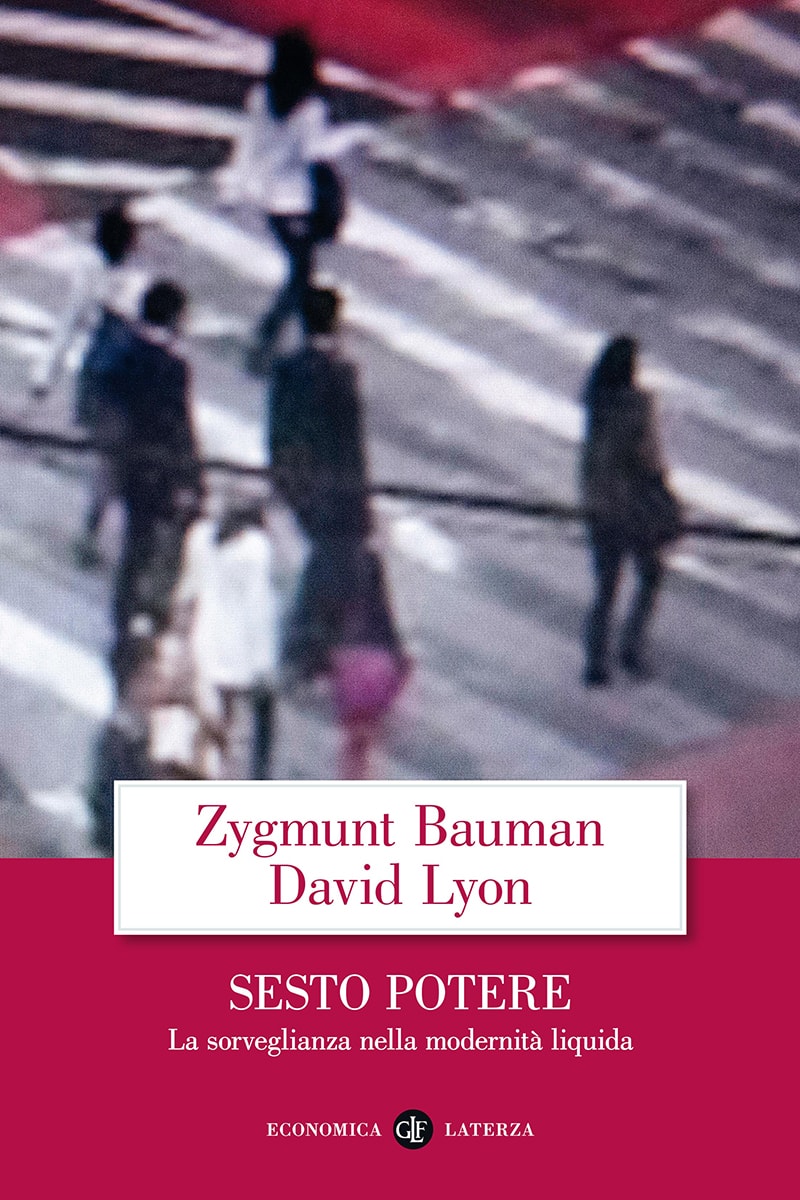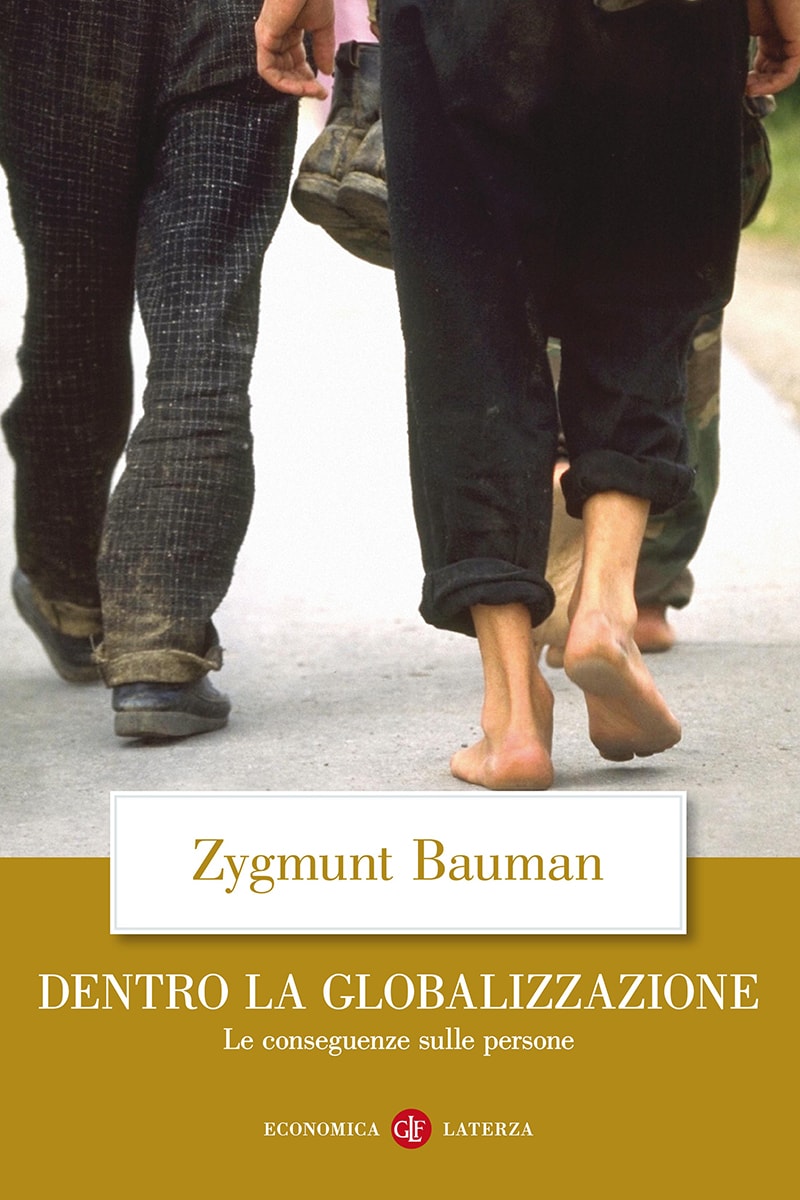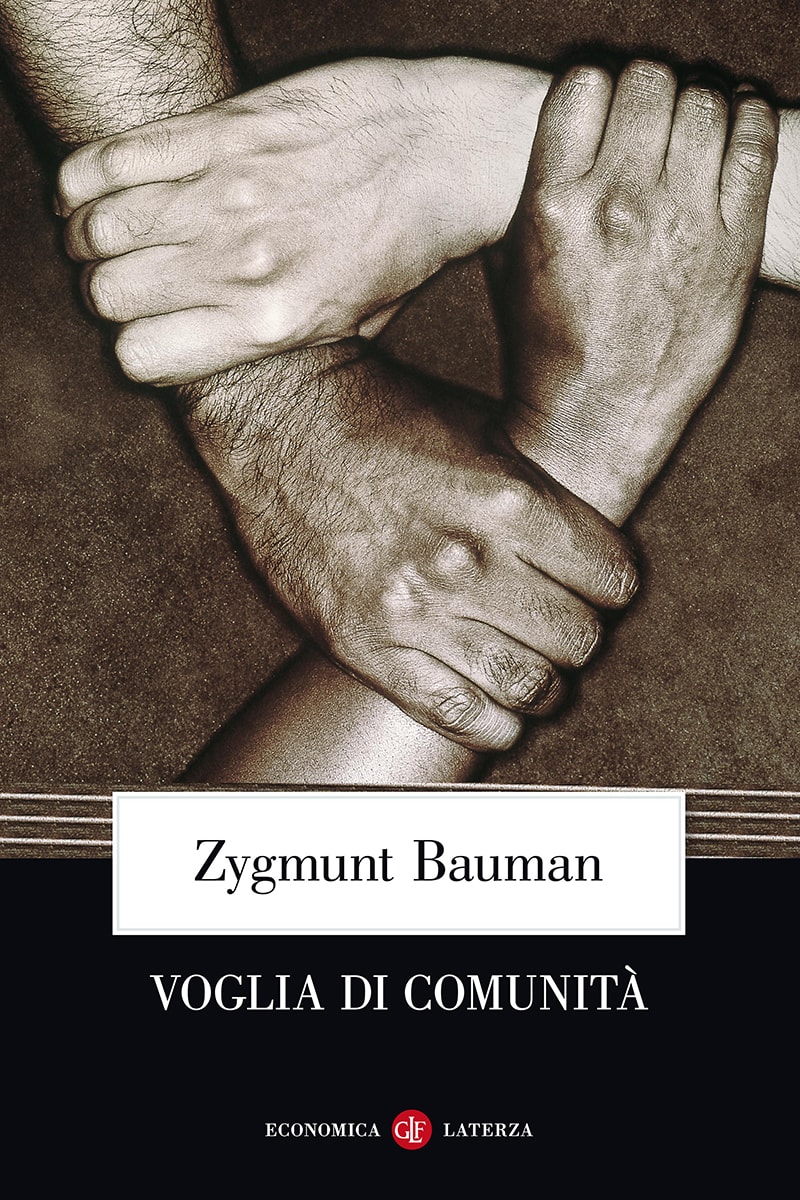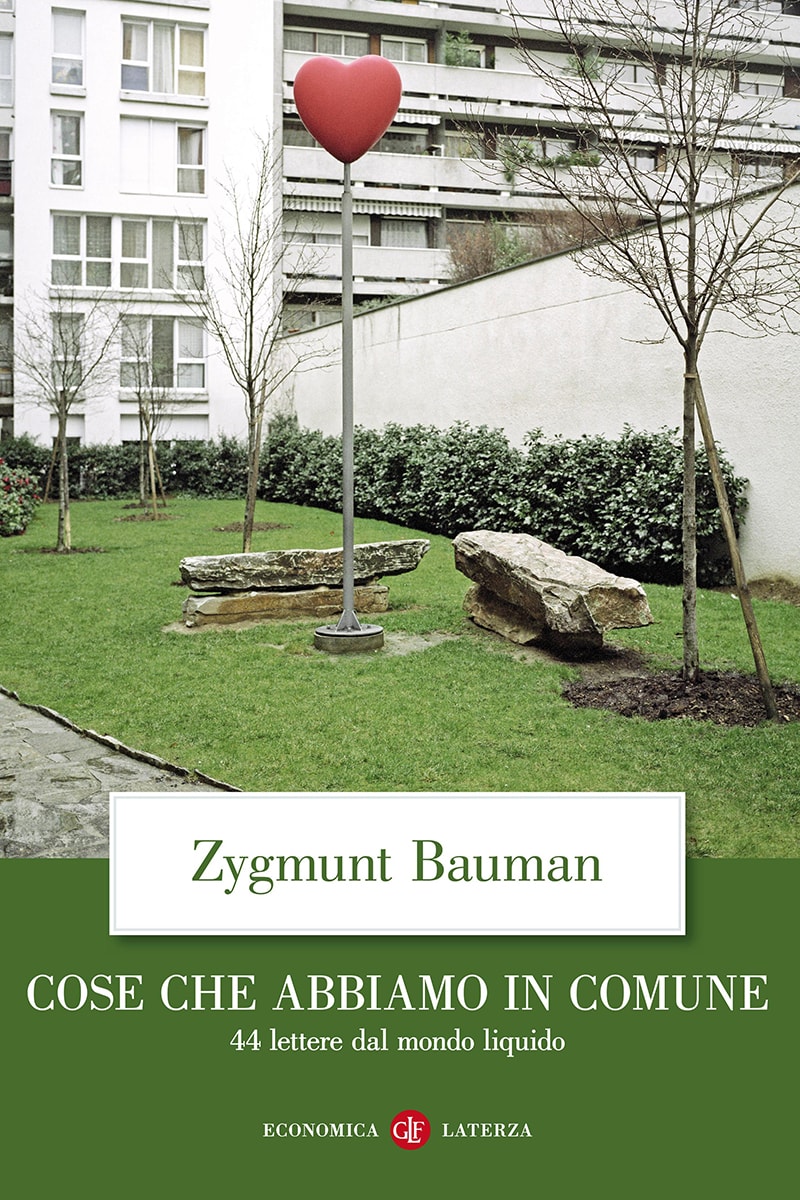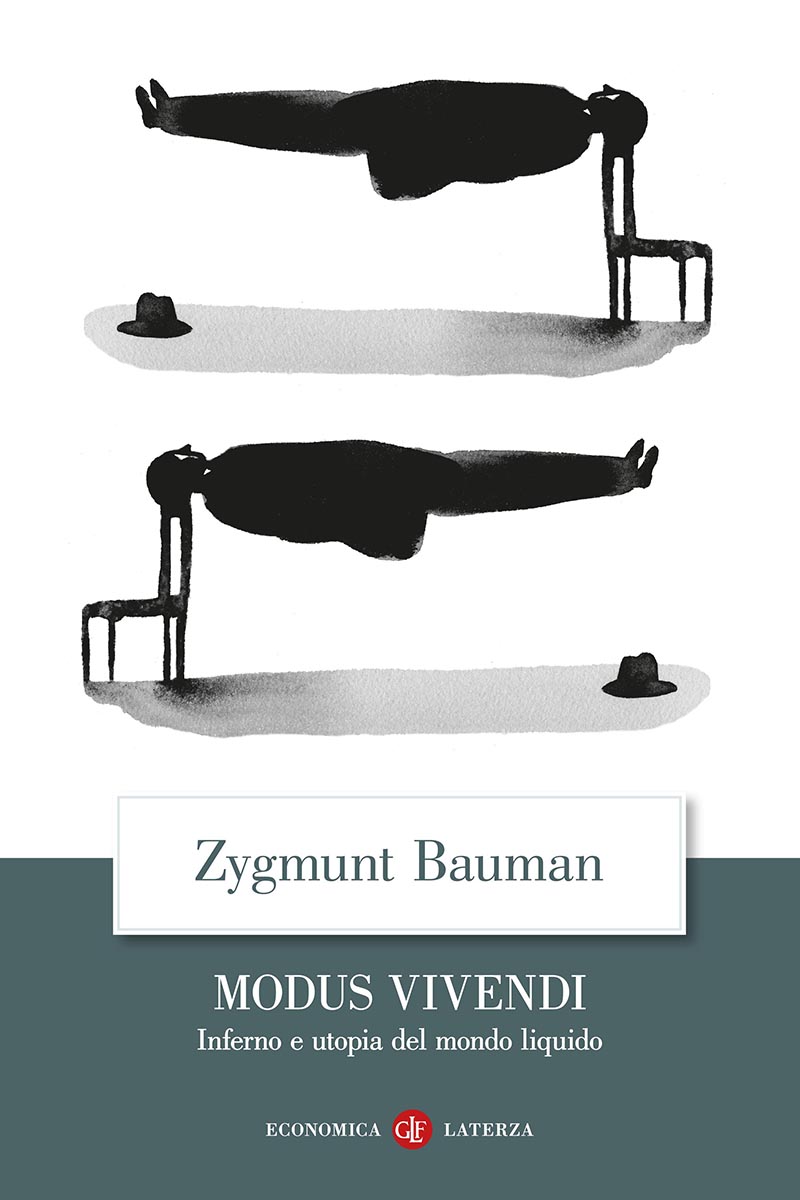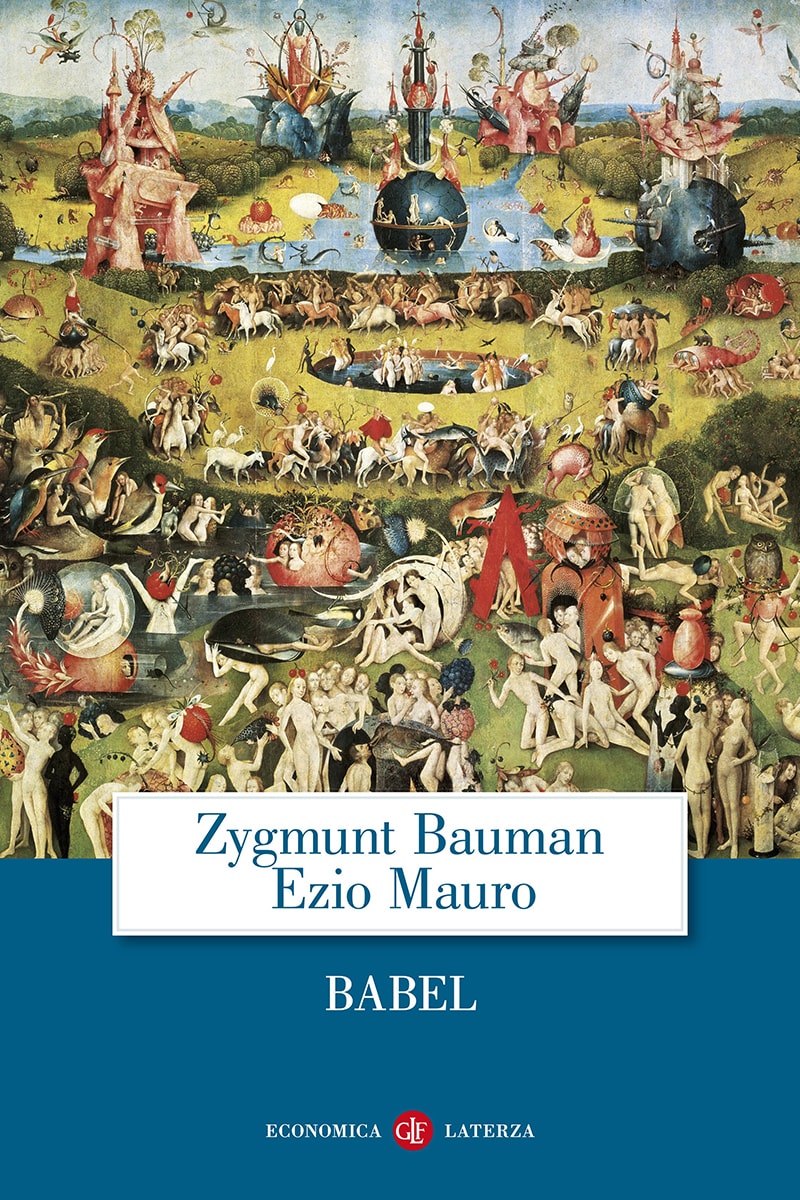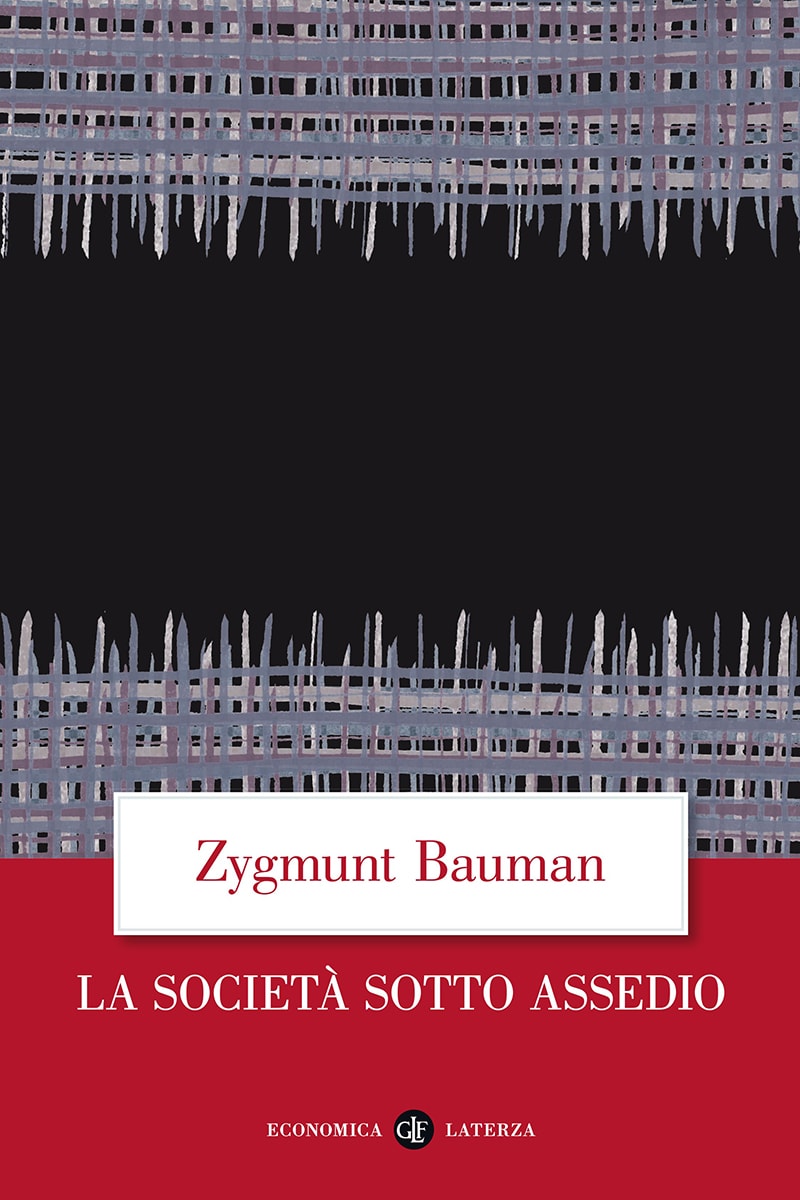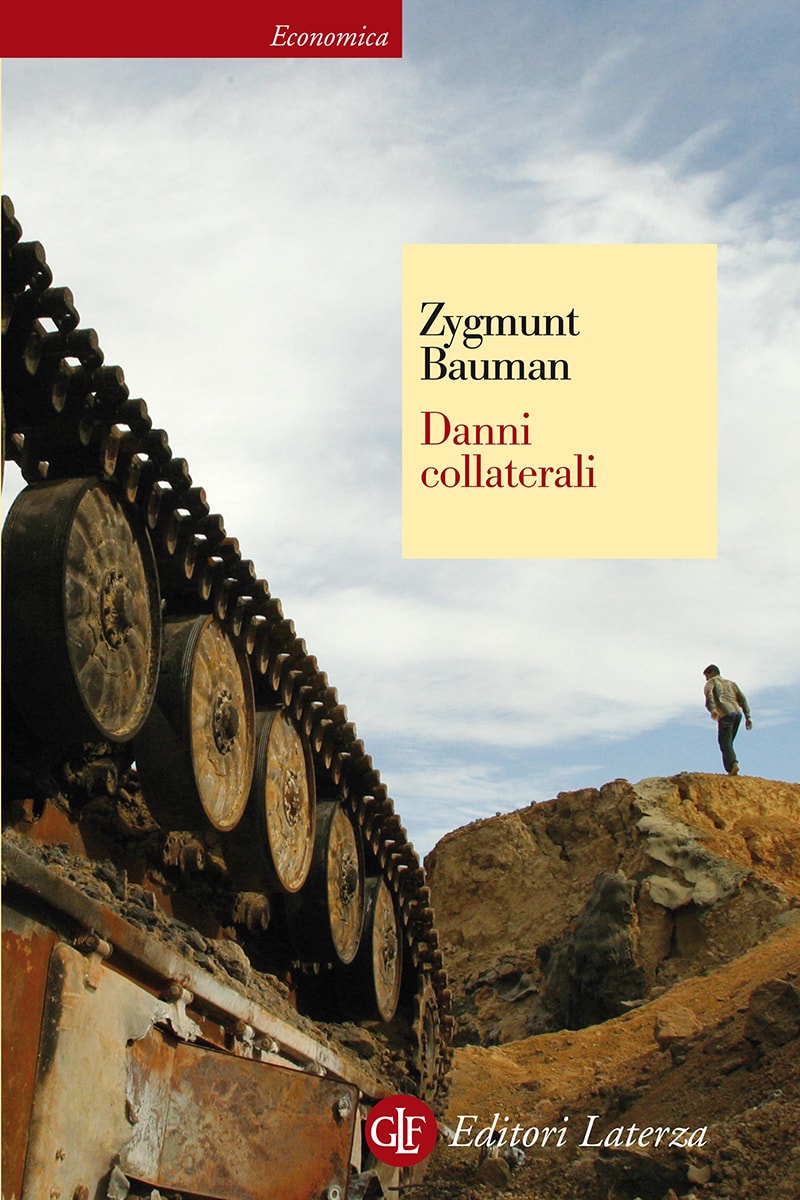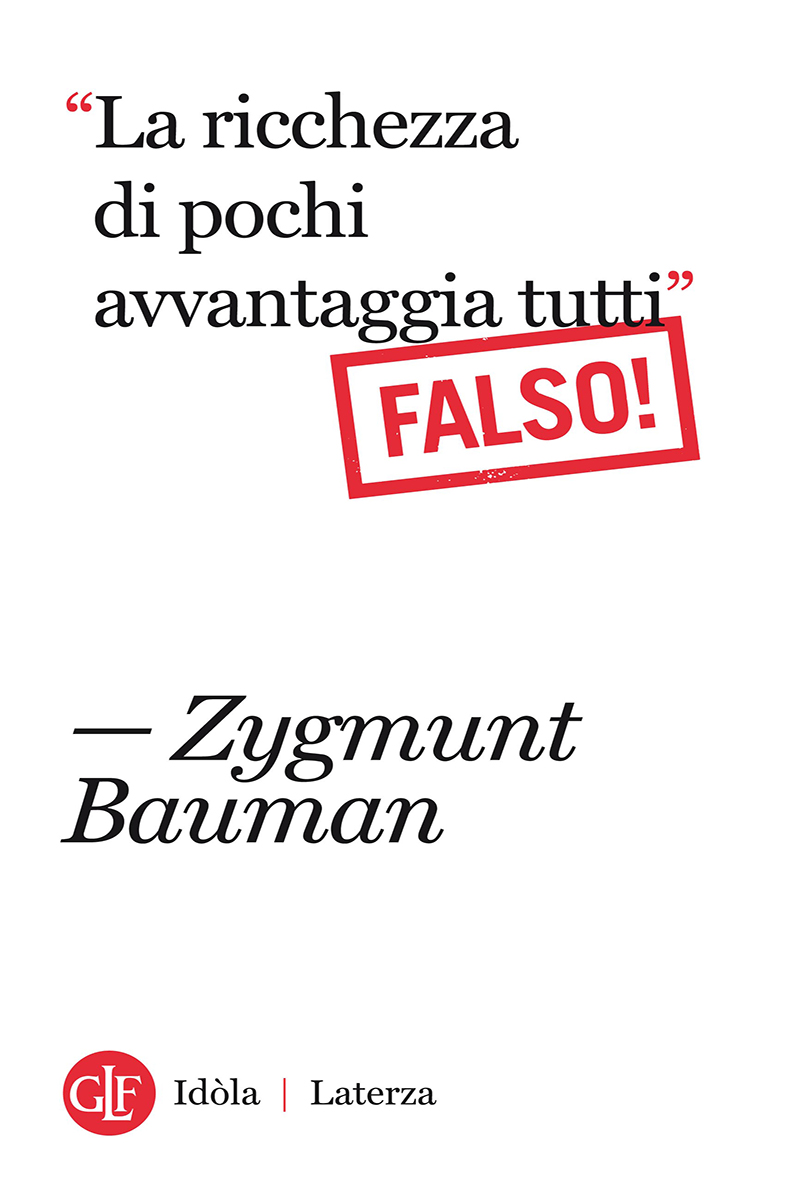Vite di scarto
Chi un giorno vorrà studiare l’estinzione dell’uomo e della sua storia e il sorgere della nuova volatile specie che lo sta soppiantando, troverà nei libri di Bauman una guida illuminante. Paola Capriolo, “Corriere della Sera”
Ci piace produrre rifiuti. Senza capire che diventiamo noi stessi rifiuti. Bauman non dà tregua, smonta le nostre illusioni e le nostre perversioni, pagina dopo pagina. Un libro da leggere. Lelio Demichelis, “Tuttolibri”
Oggi il mondo è pieno. Non esistono più ‘frontiere’ verso cui convogliare la popolazione eccedente. L’analogia descritta da Zygmunt Bauman, tra i rifiuti materiali dei processi di produzione e consumo e i rifiuti umani generati dai processi storici, si rivela in questo saggio una potente chiave di interpretazione della storia. Guido Viale, “la Repubblica”