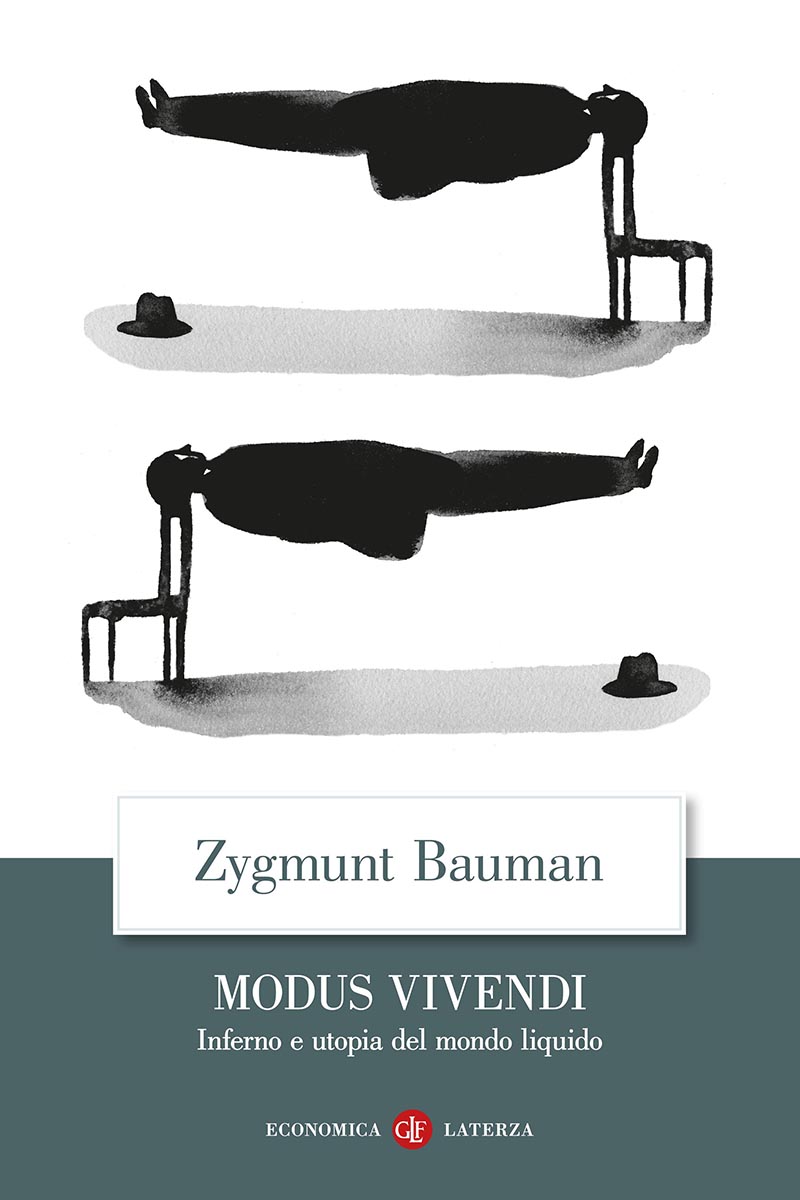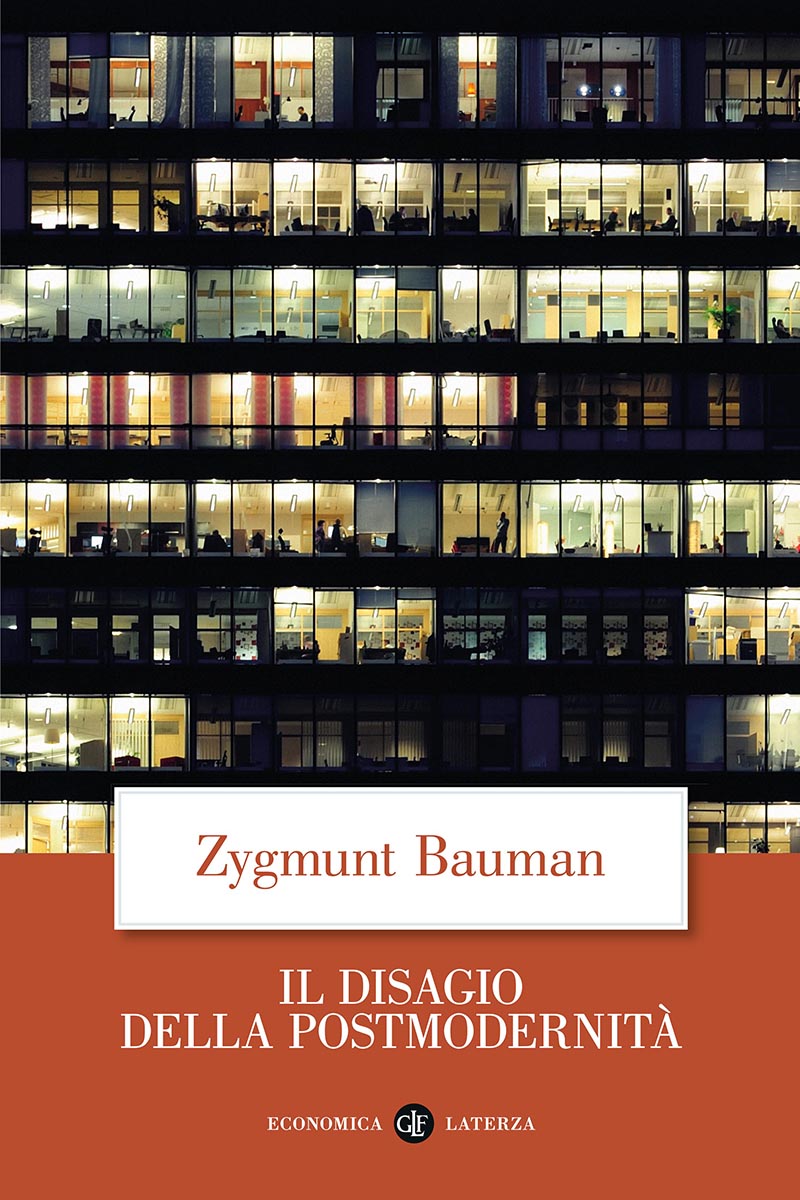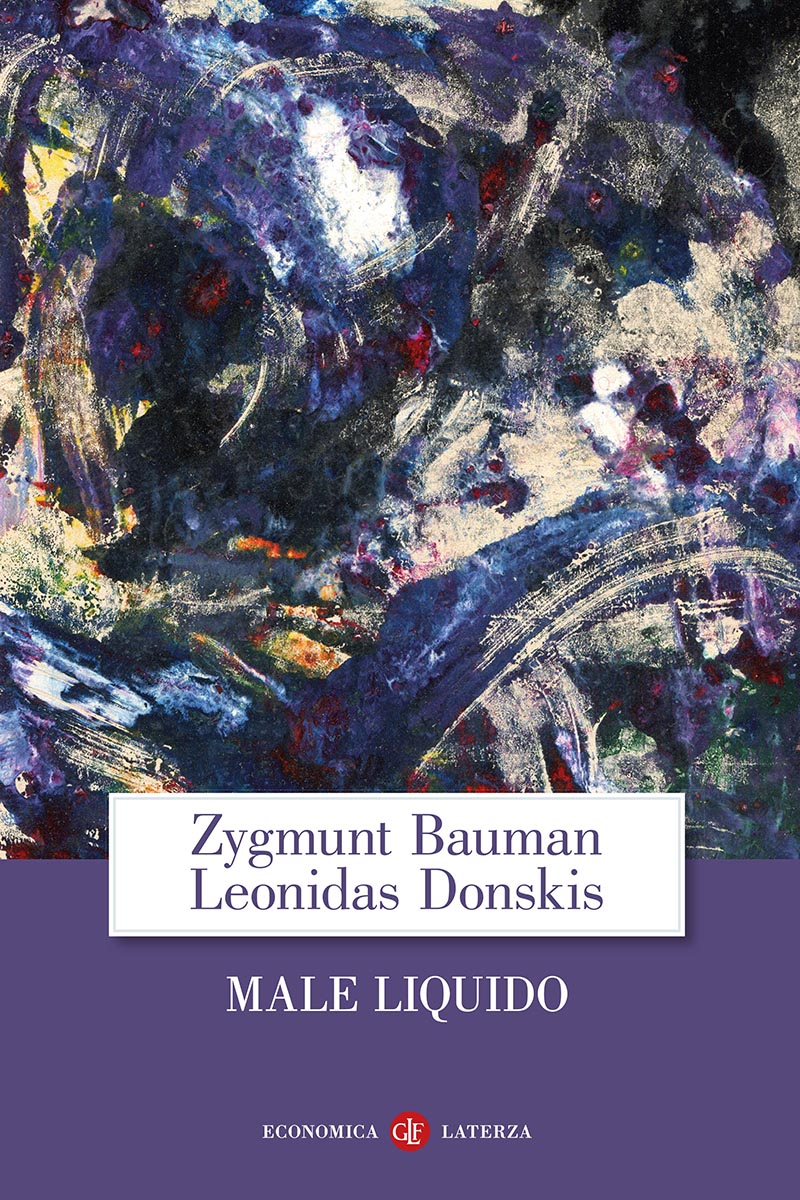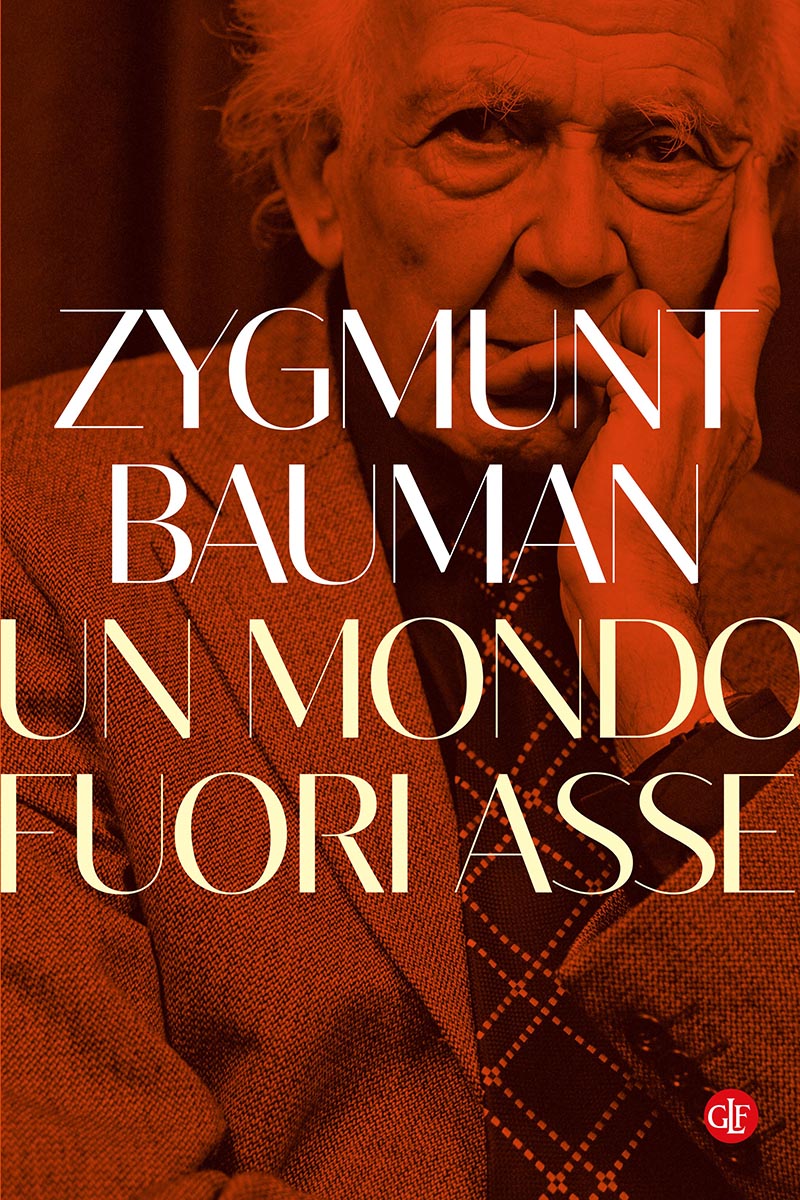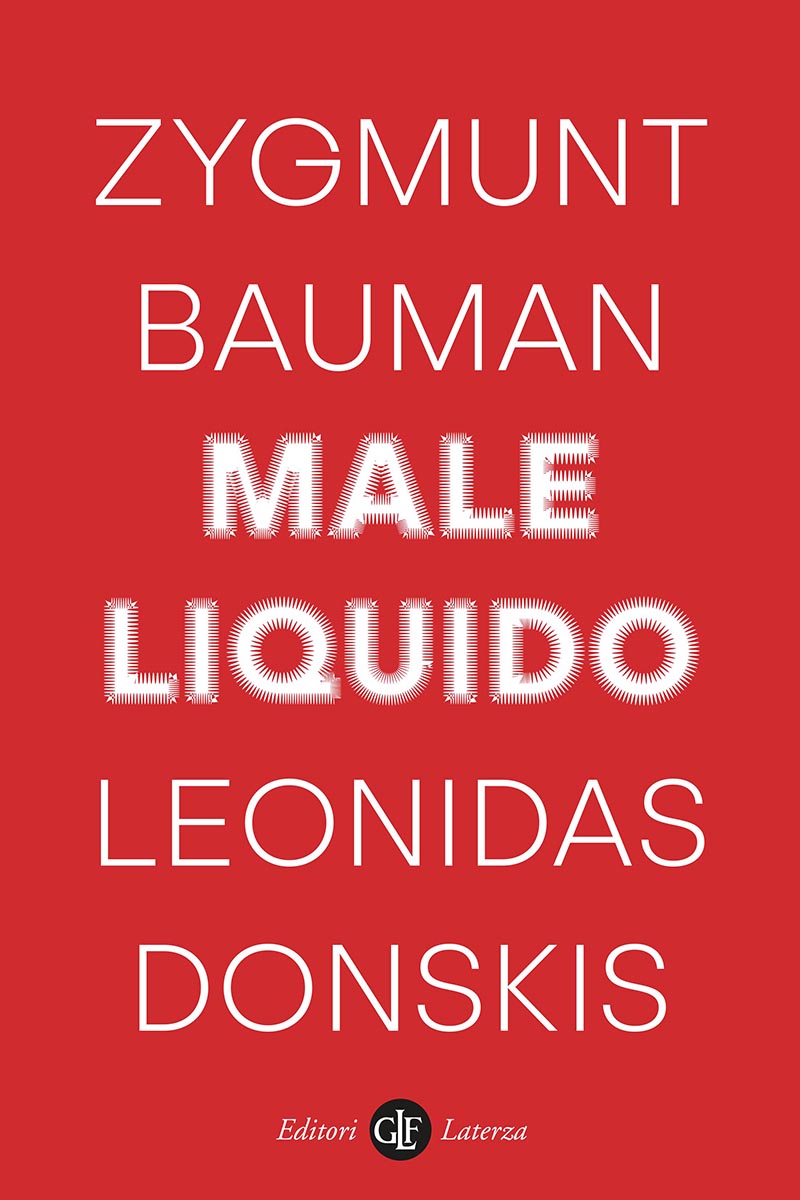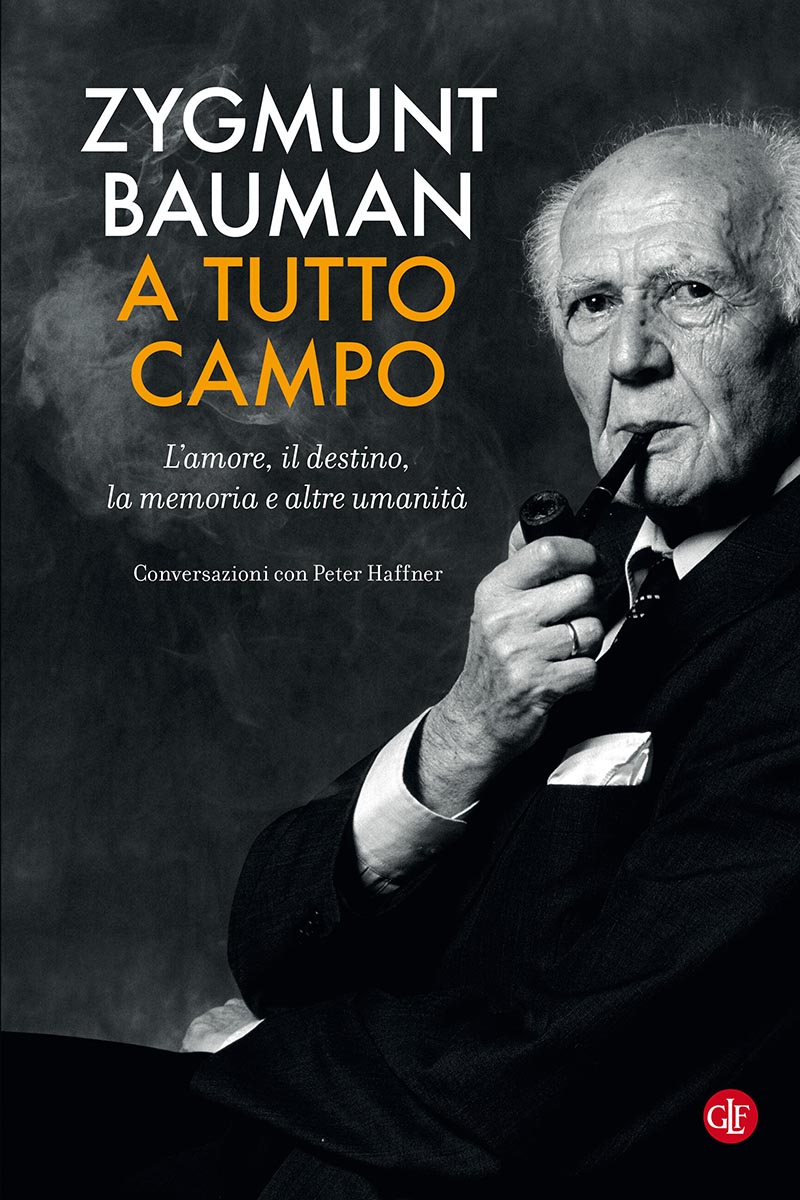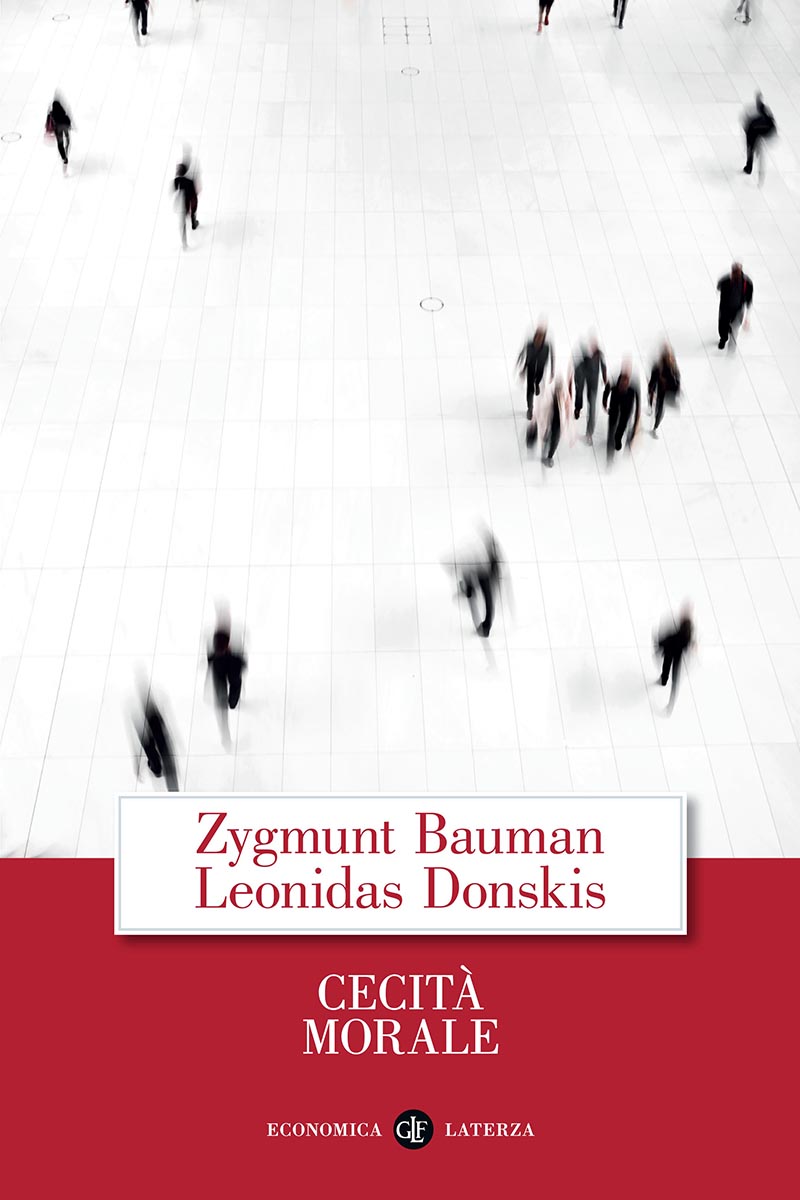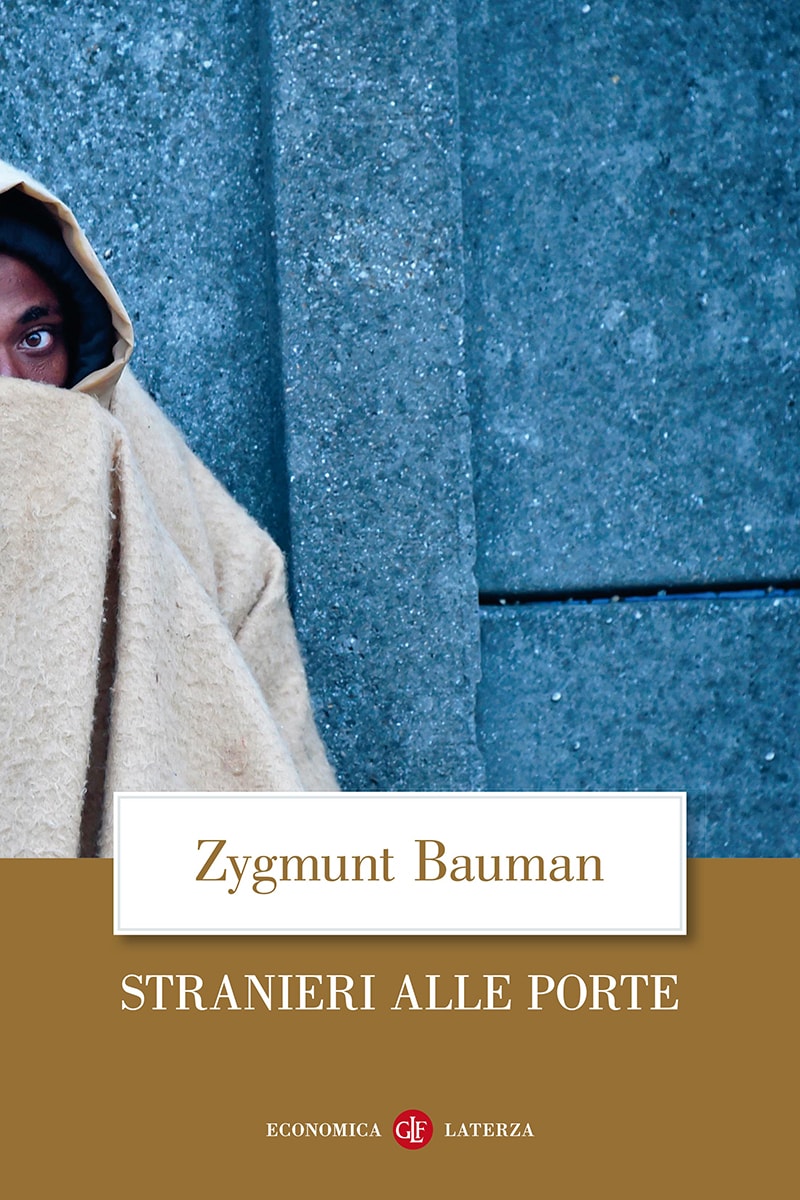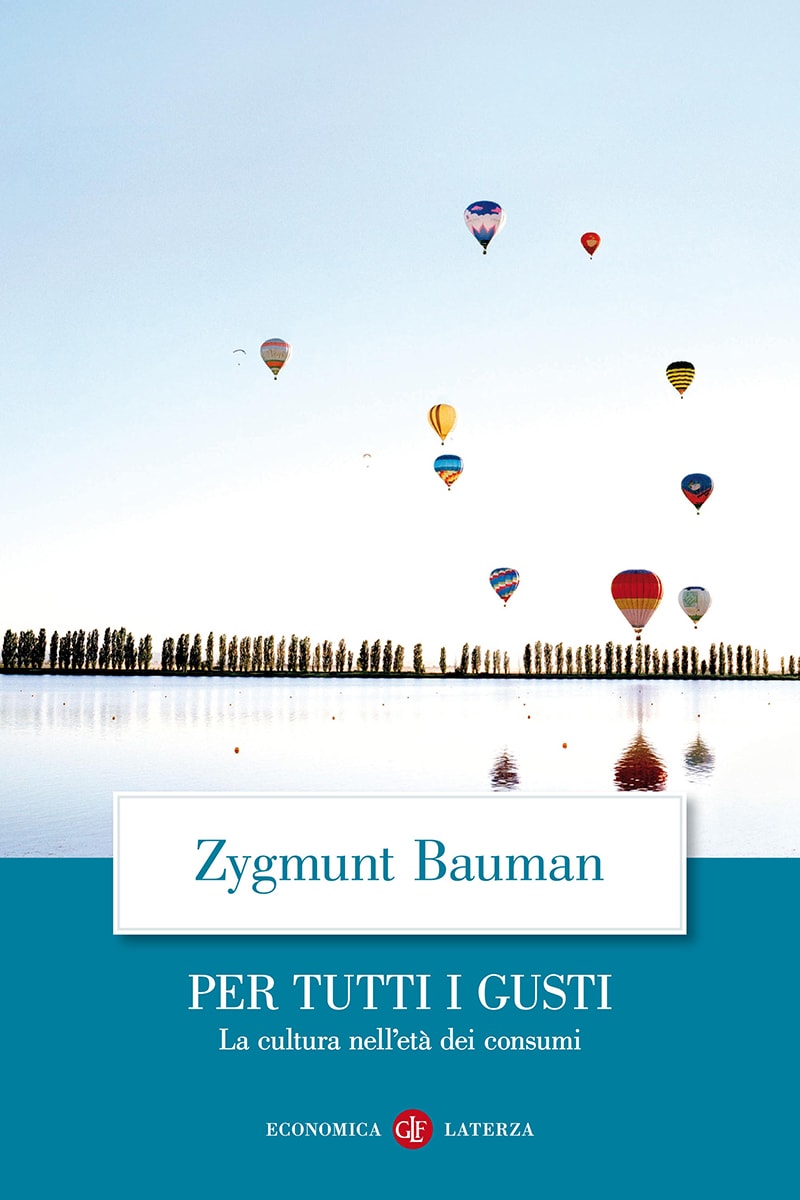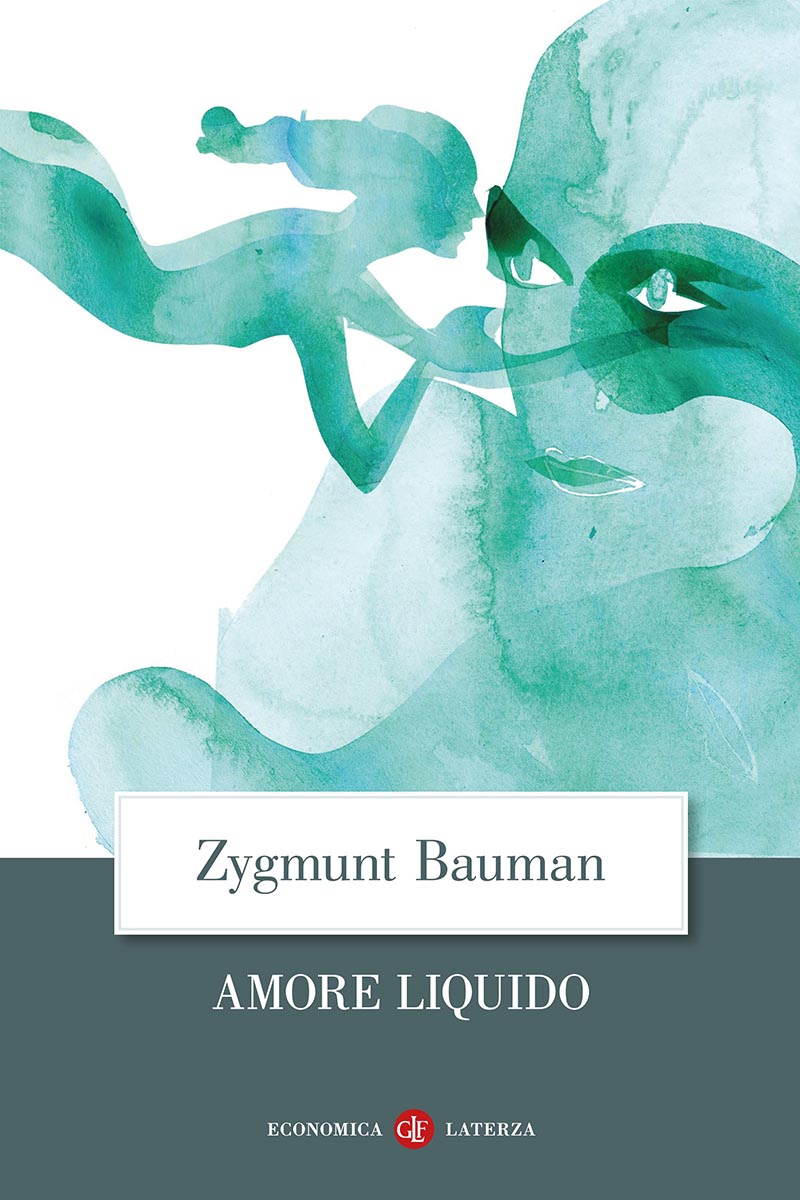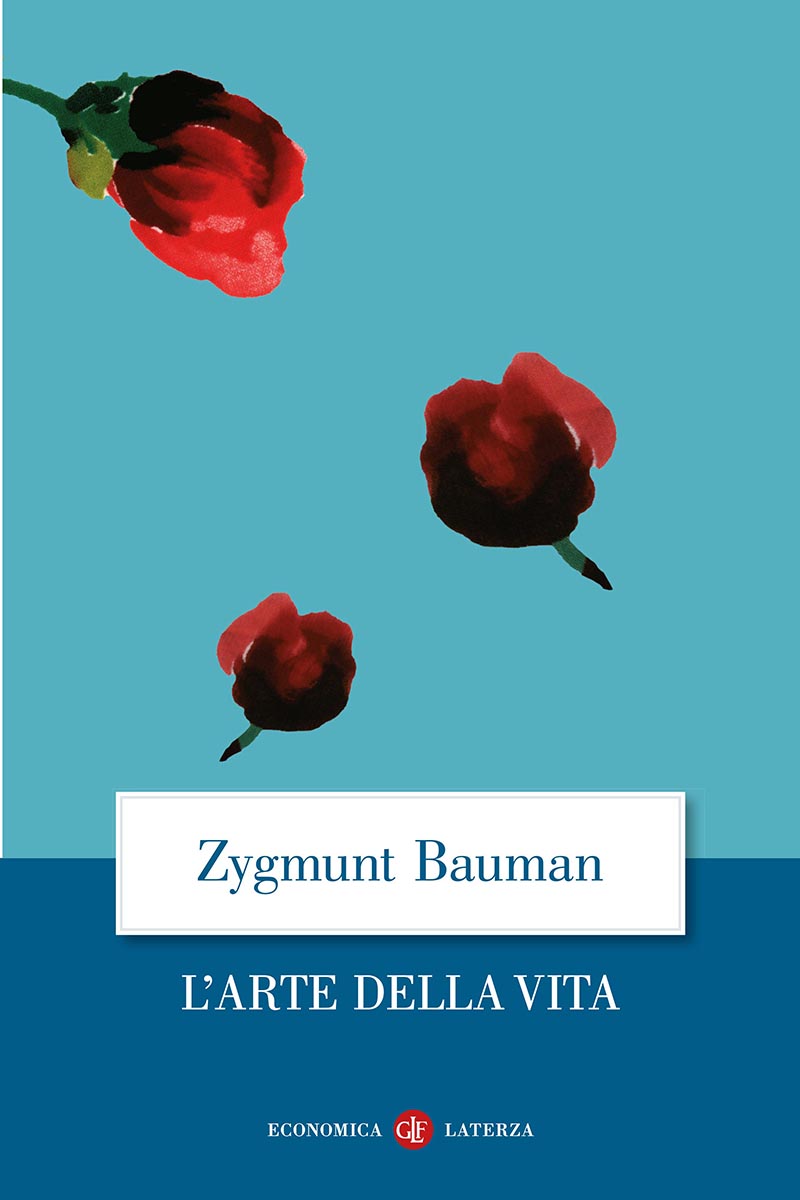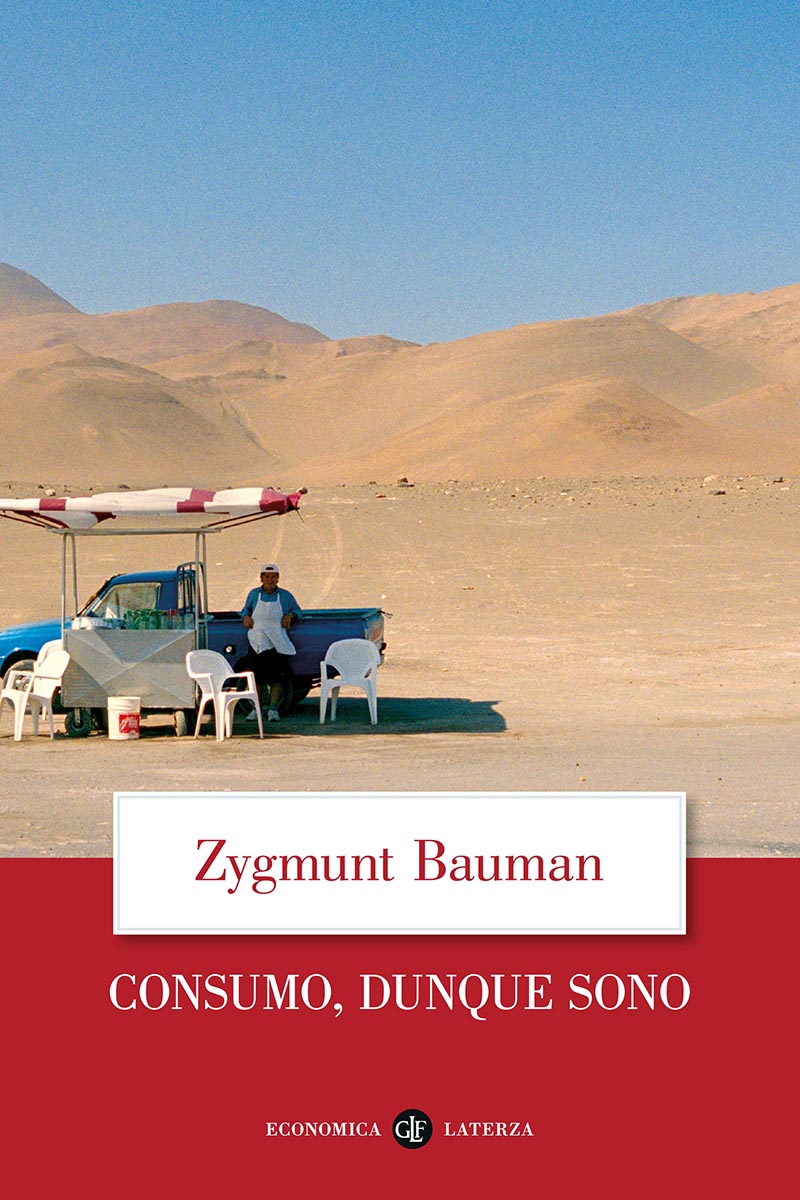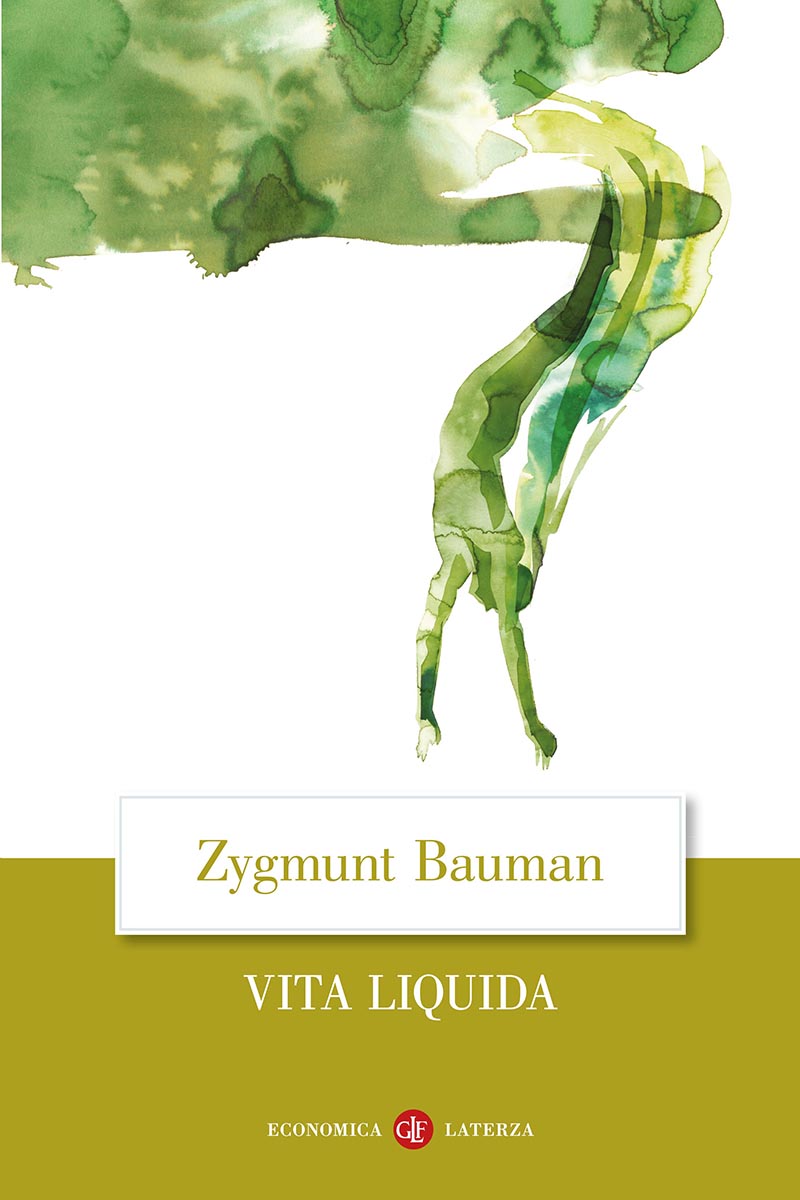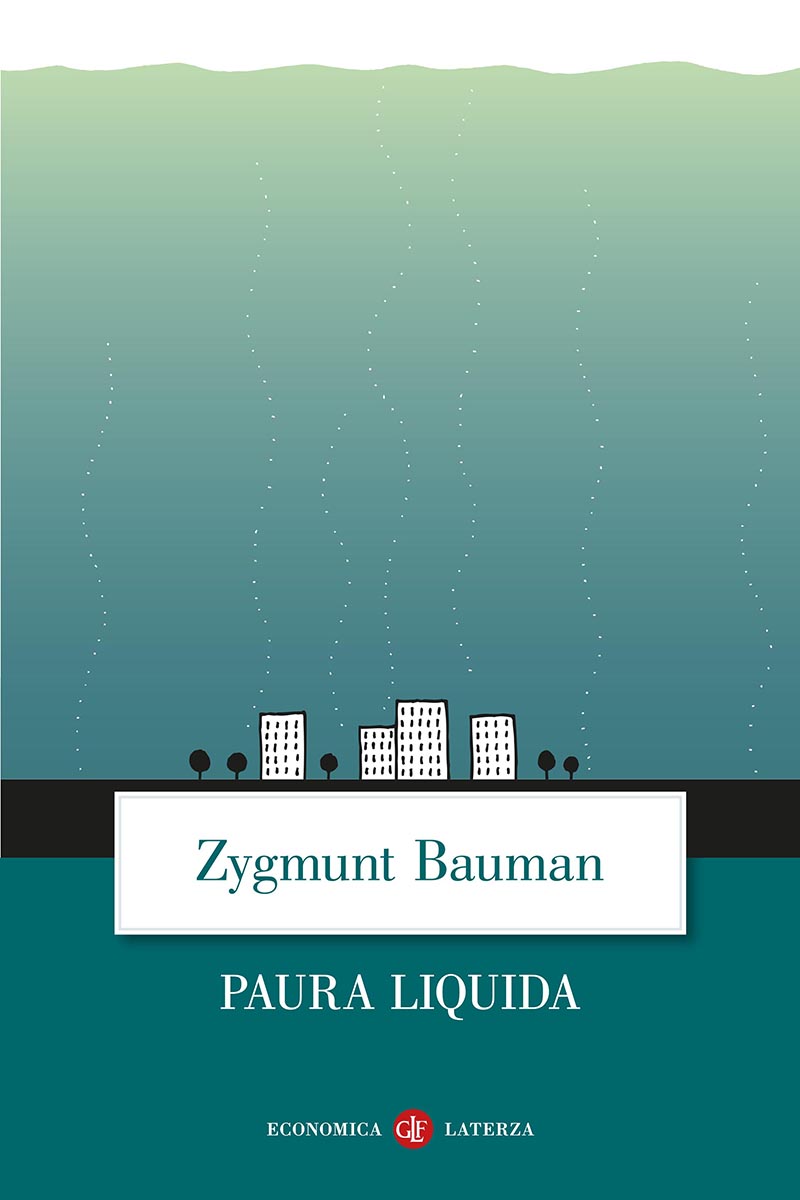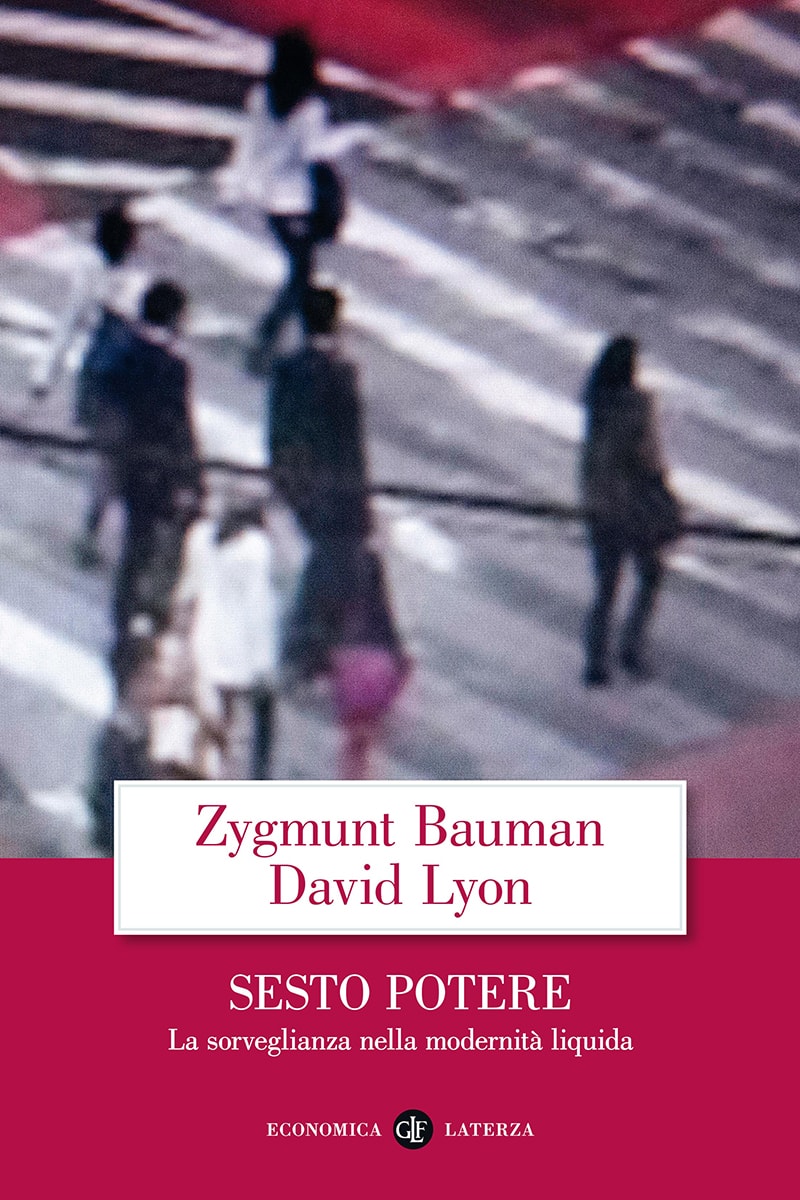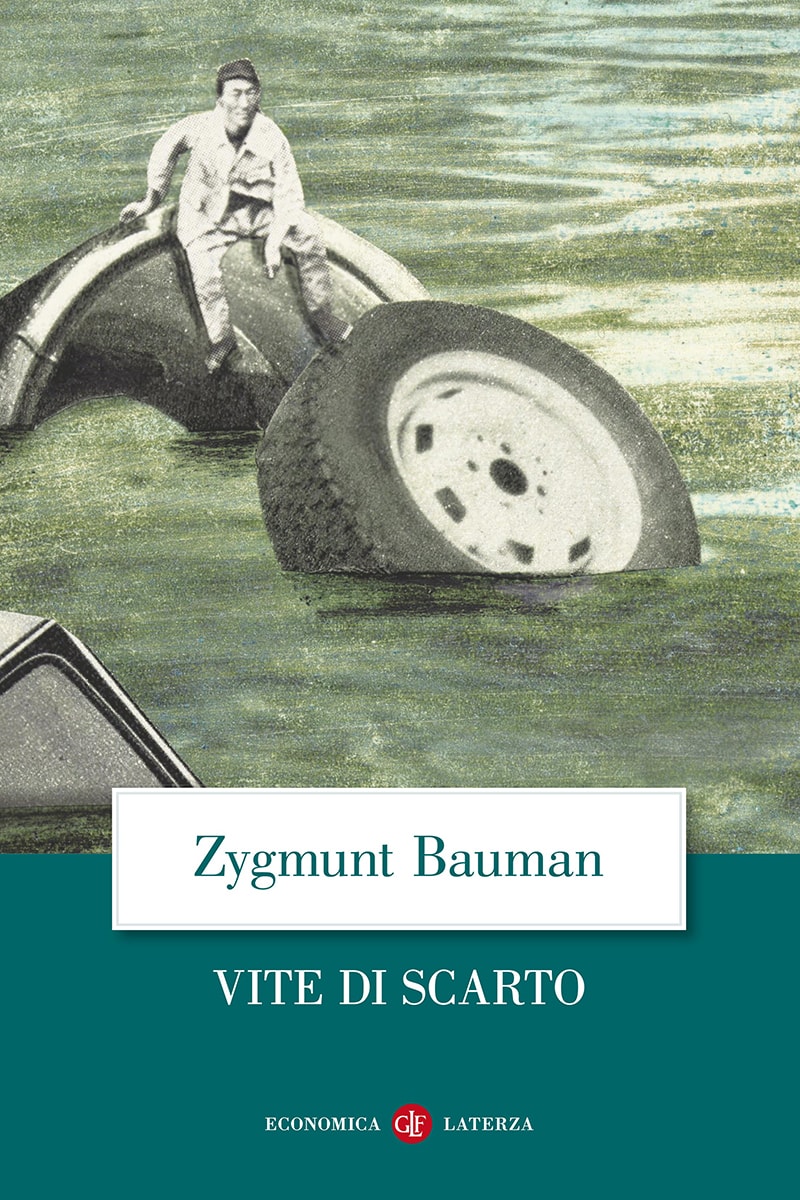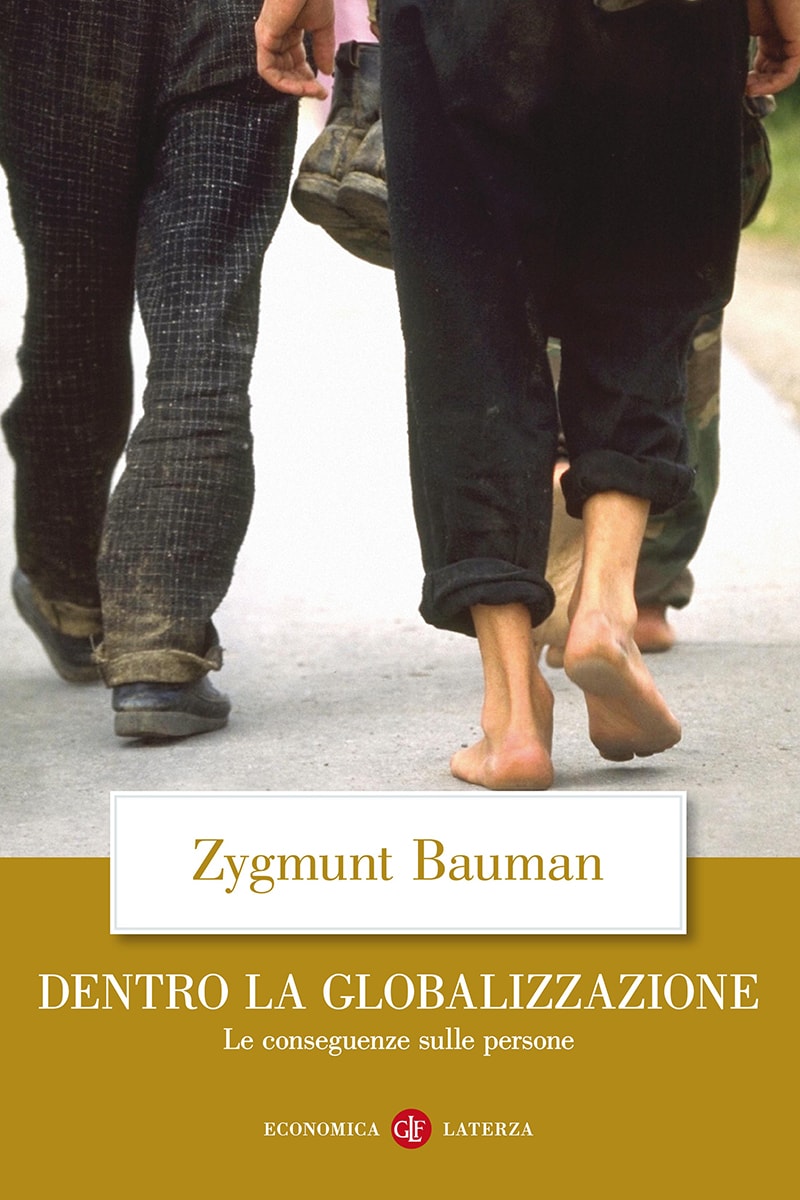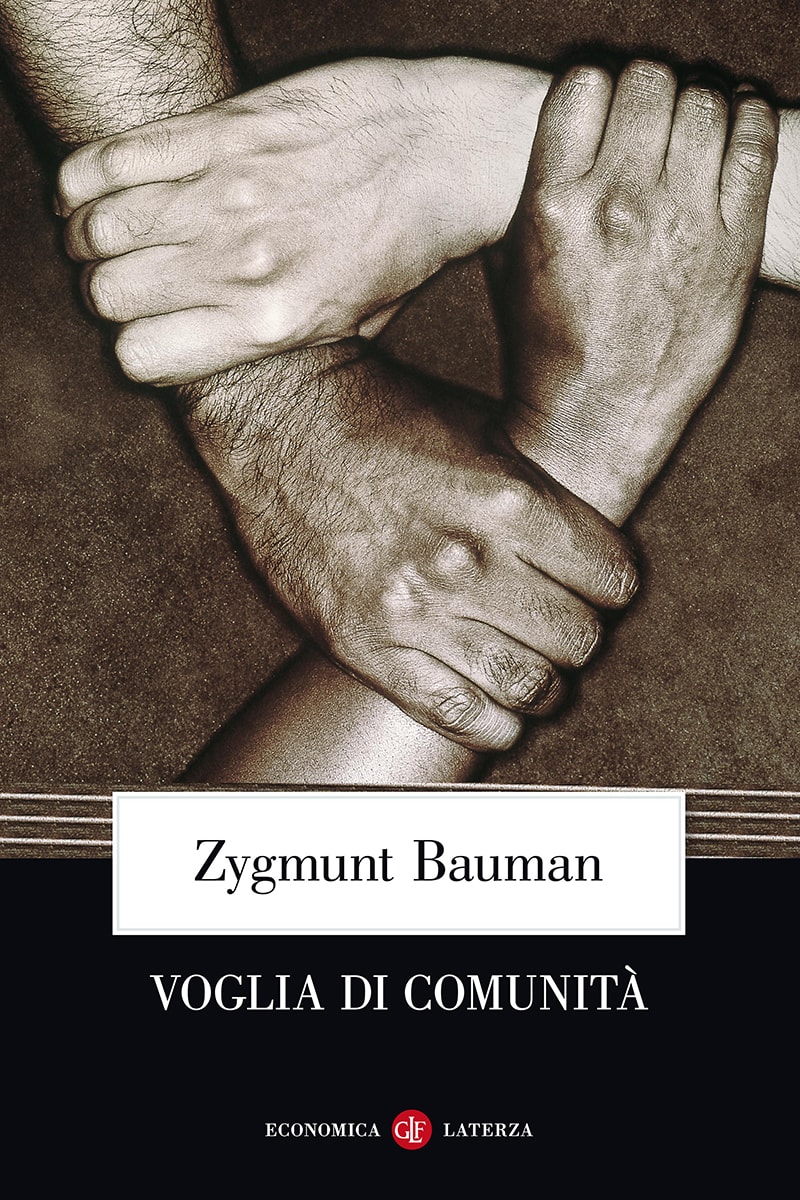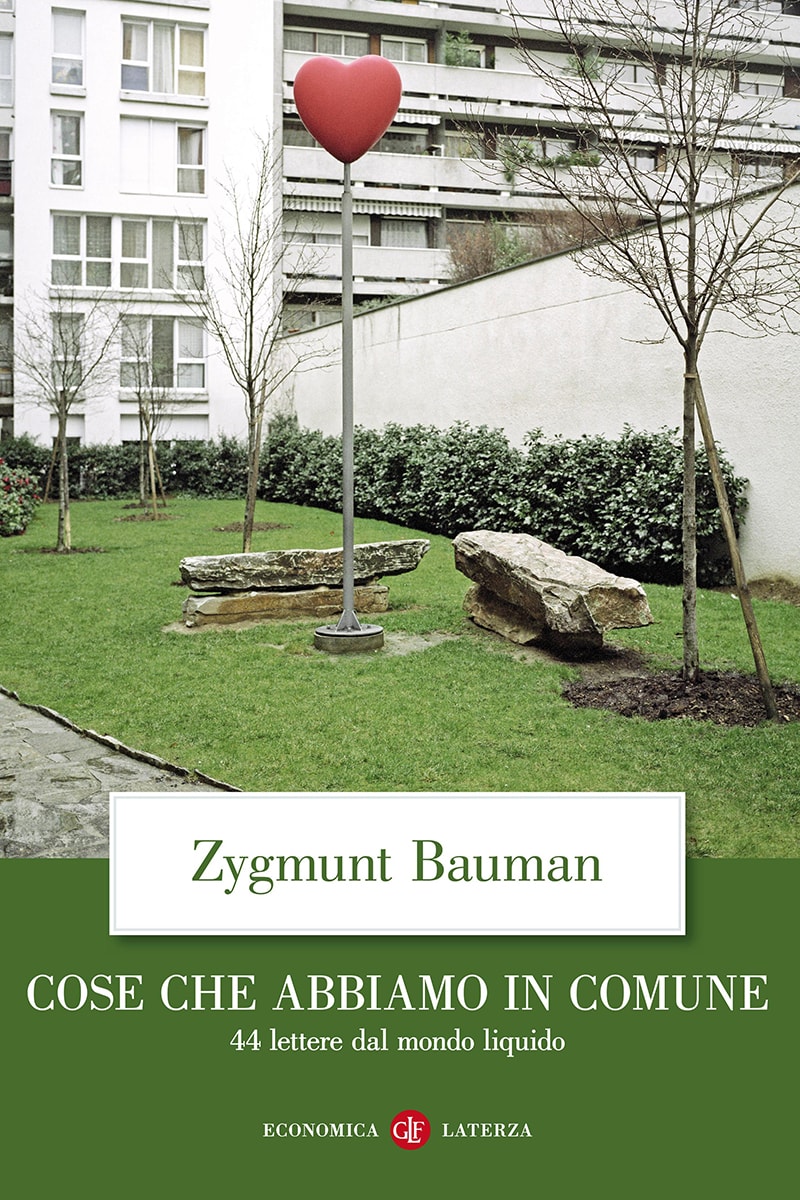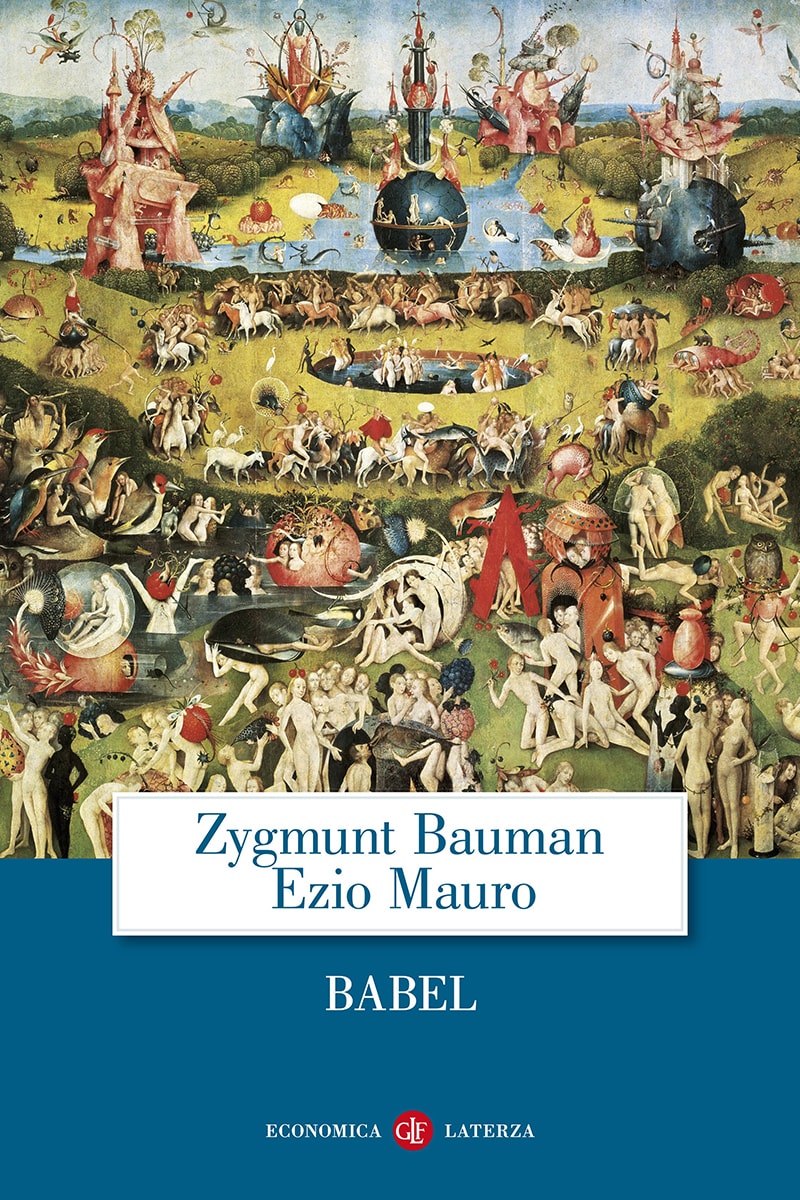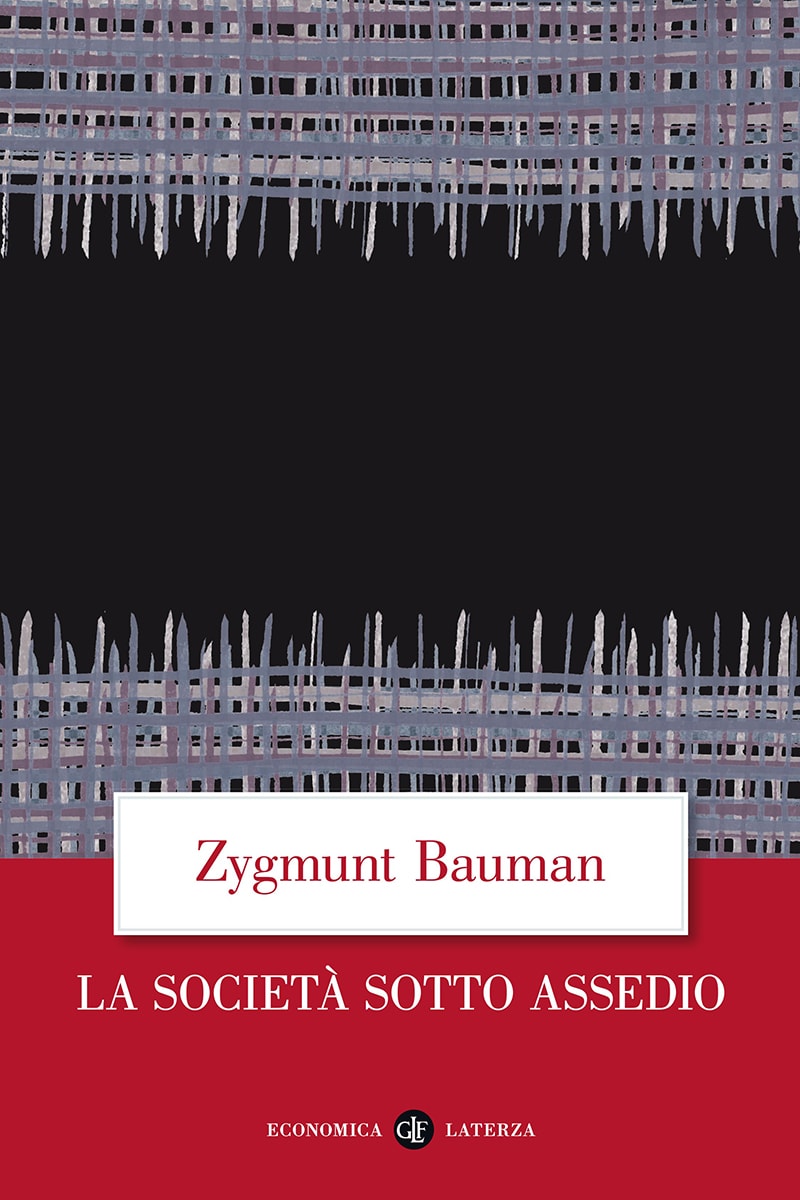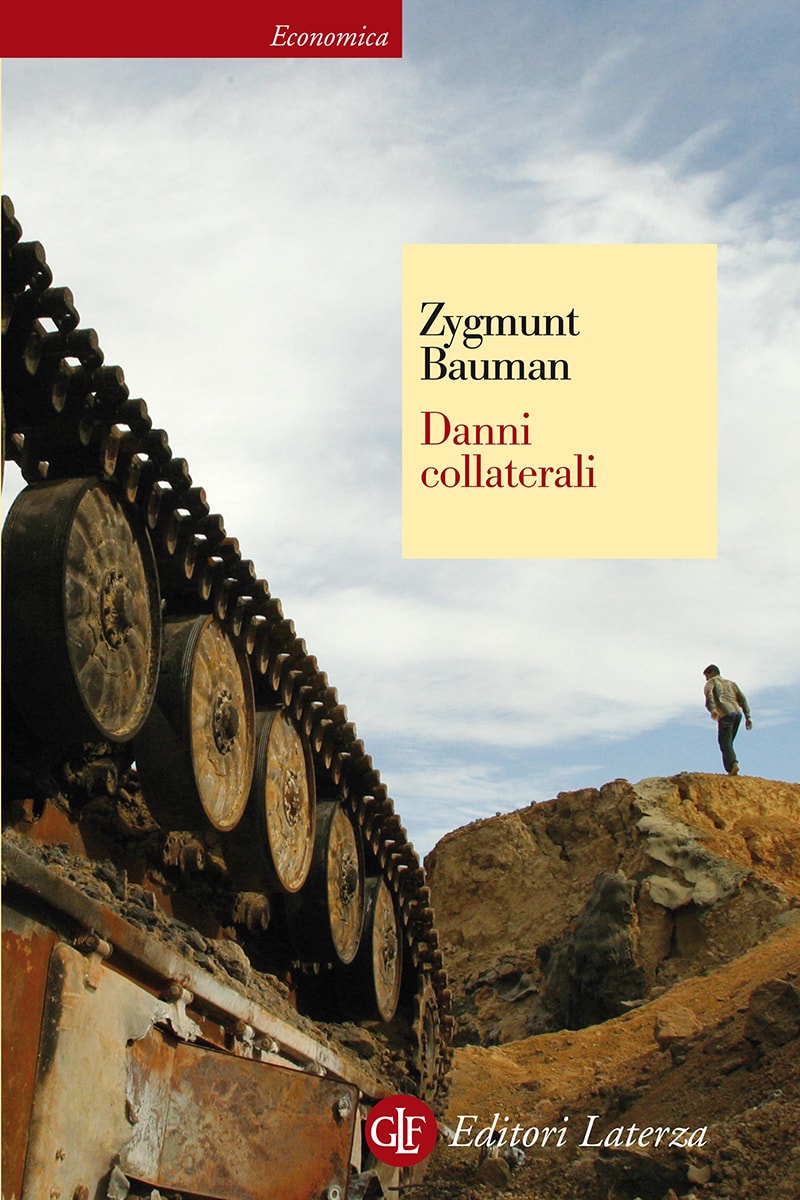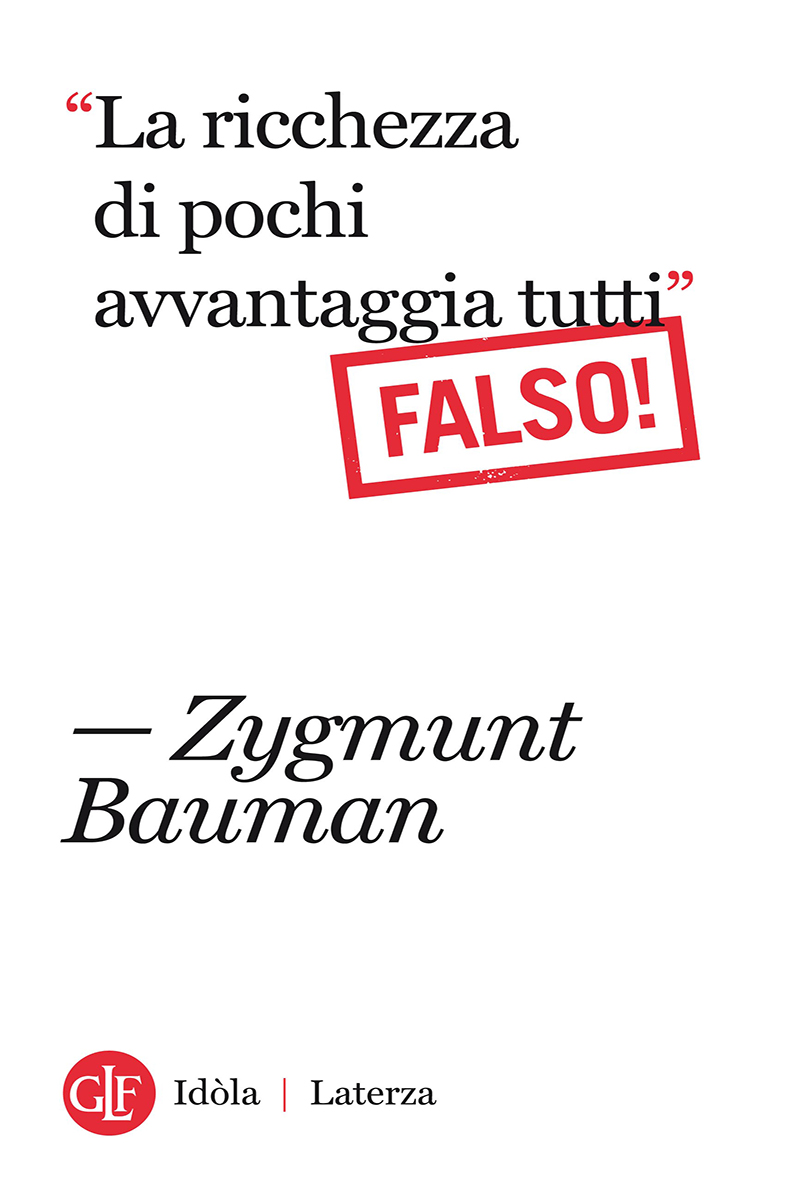Modus vivendi
Se vogliamo capire in che mondo viviamo e non sbagliare le mosse, interpretandolo con le categorie che abbiamo utilizzato in passato e che oggi non servono più, è opportuno leggere Modus vivendi di Zygmunt Bauman. Il libro è bellissimo. La condizione umana, dipinta come un inferno, invoca un’utopia che la possa riscattare. Umberto Galimberti
Con un libro folgorante, Zygmunt Bauman si conferma lucidissimo nelle sue analisi sul tipo di mondo nel quale ci è capitato di vivere. Corrado Augias
Modus vivendi è uno dei più bei libri scritti da Bauman. Lelio Demichelis, “Tuttolibri”
In questo saggio la modernità liquida è sinonimo di rapacità, e l’hobbesiano homo homini lupus si ripresenta al centro della scena. L’analisi di Bauman è cupa e tuttavia condita da una buona dose d’ironia. Benedetto Vecchi, “il manifesto”