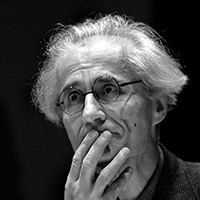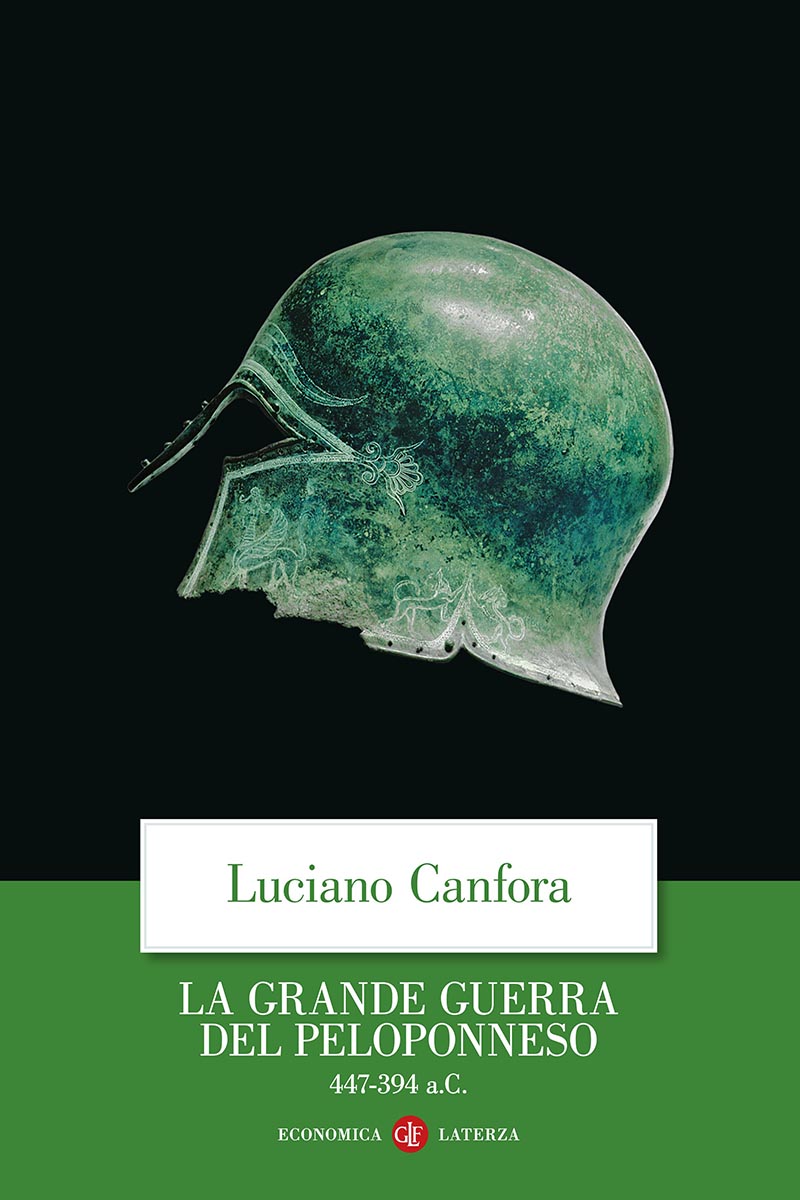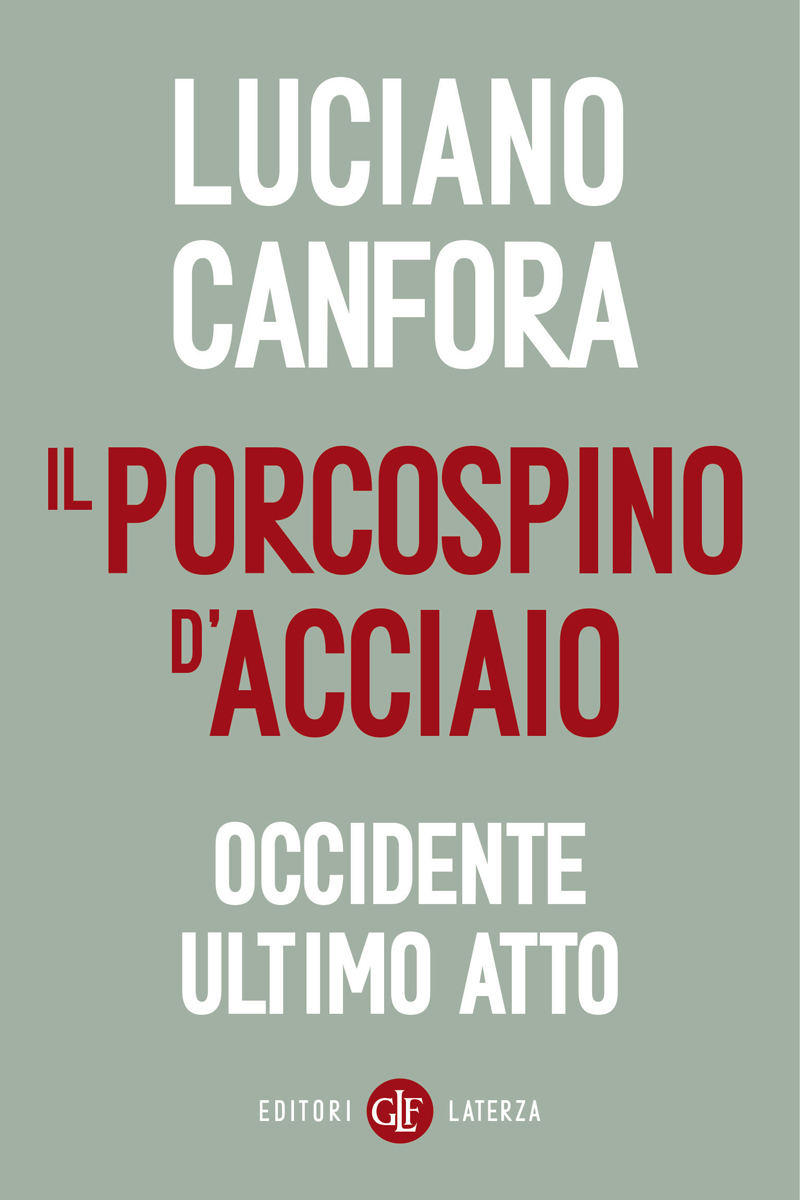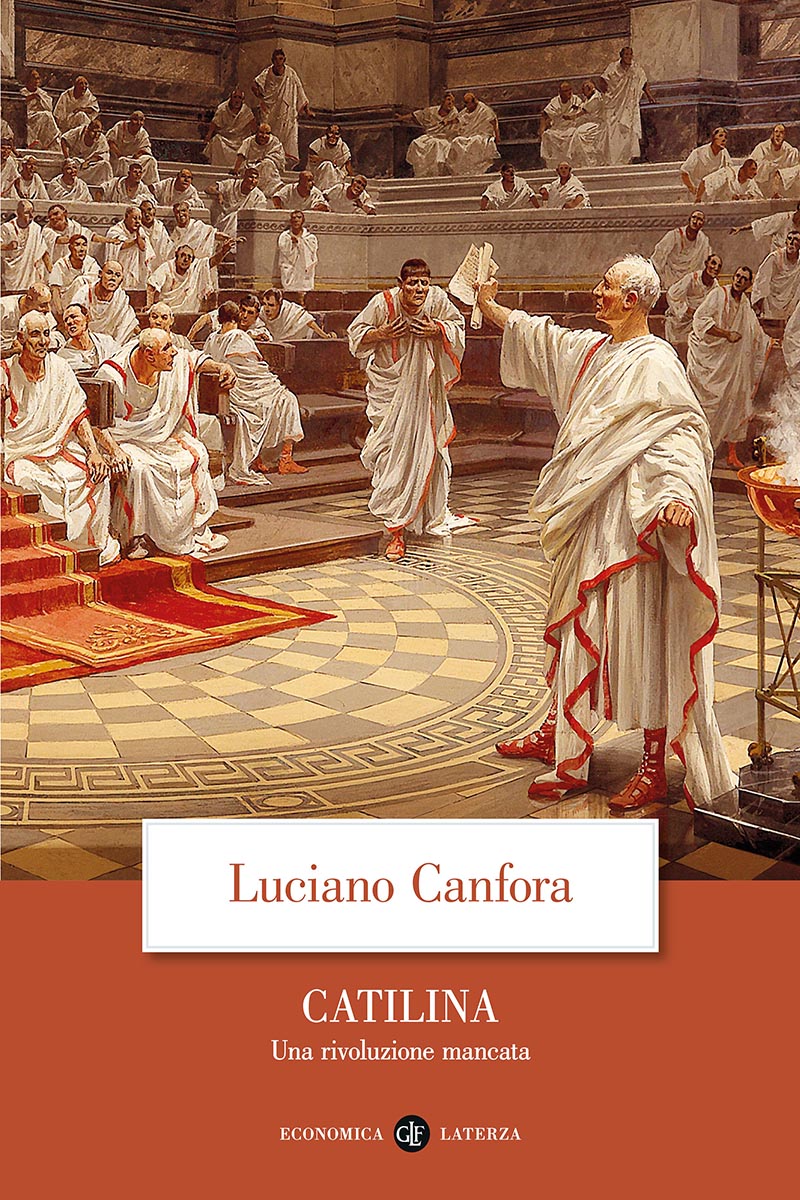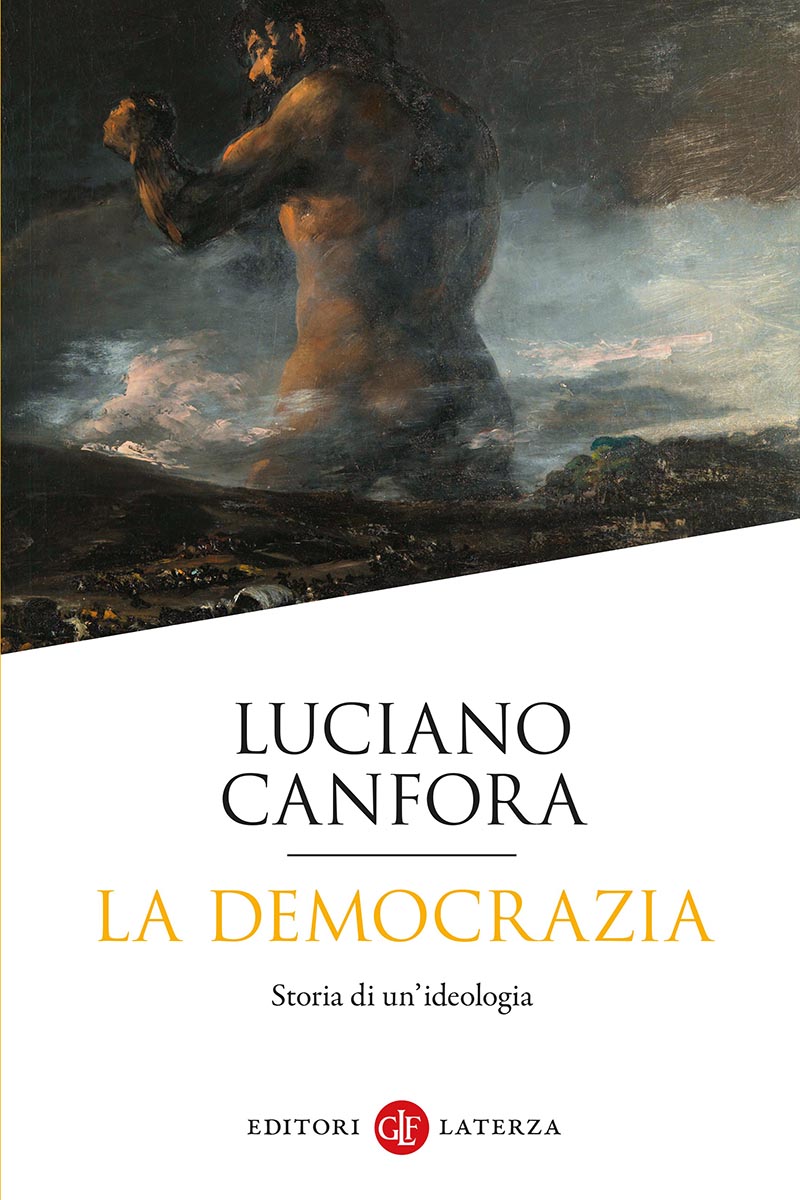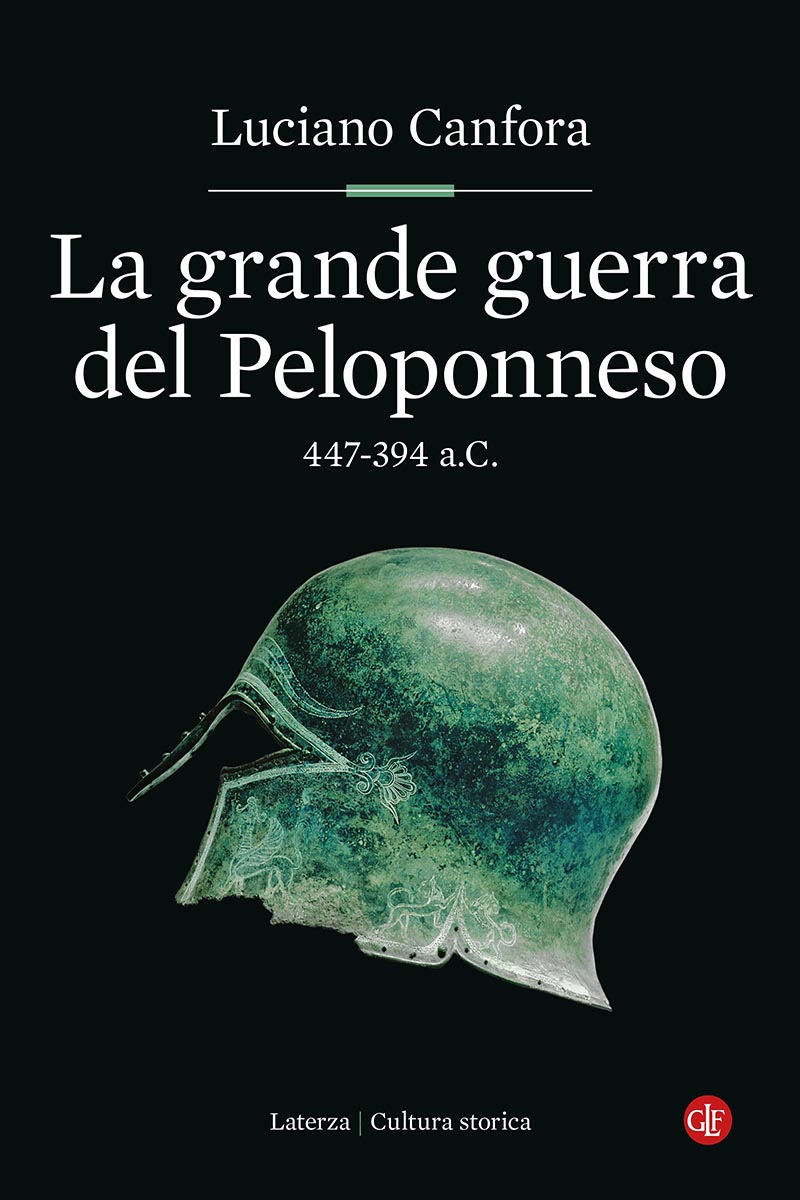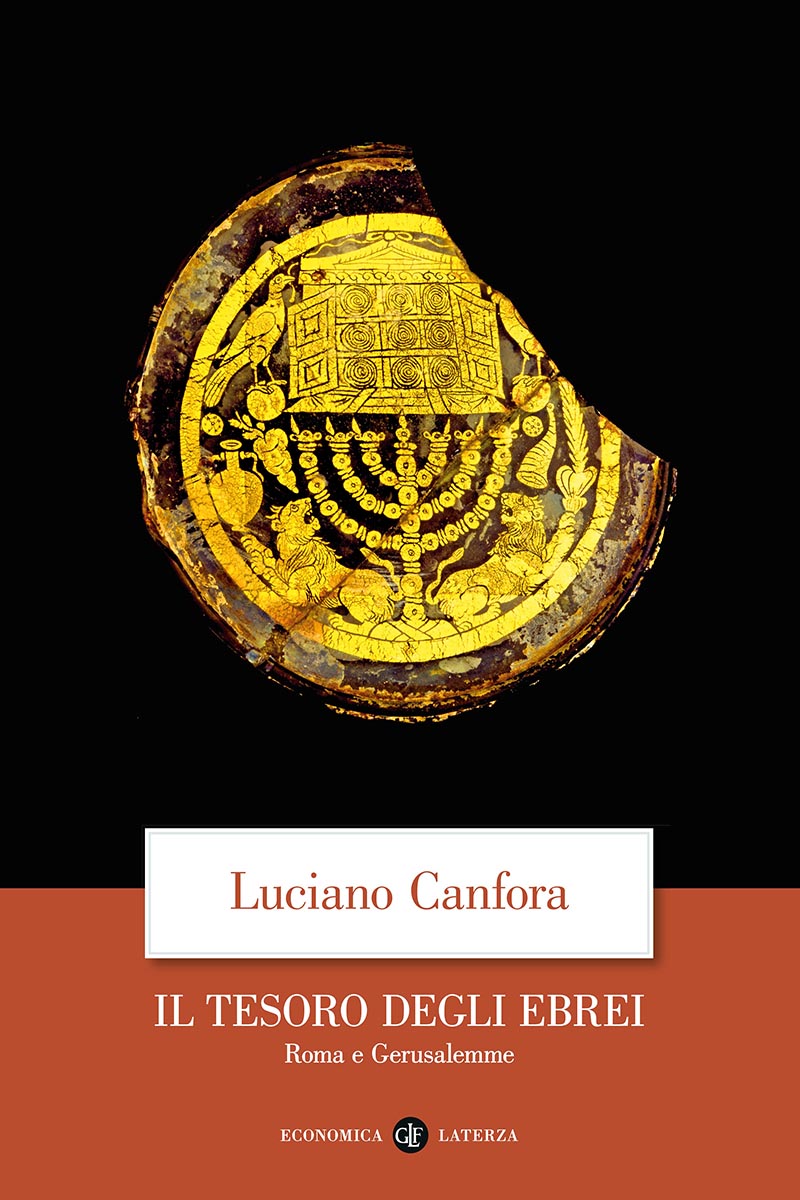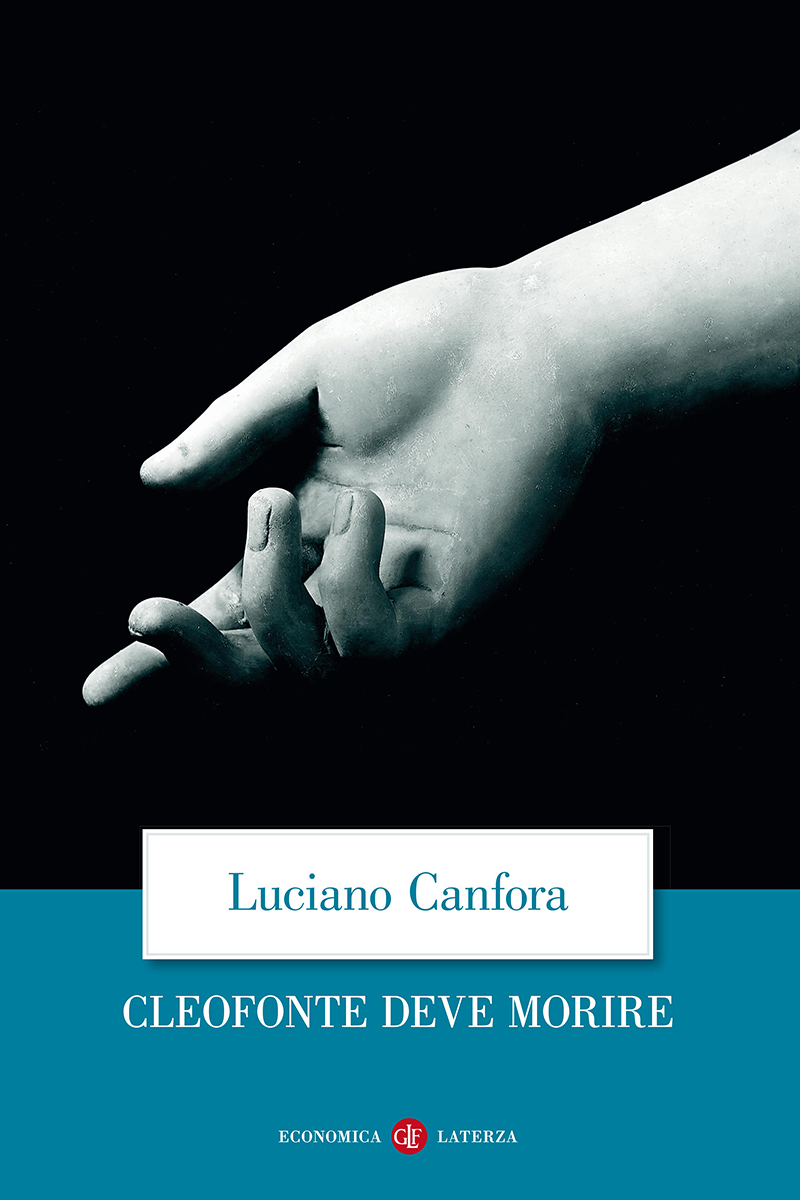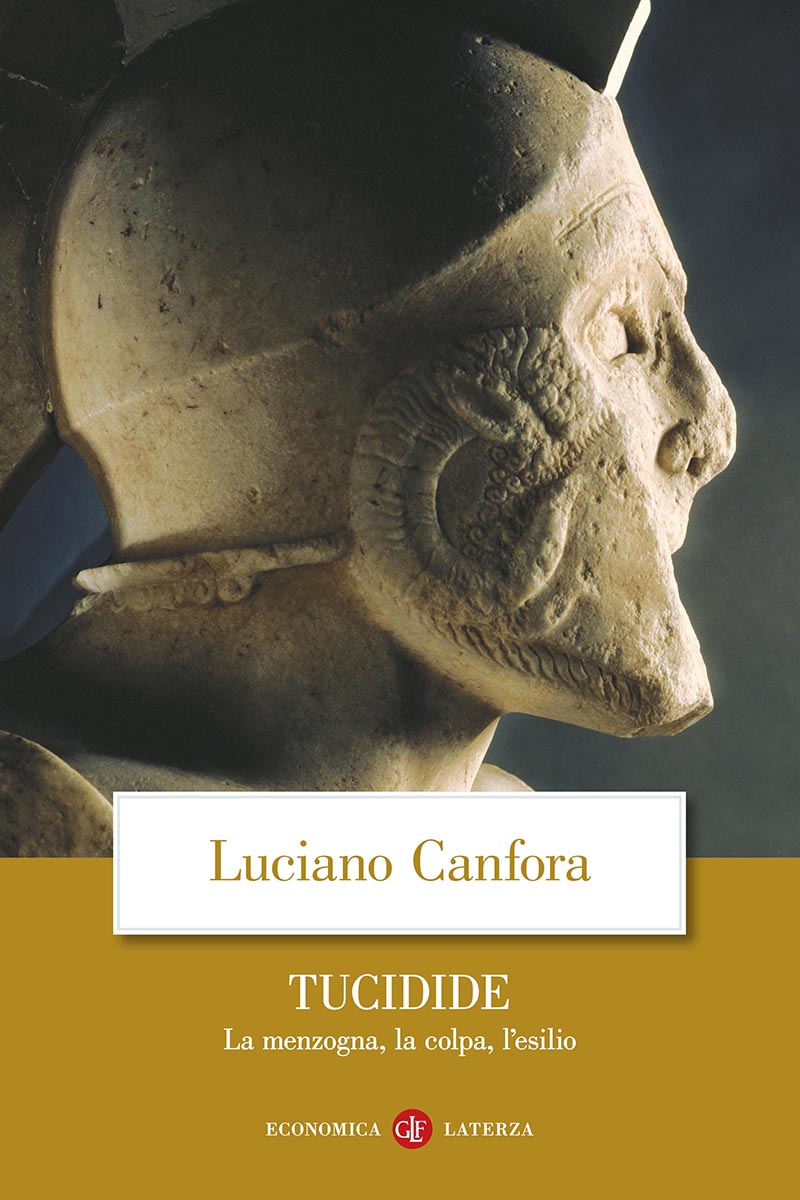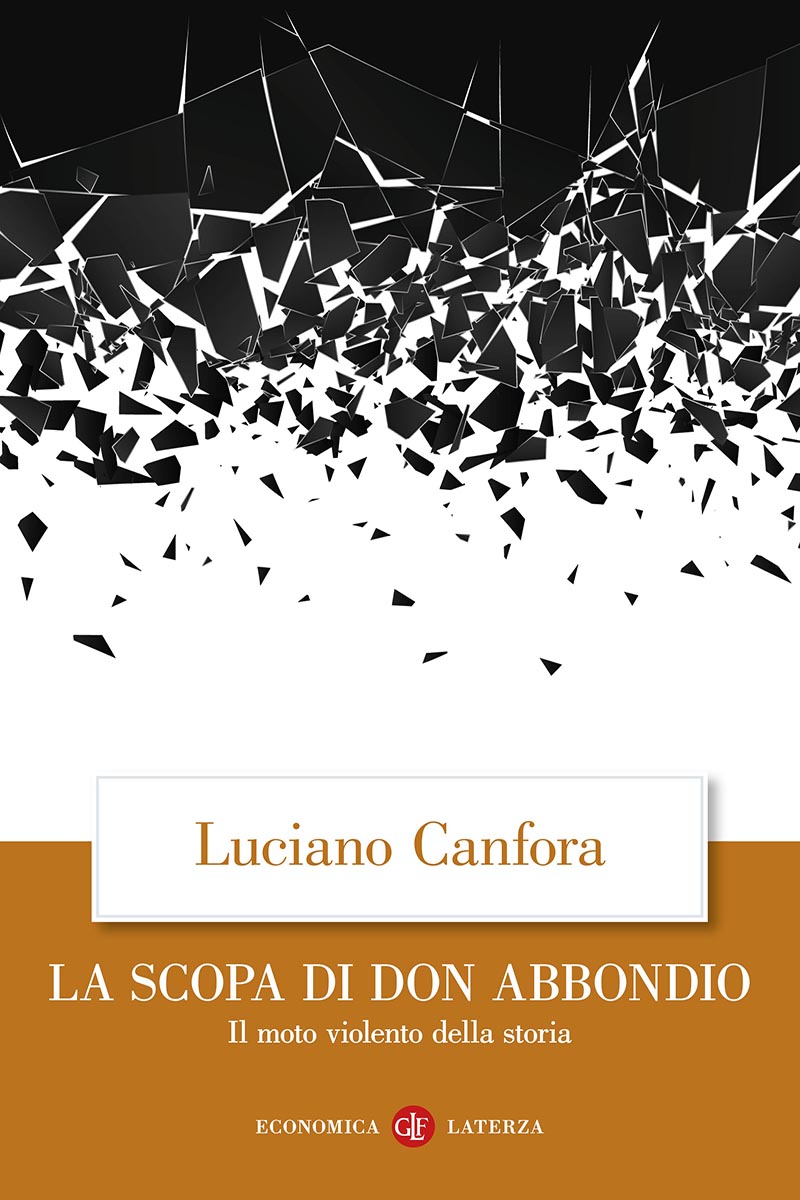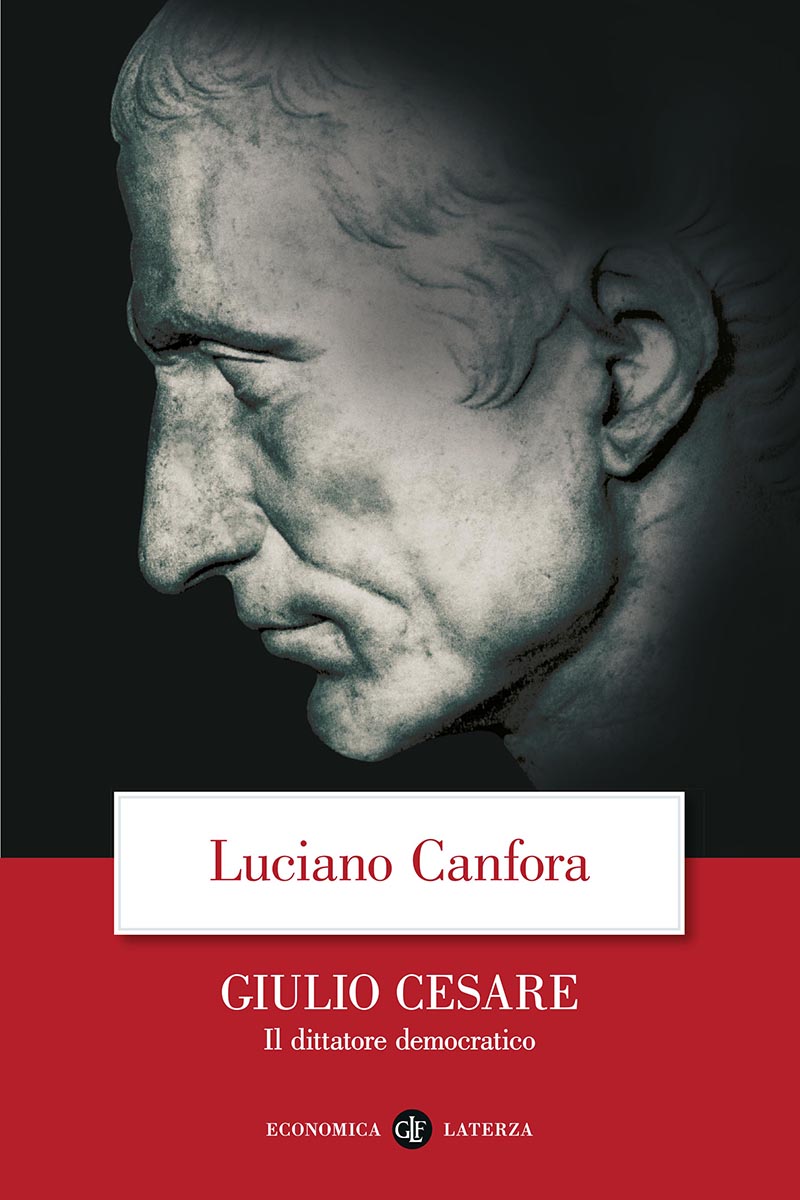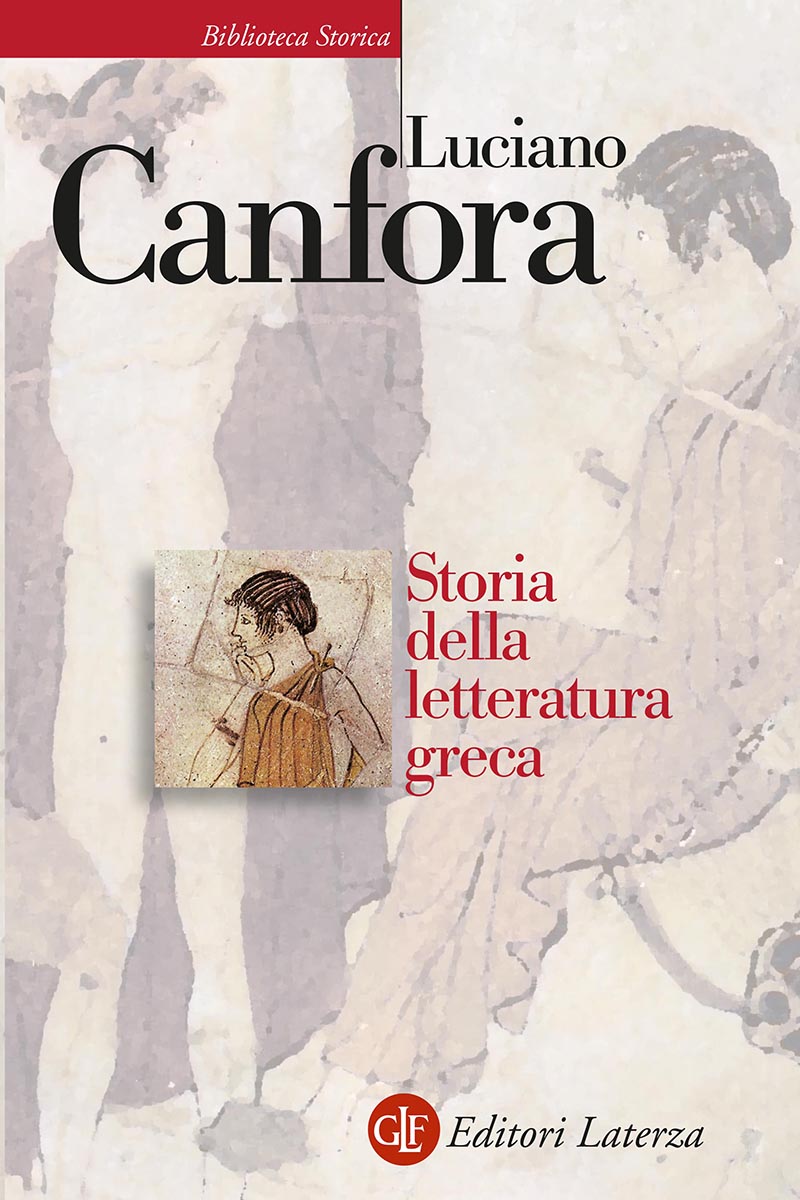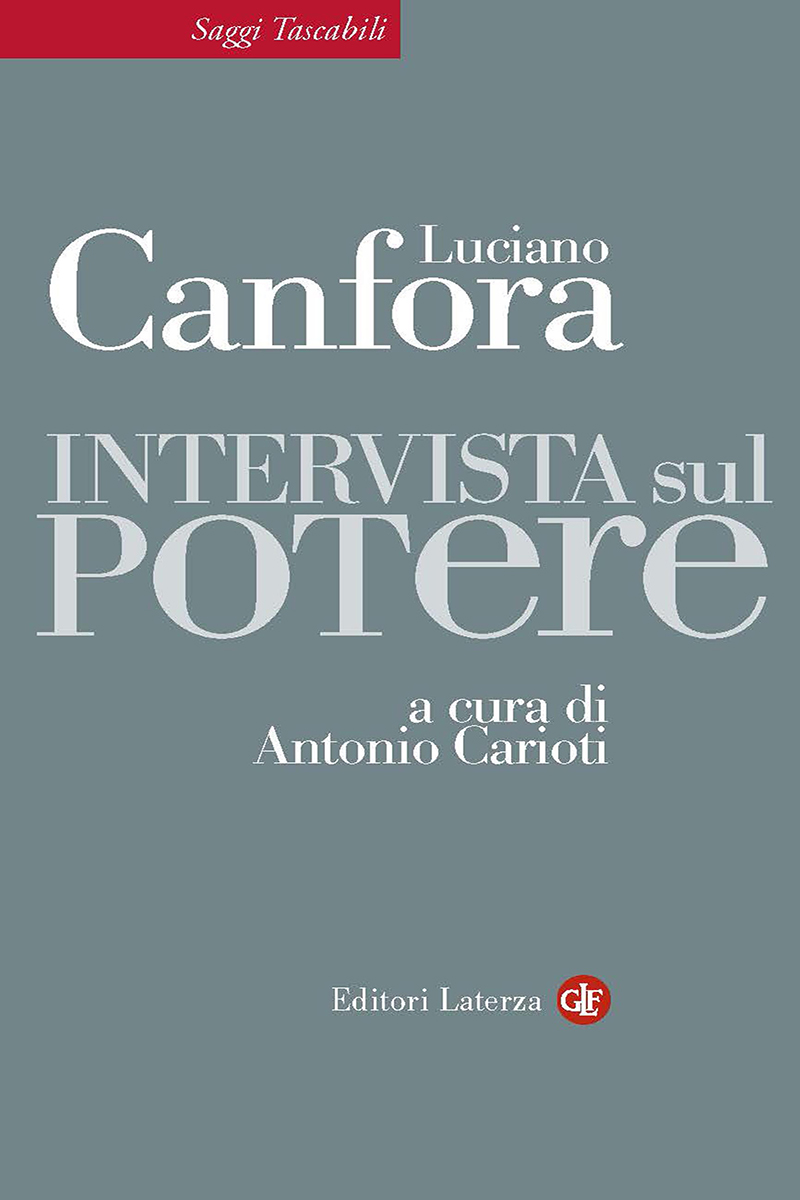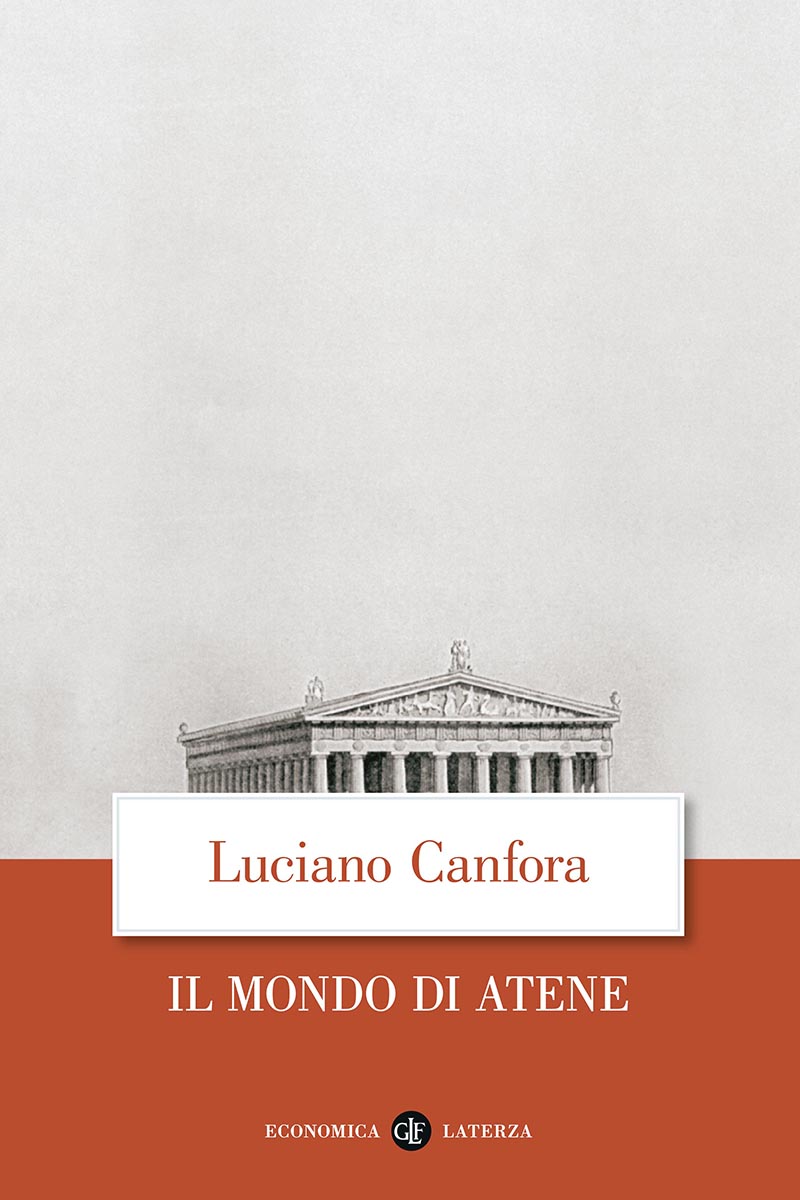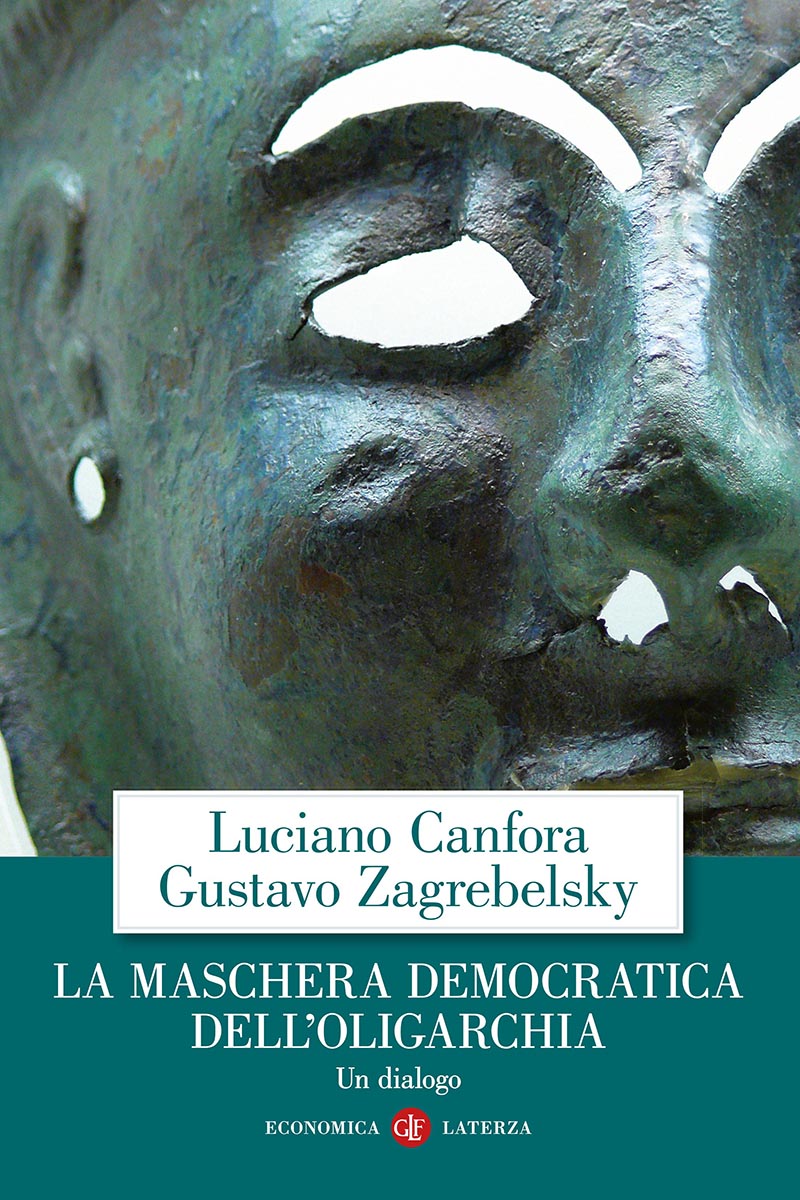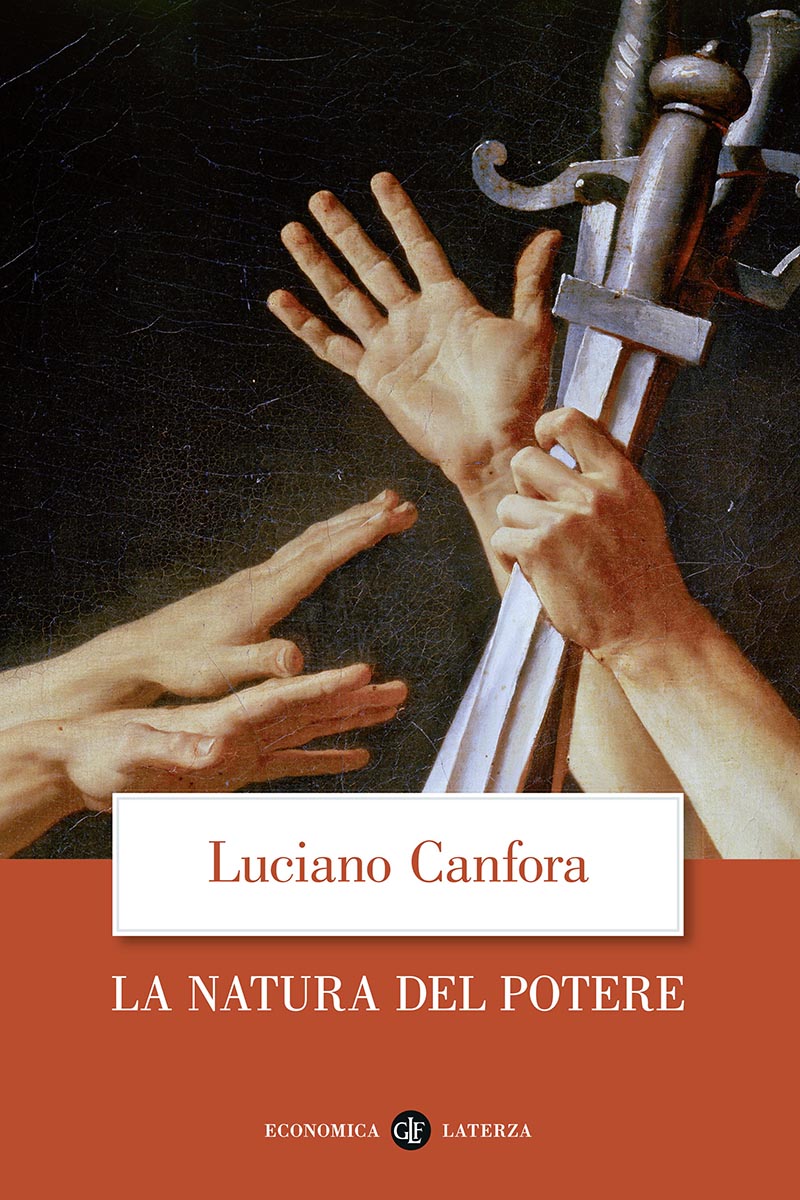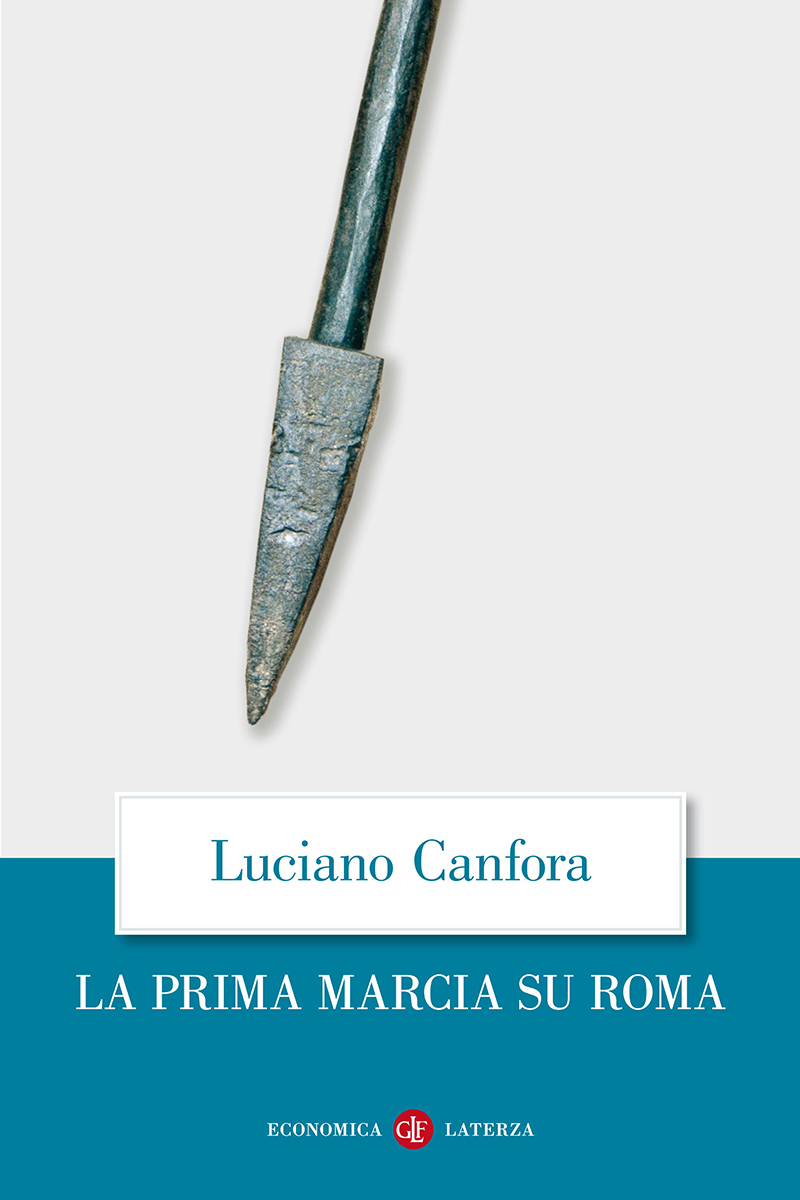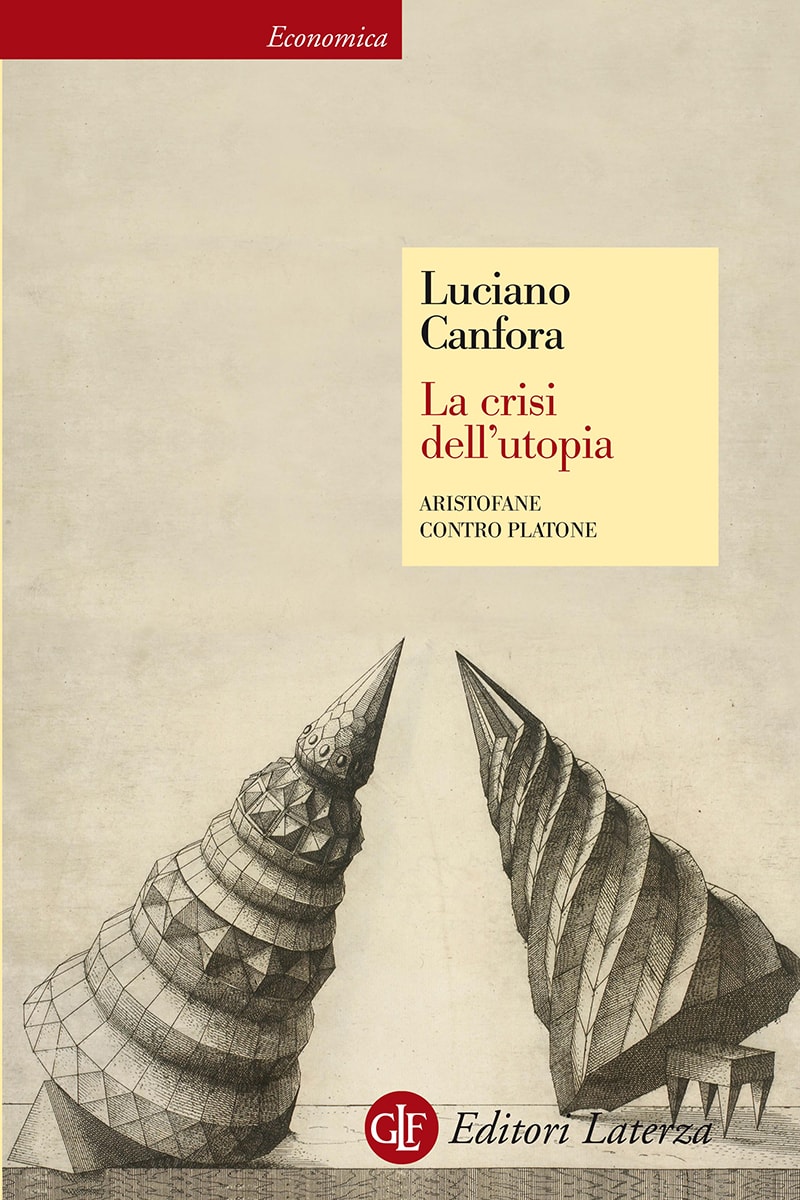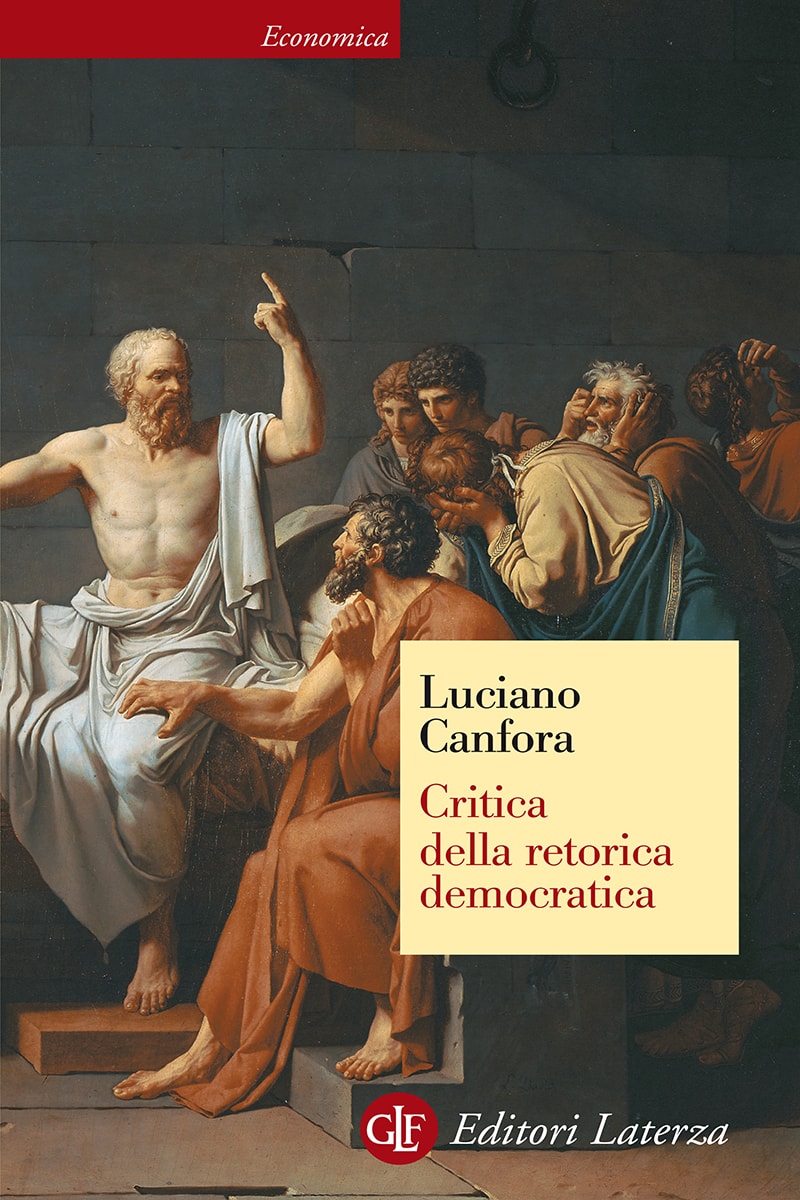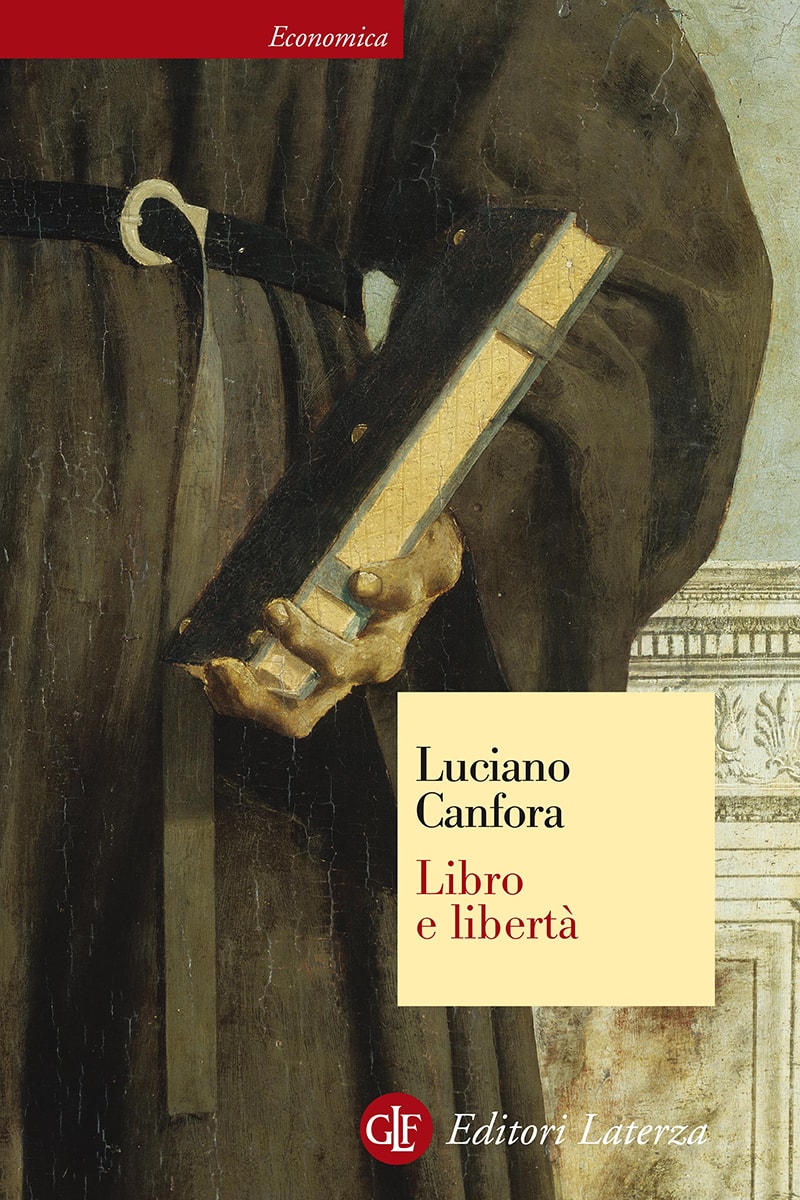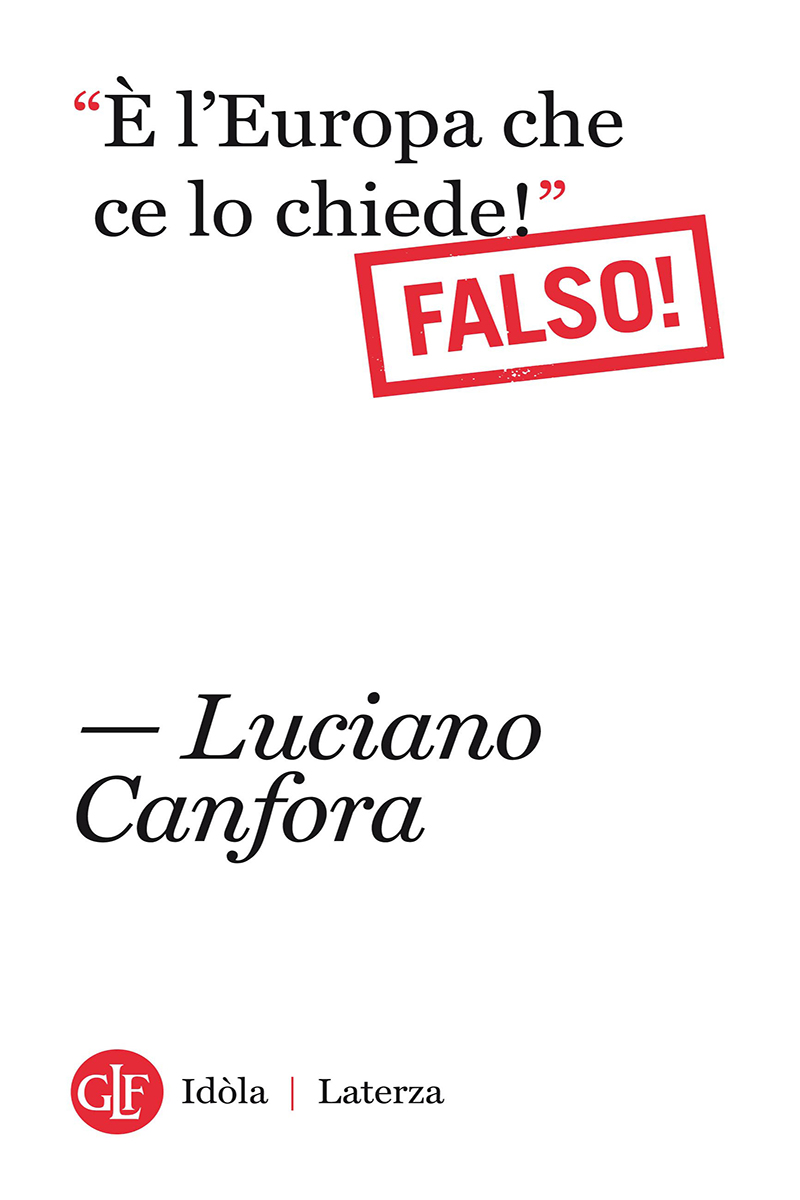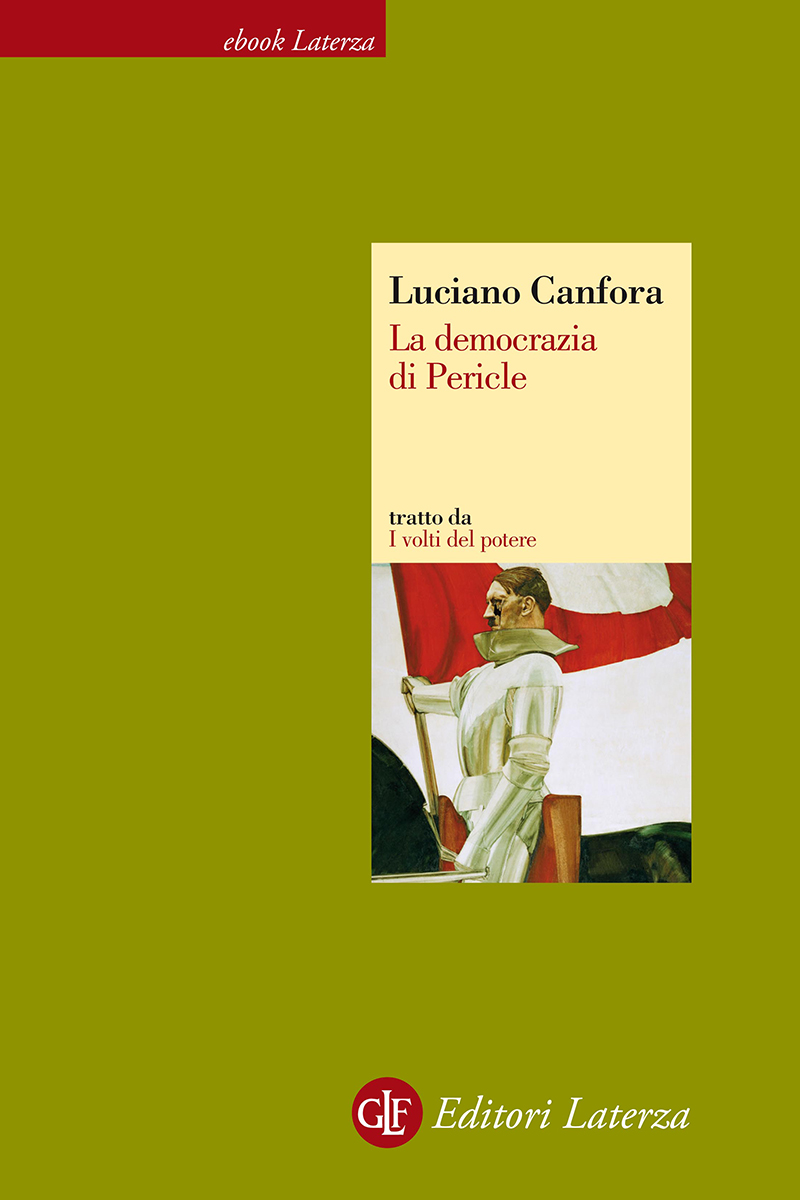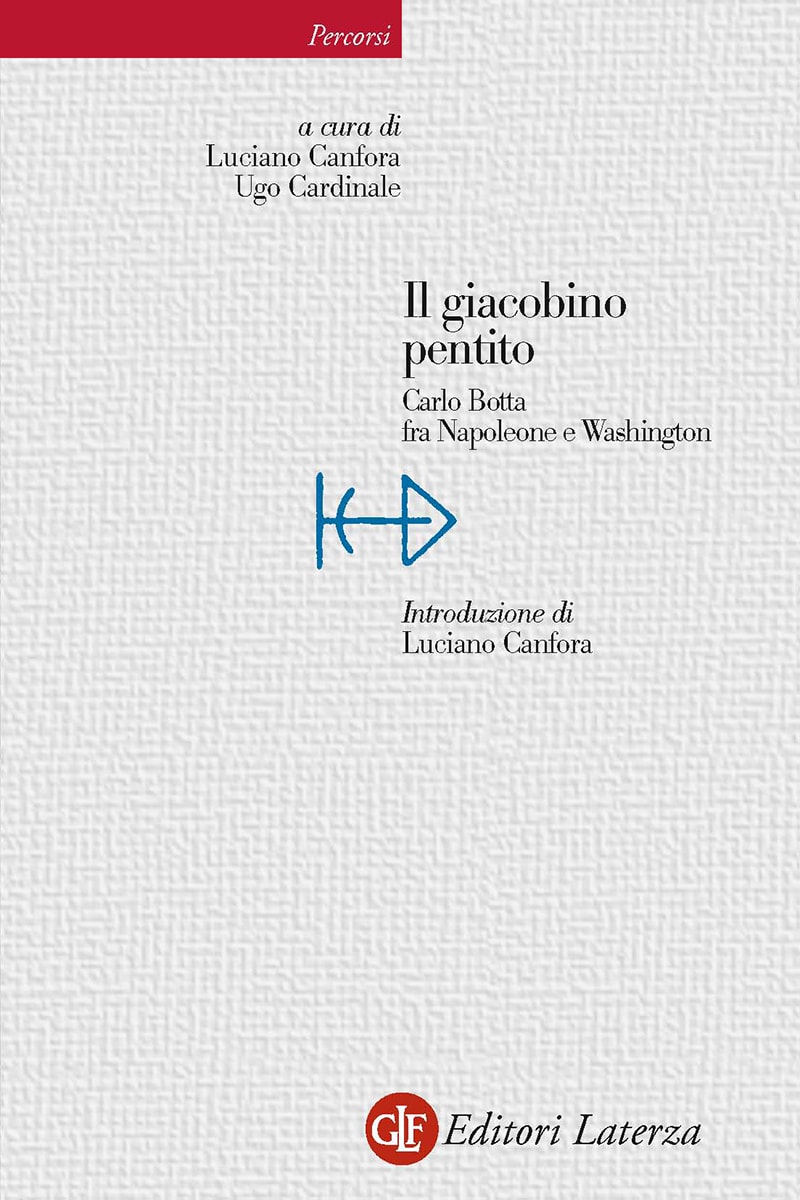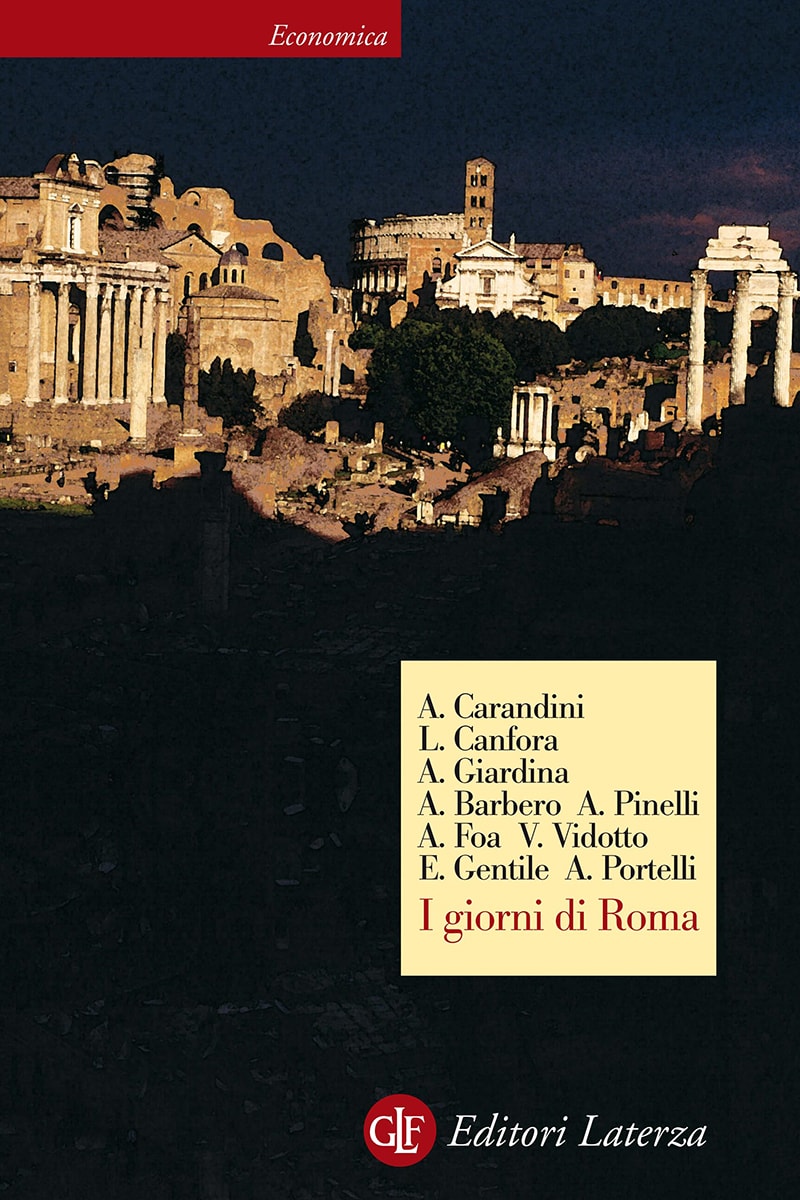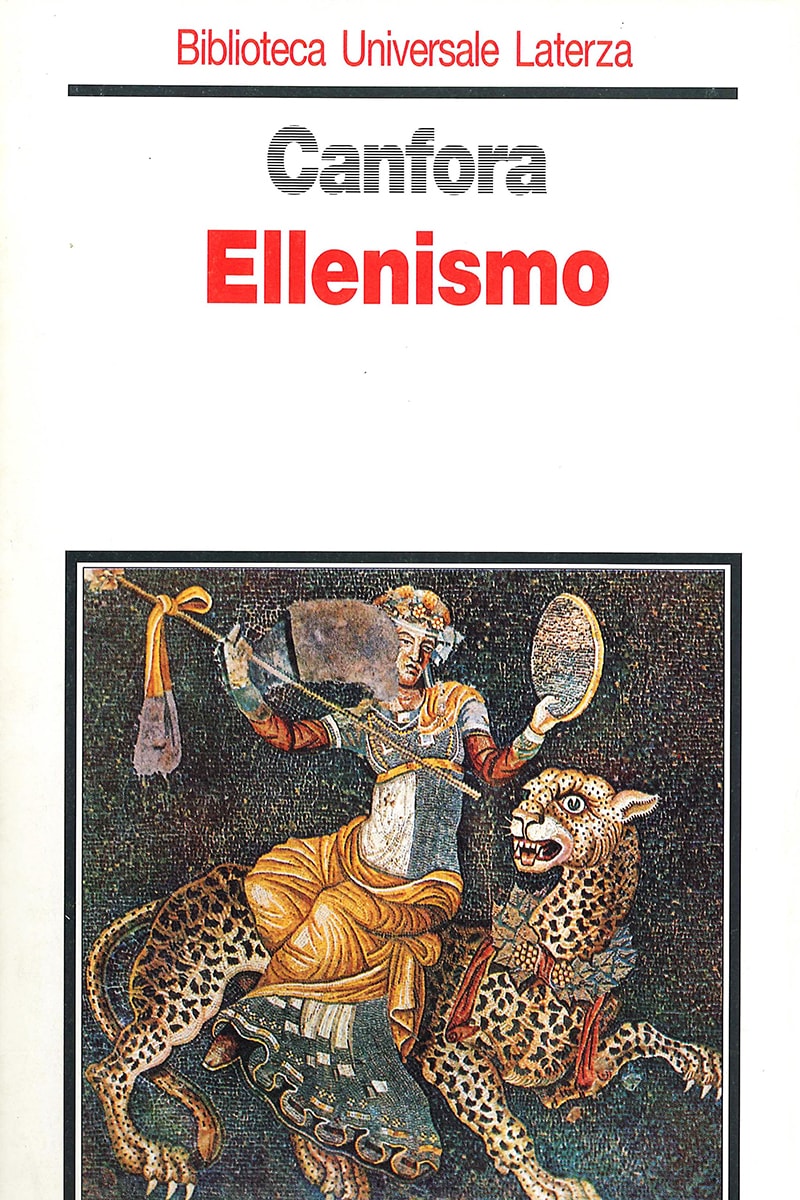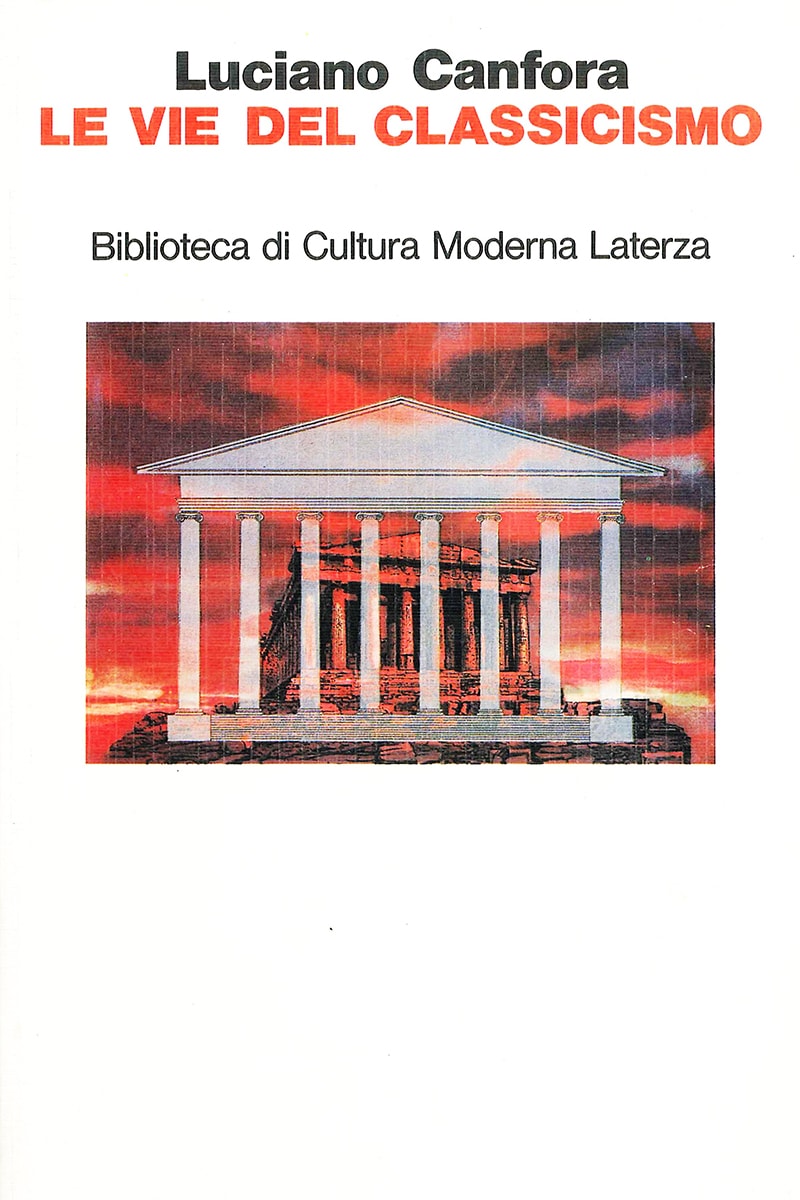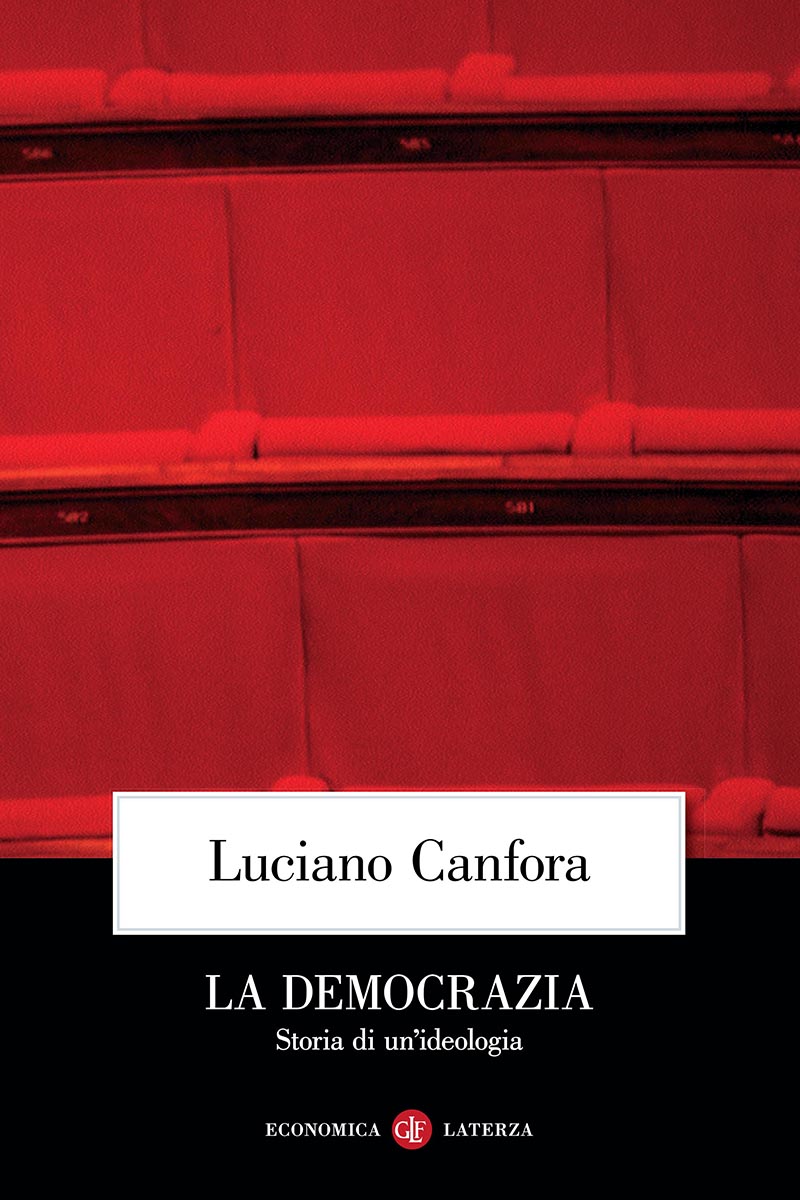
Pagine: 452
Collana: Economica Laterza [464]
ISBN carta: 9788842086352
ISBN digitale: 9788858103647
Argomenti: Storia d'Europa
La democrazia
Luciano Canfora riapre la fondamentale questione del rapporto tra libertà e democrazia. Questo libro coglie il carattere «inquietante» e «terribile» della libertà. Giulio Giorello, “Corriere della Sera – Magazine”
Pochi studiosi hanno, in Italia, la fortuna di unire in sé l’erudizione e la verve: Luciano Canfora è uno di essi, con in più una vena di polemica che rende la sua scrittura sempre sapida e stimolante. Con La democrazia non resteremo delusi: l’autore dà il meglio di sé. Angelo d’Orsi, “Tuttolibri”
«Nel mondo ricco ha vinto la libertà. Con le immani conseguenze che questo comporta. La democrazia è rinviata ad altre epoche.» La tesi radicale di Canfora reinterpreta la storia d’Europa e demolisce un preconcetto della nostra cultura politica.
Pagine: 452
Collana: Economica Laterza
ISBN: 9788842086352