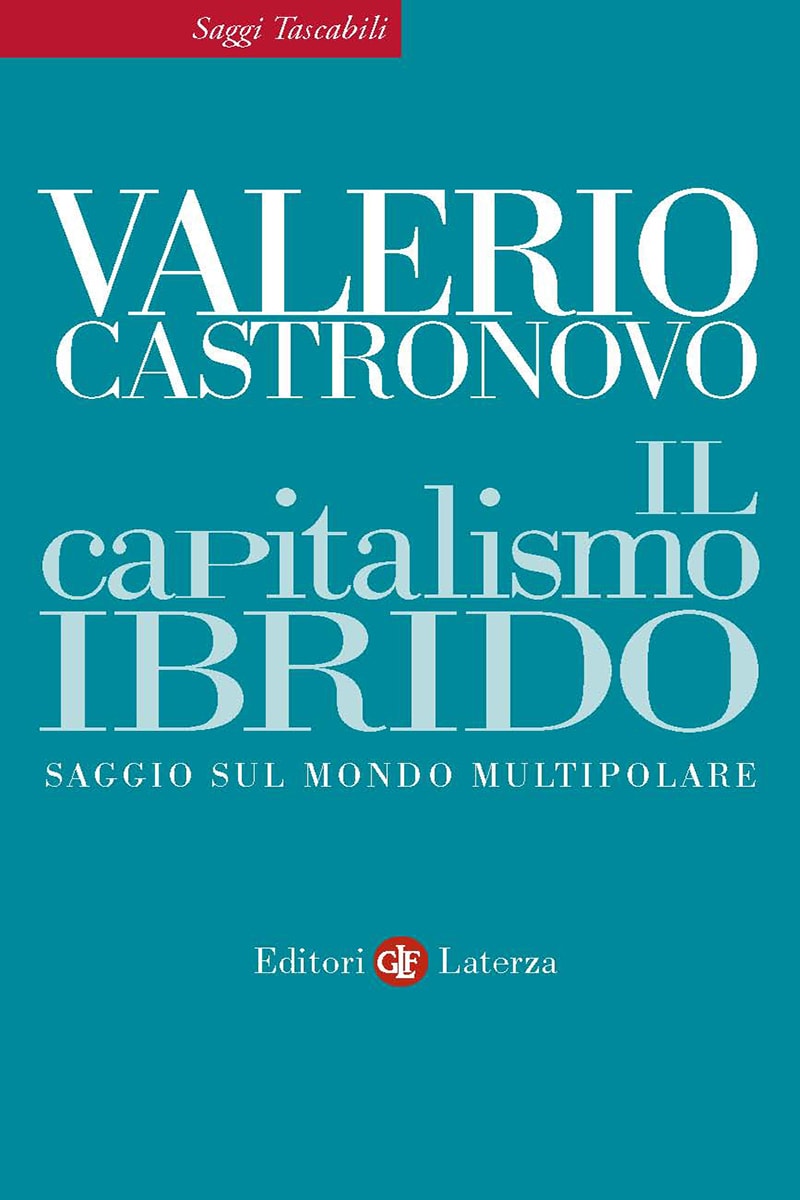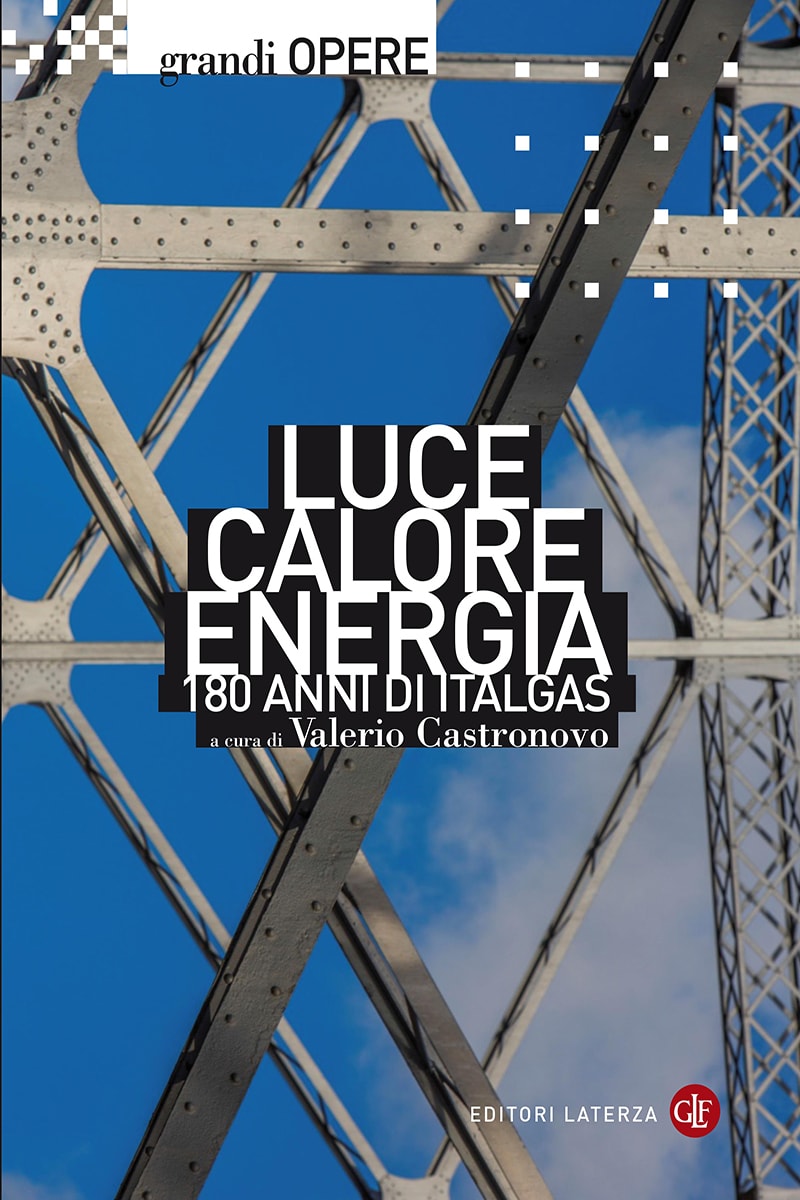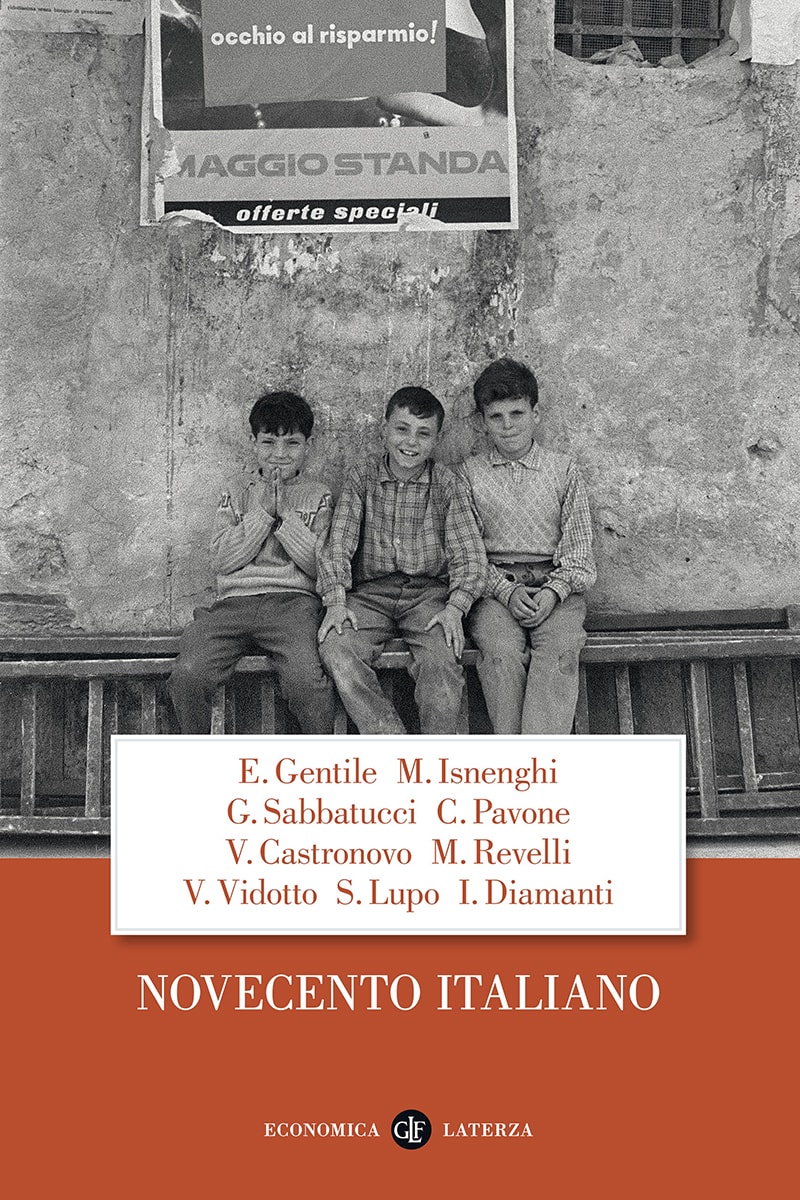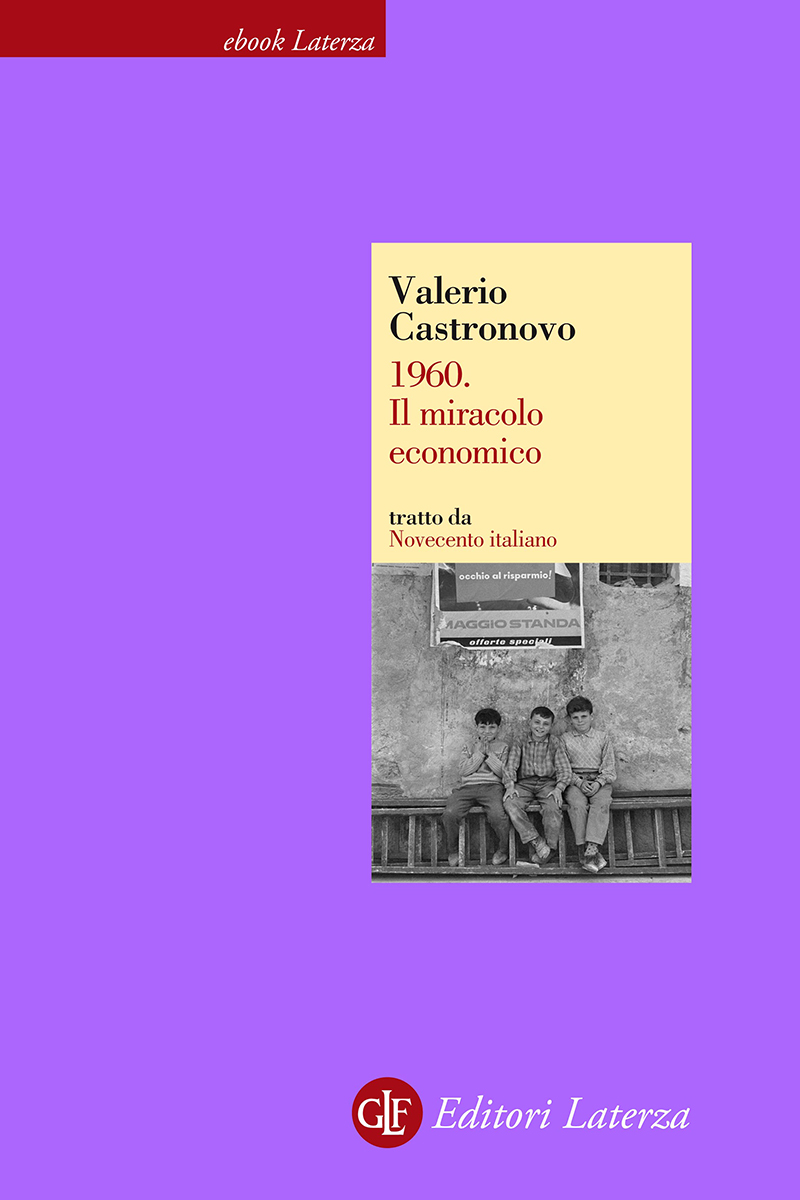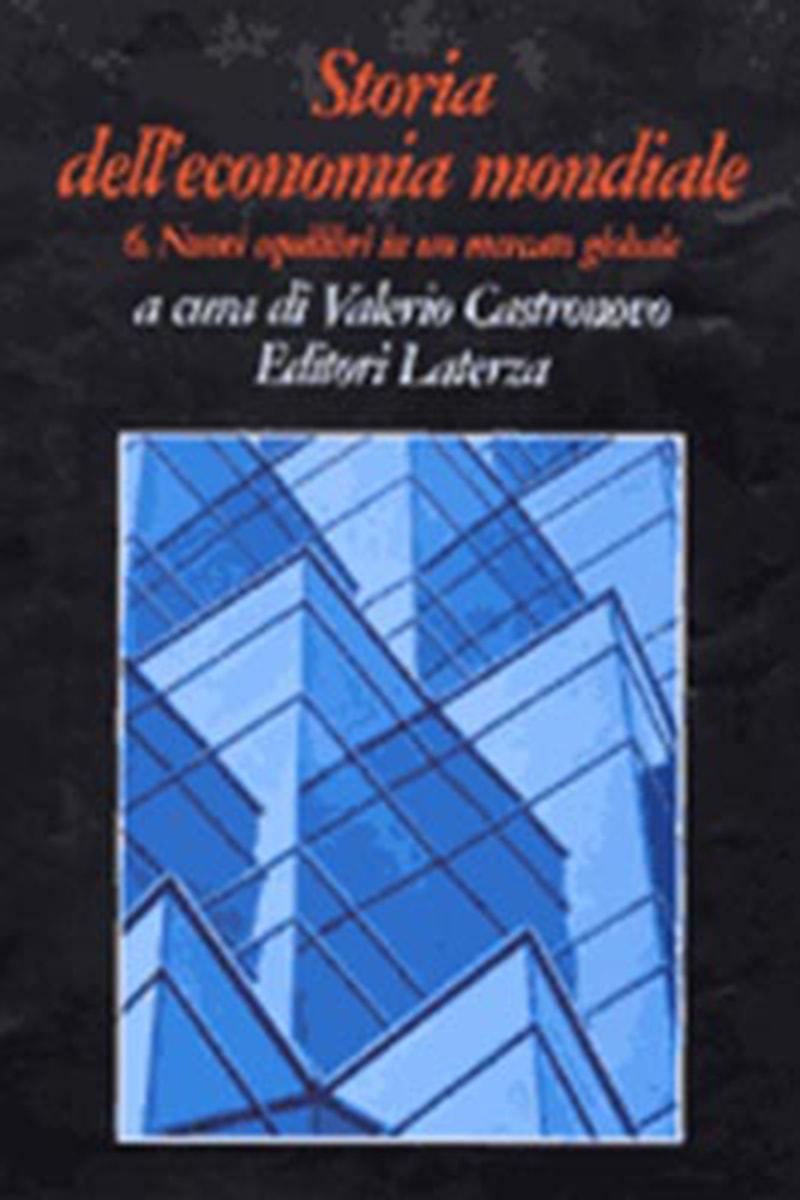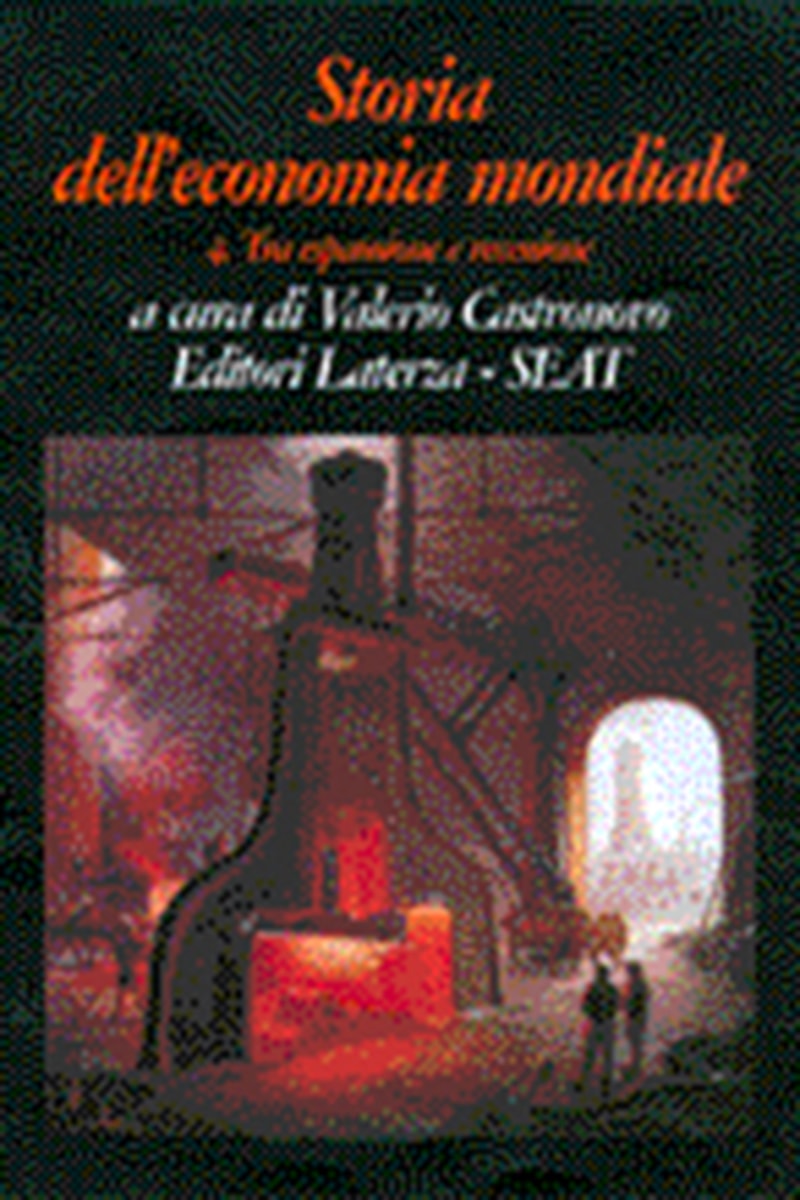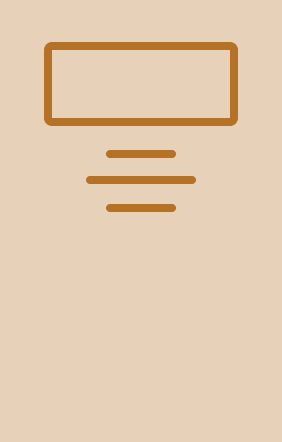Il capitalismo ibrido
Oggi ci troviamo in presenza di una sorta di capitalismo al plurale, con un’impronta marcatamente finanziaria e transnazionale, e dai connotati ibridi ed eterogenei. Non sono più gli Stati Uniti e l’Europa, insieme al Giappone, a segnare le direttrici di marcia del mercato globale, ma anche, e con un passo sempre più spedito, la superpotenza cinese e nuovi paesi emergenti come l’India e il Brasile, affiancati dalla risorgente Russia, dalla Corea del Sud, dalla Turchia e dal Sudafrica. Si tratta ora di vedere se questo universo economico multipolare darà luogo a un processo di sviluppo sostenibile e socialmente responsabile e asseconderà un’evoluzione delle istituzioni politiche; o non finirà piuttosto per formare un arcipelago di nuove élites oligarchiche e di nuove derive nazionalistiche.
Rassegna stampa
-
Il capitalismo ibrido
Sarà l'elefante indiano a mettere le ali alla crescita
di Mario Deaglio