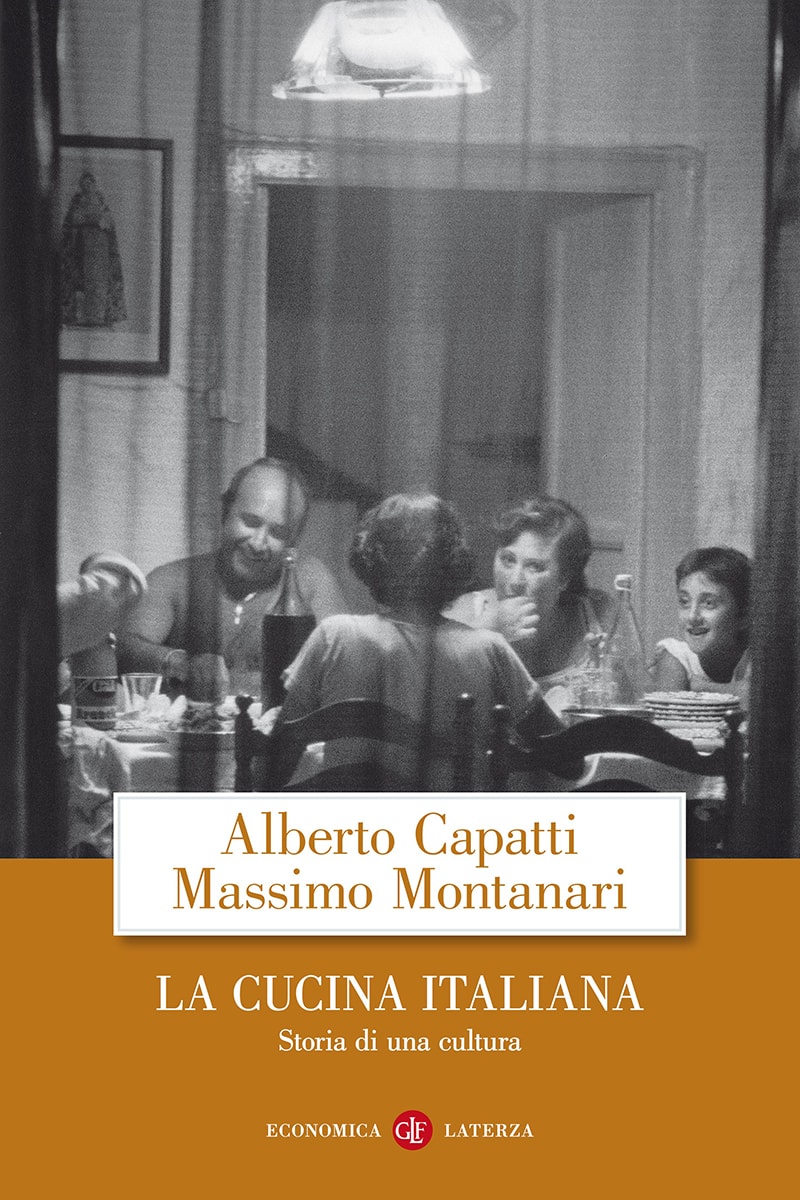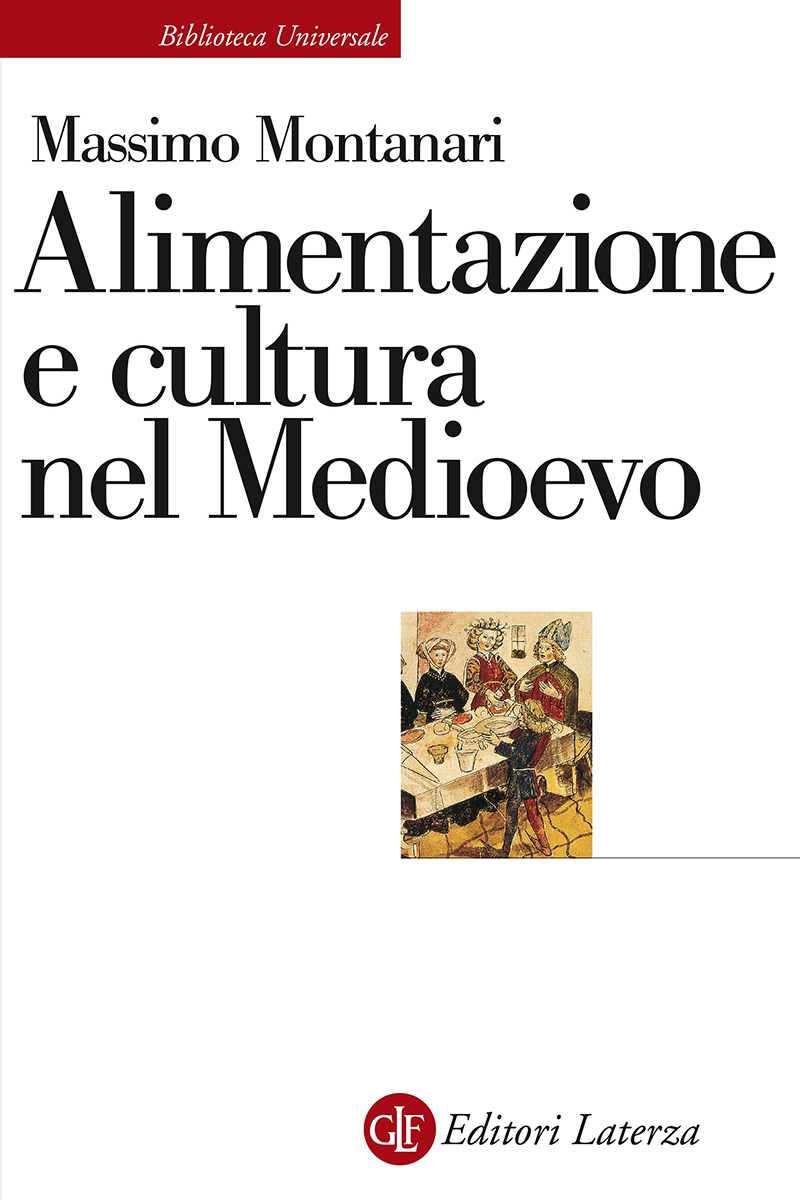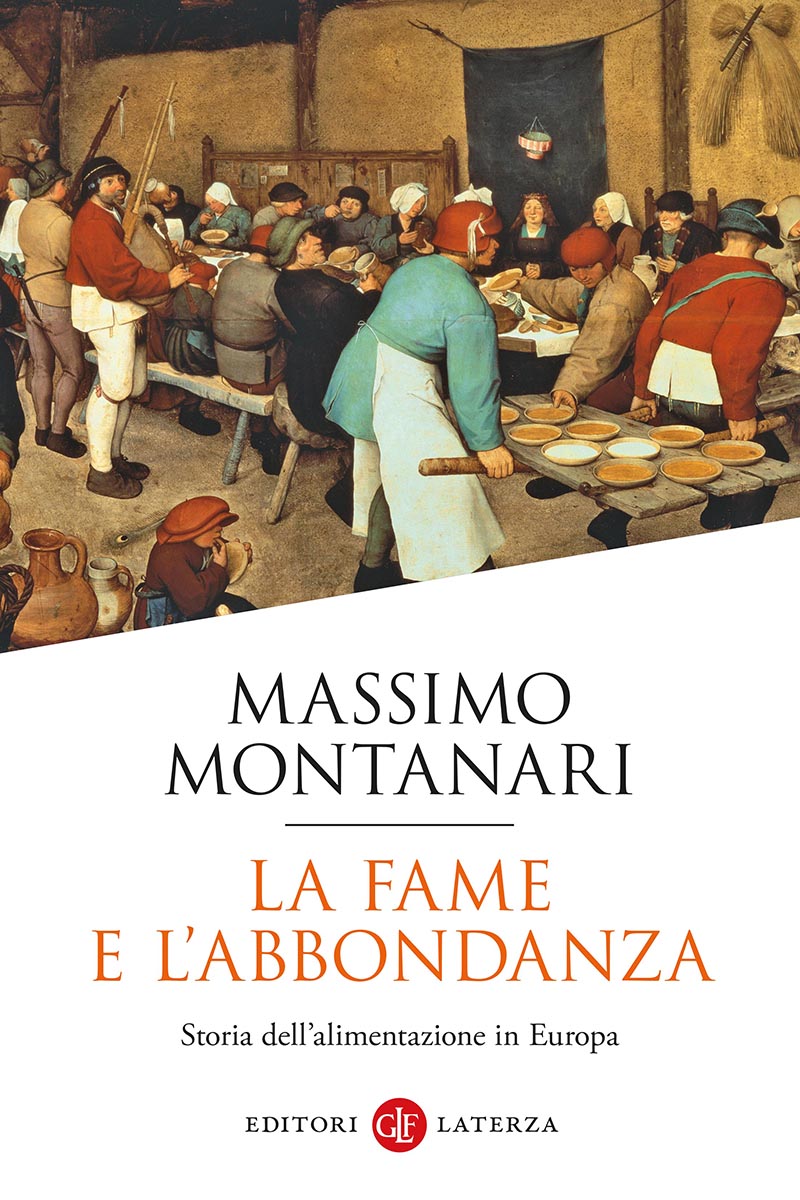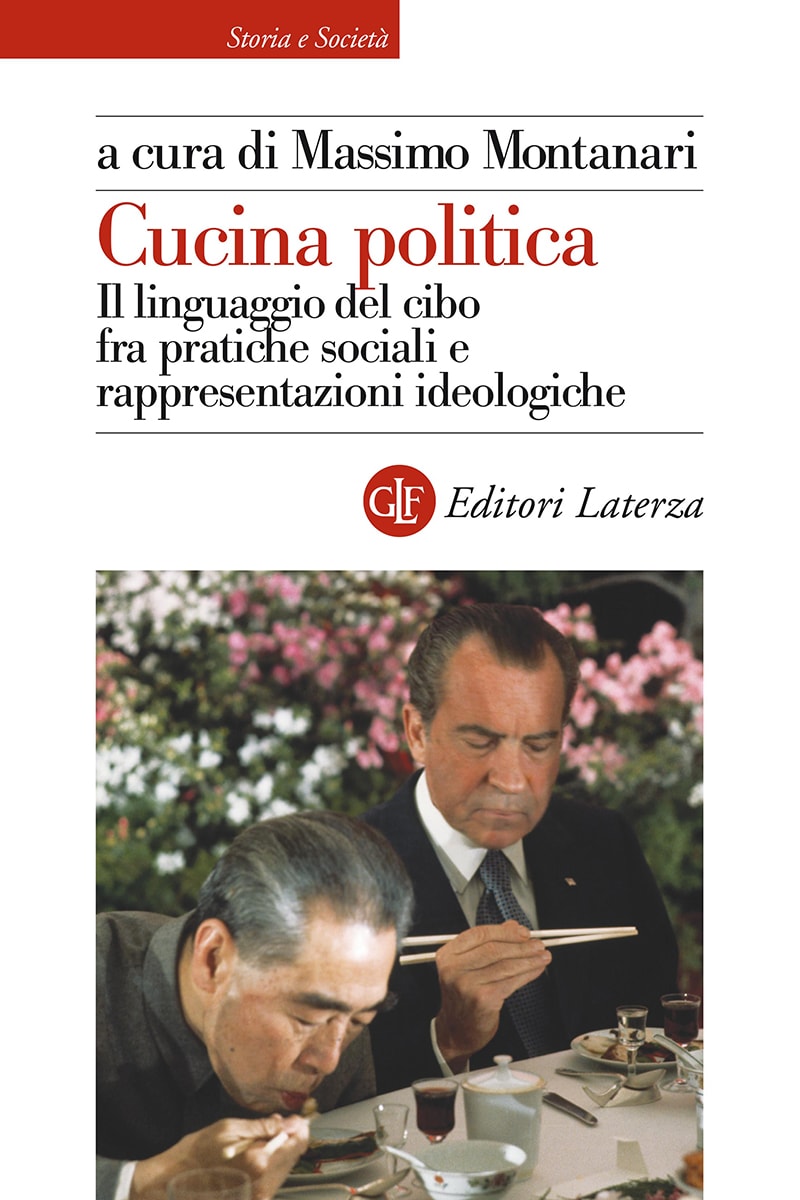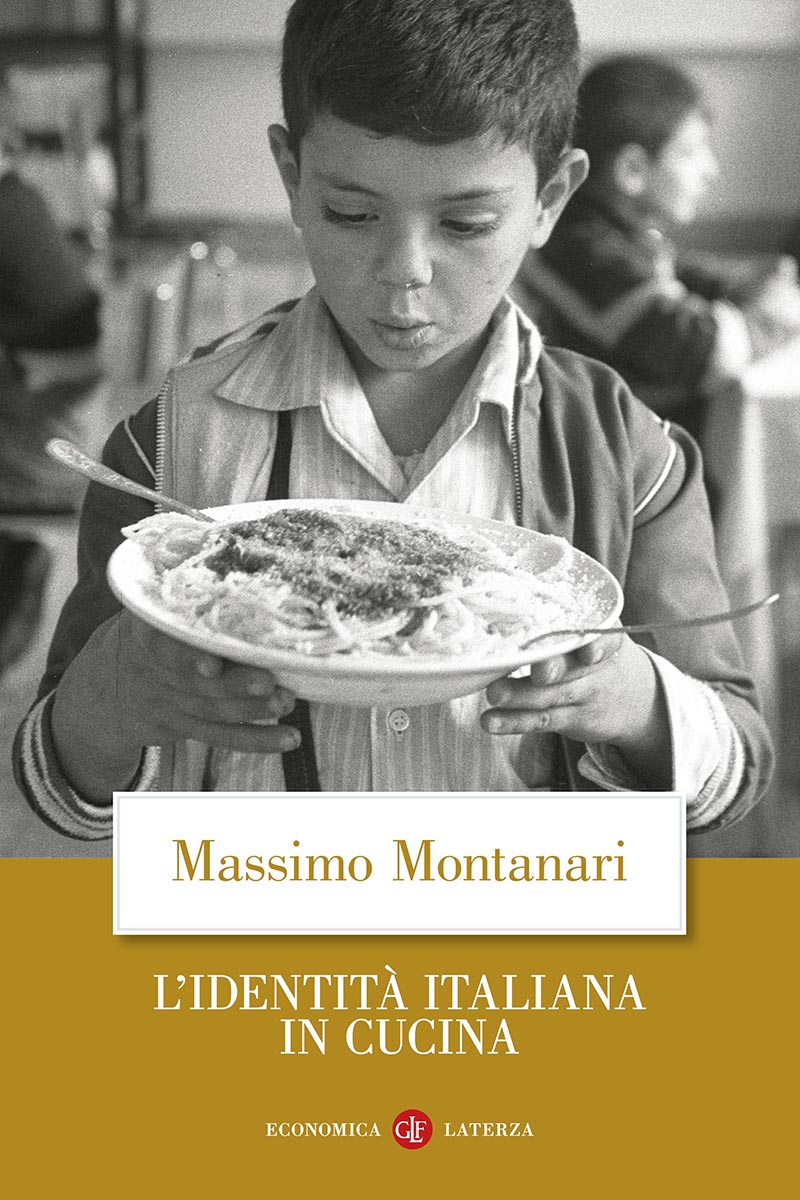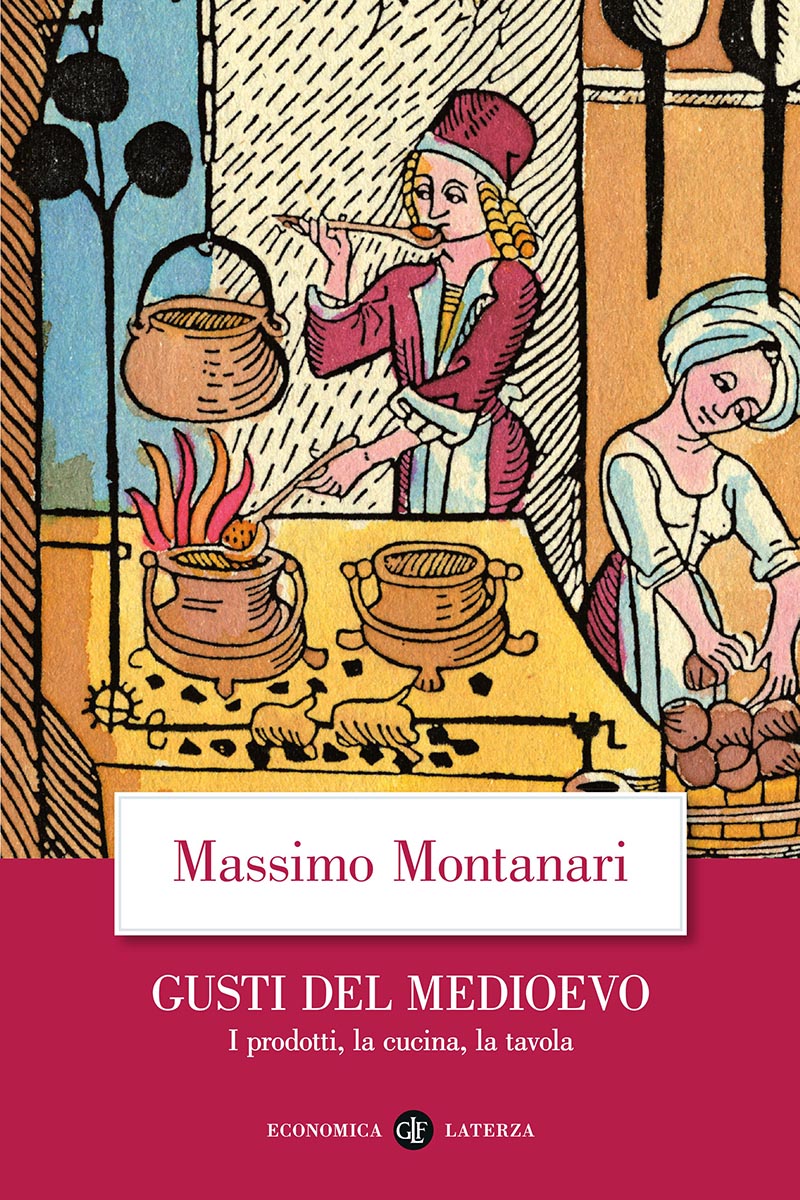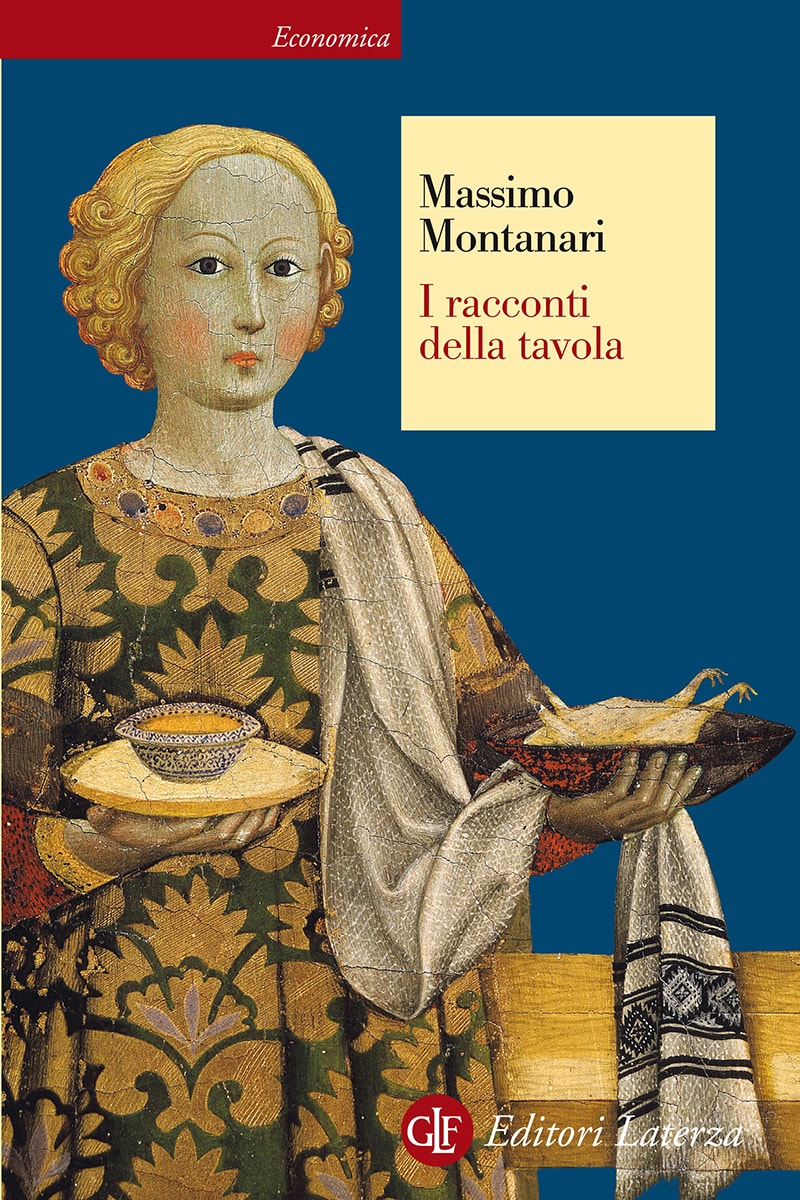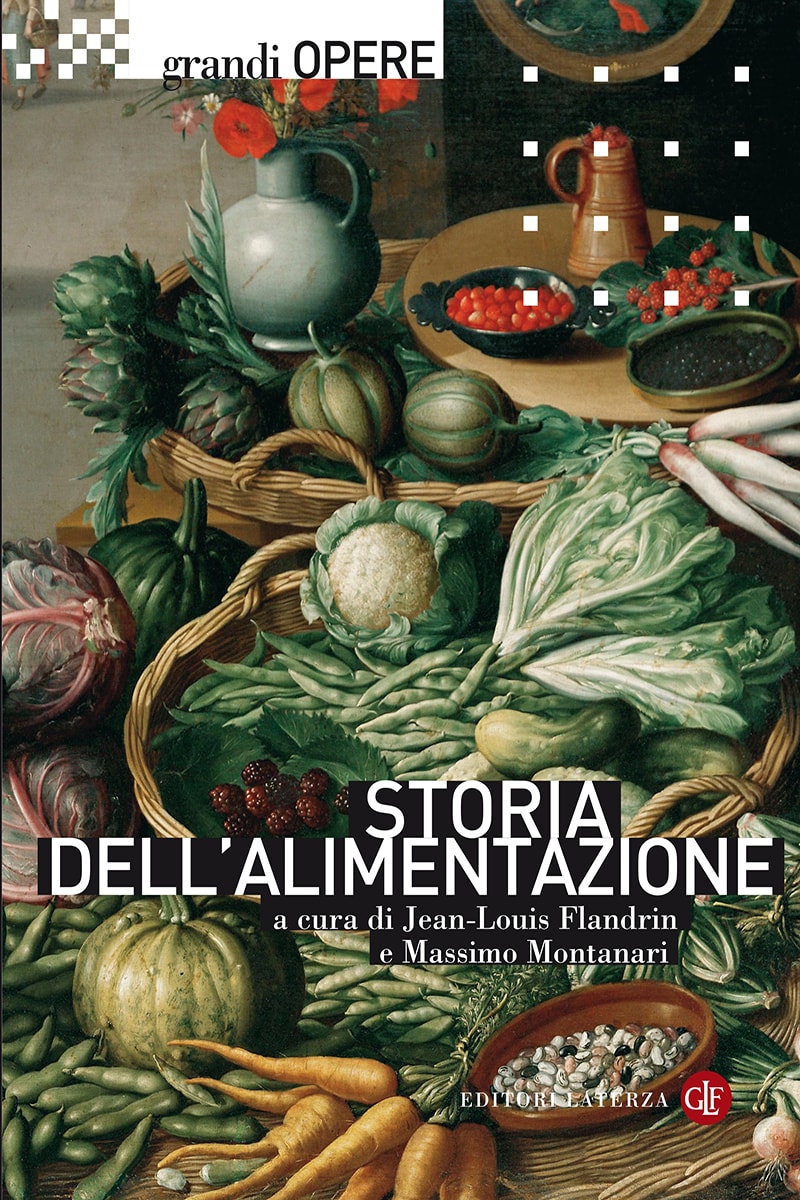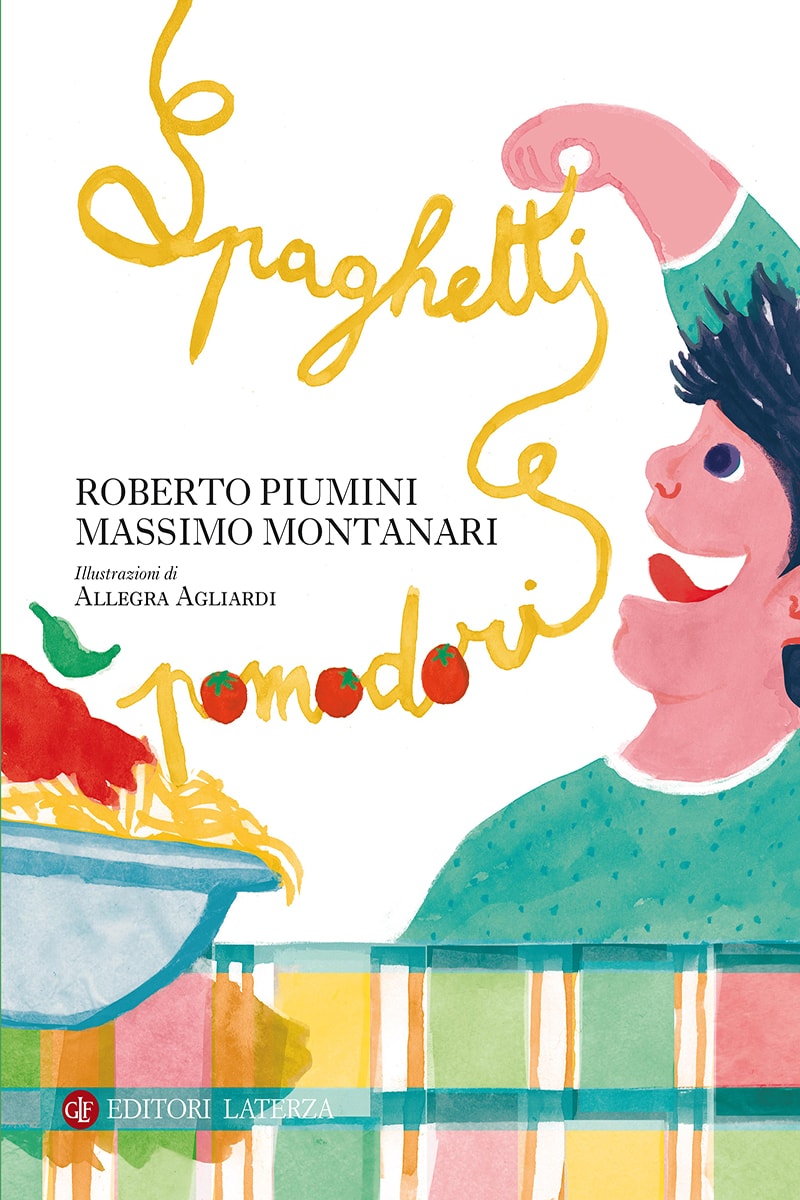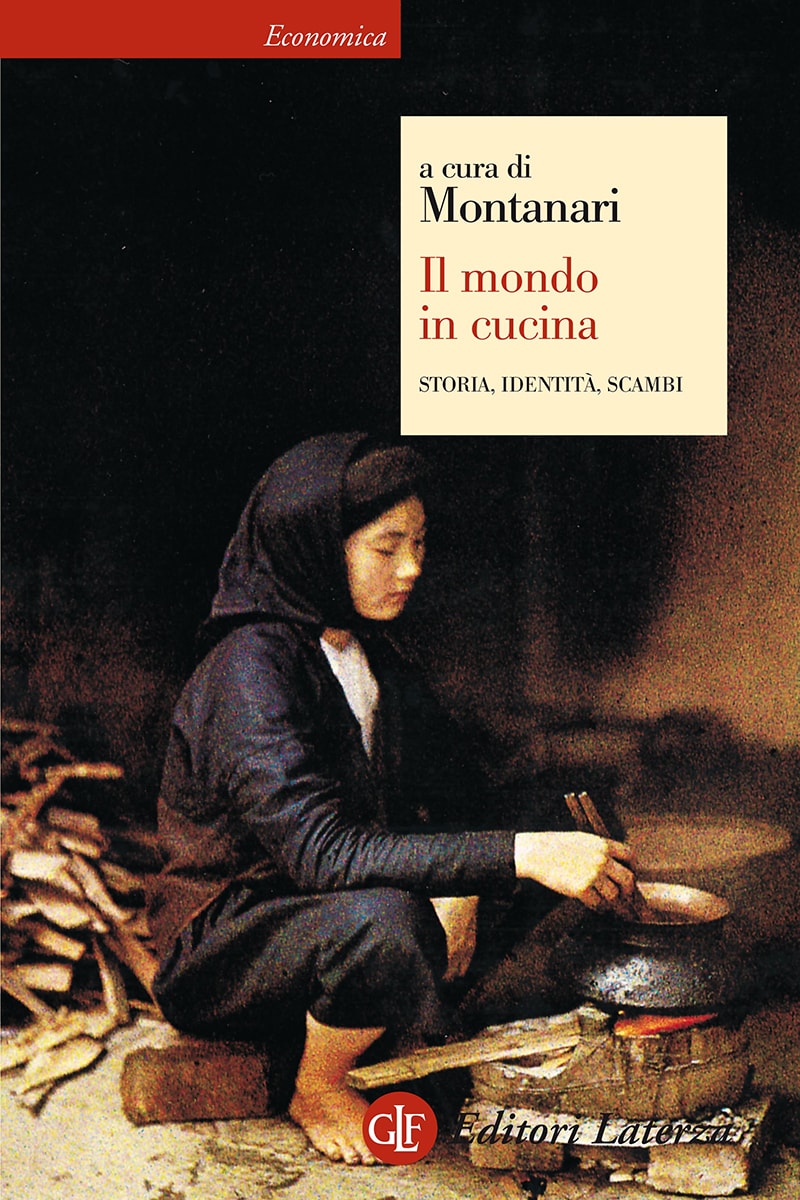La cucina italiana
Storia di una cultura
L’illustrazione esemplare di una ricerca e di una riflessione di storia totale che riesce a combinare idee, valori e pratiche. E anche una storia d’Italia e degli italiani spiegata con realismo concreto, sapienza e umorismo. Un bel libro. Jacques Le Goff
Un libro gradevolissimo che ci guida a un ritorno all’amore per il convito come momento essenziale nella storia del vivere civile.
Tullio Gregory