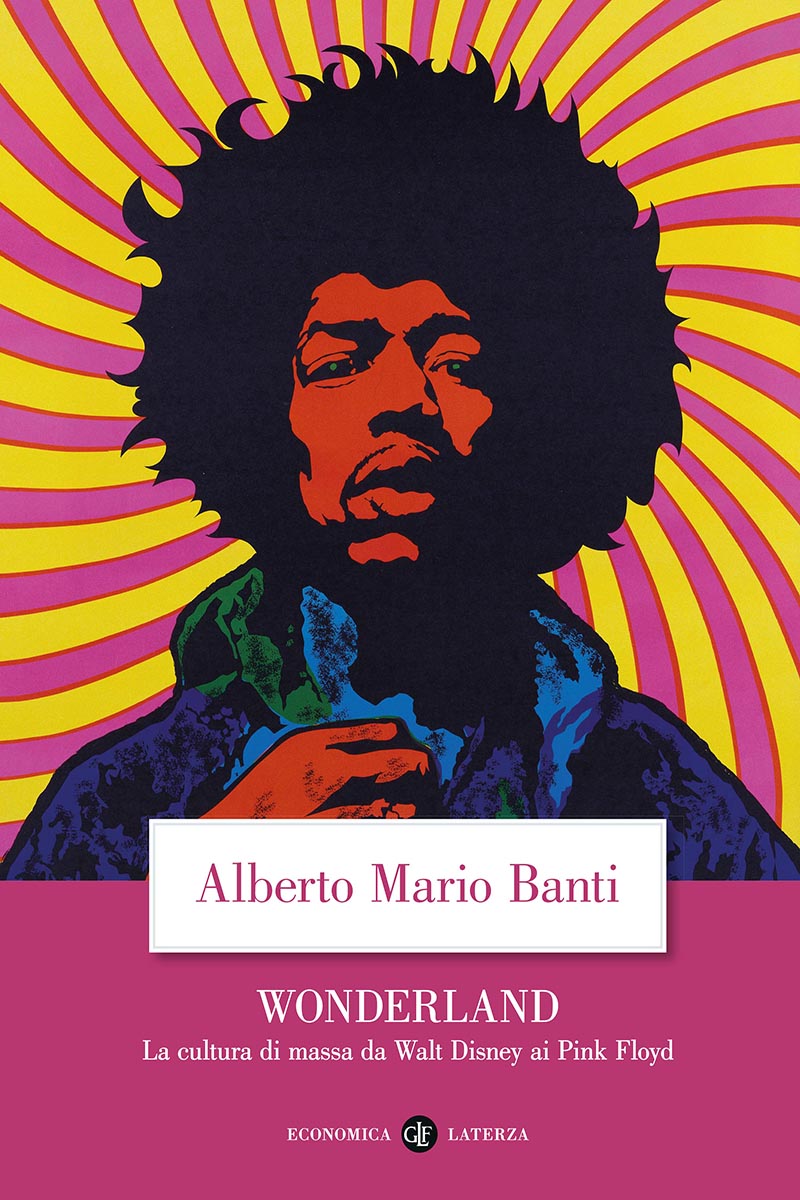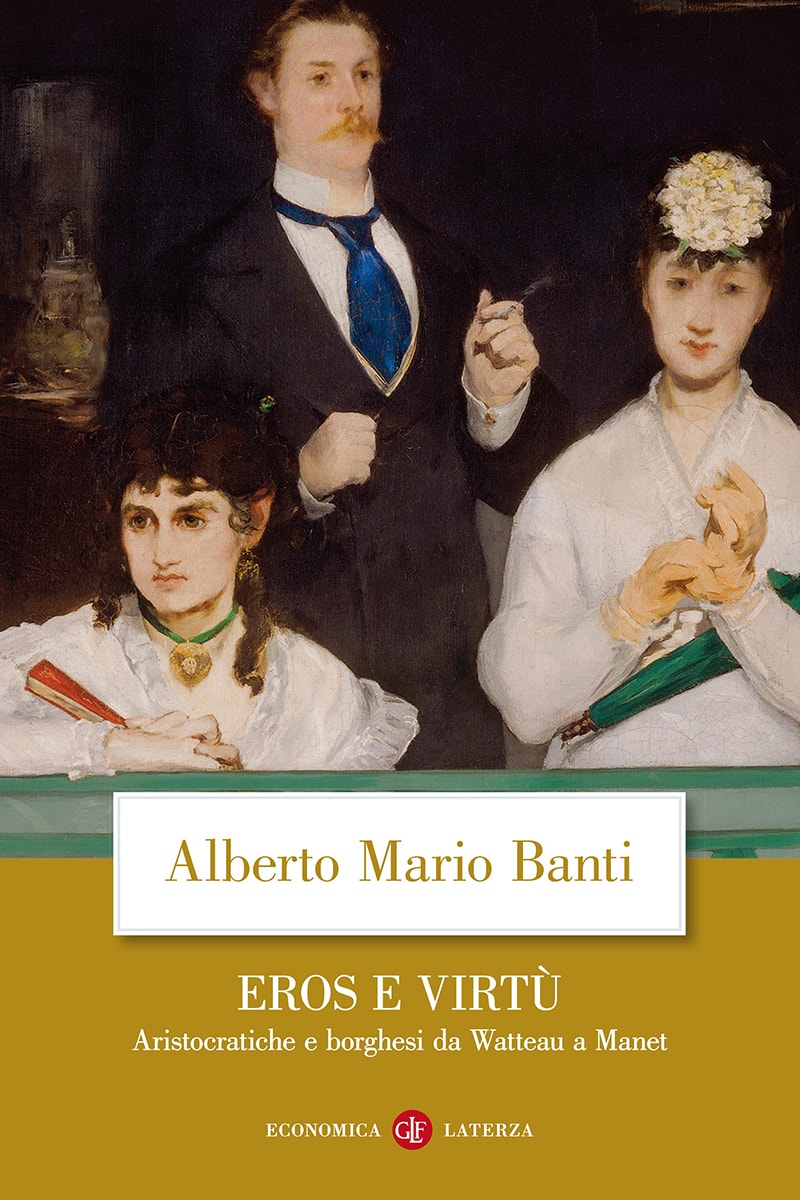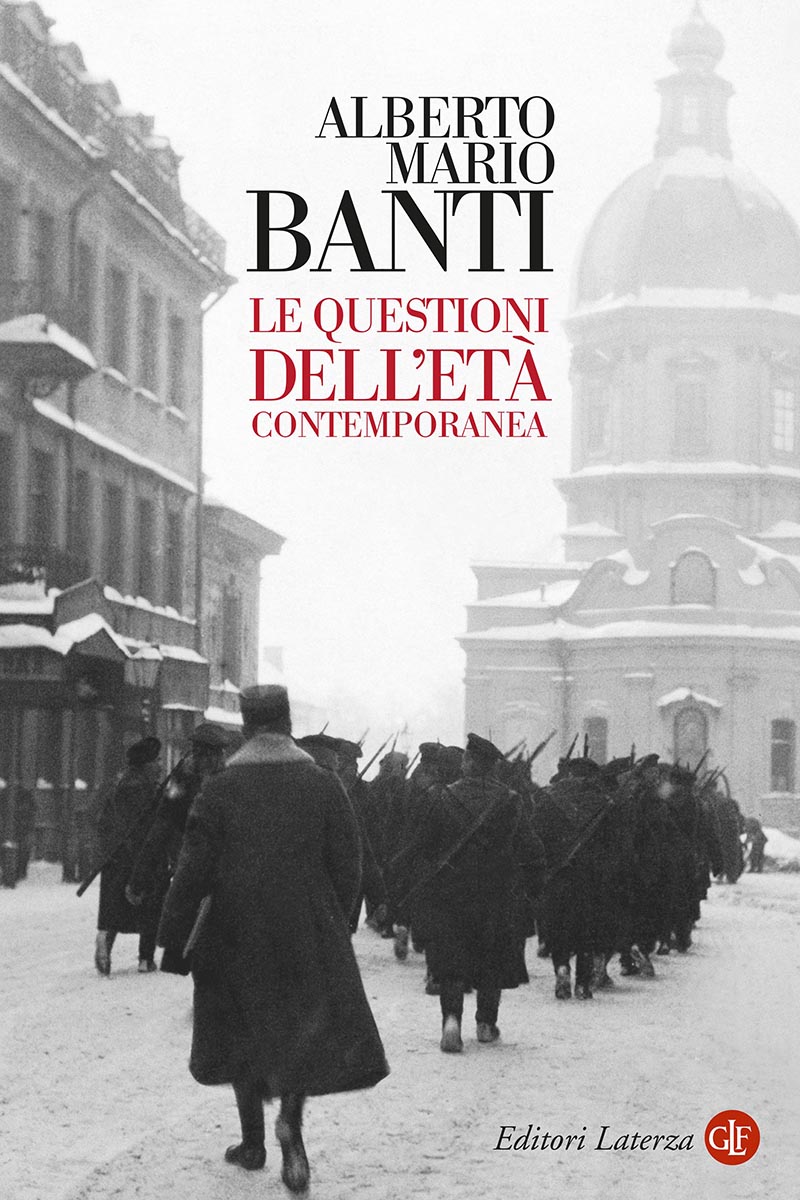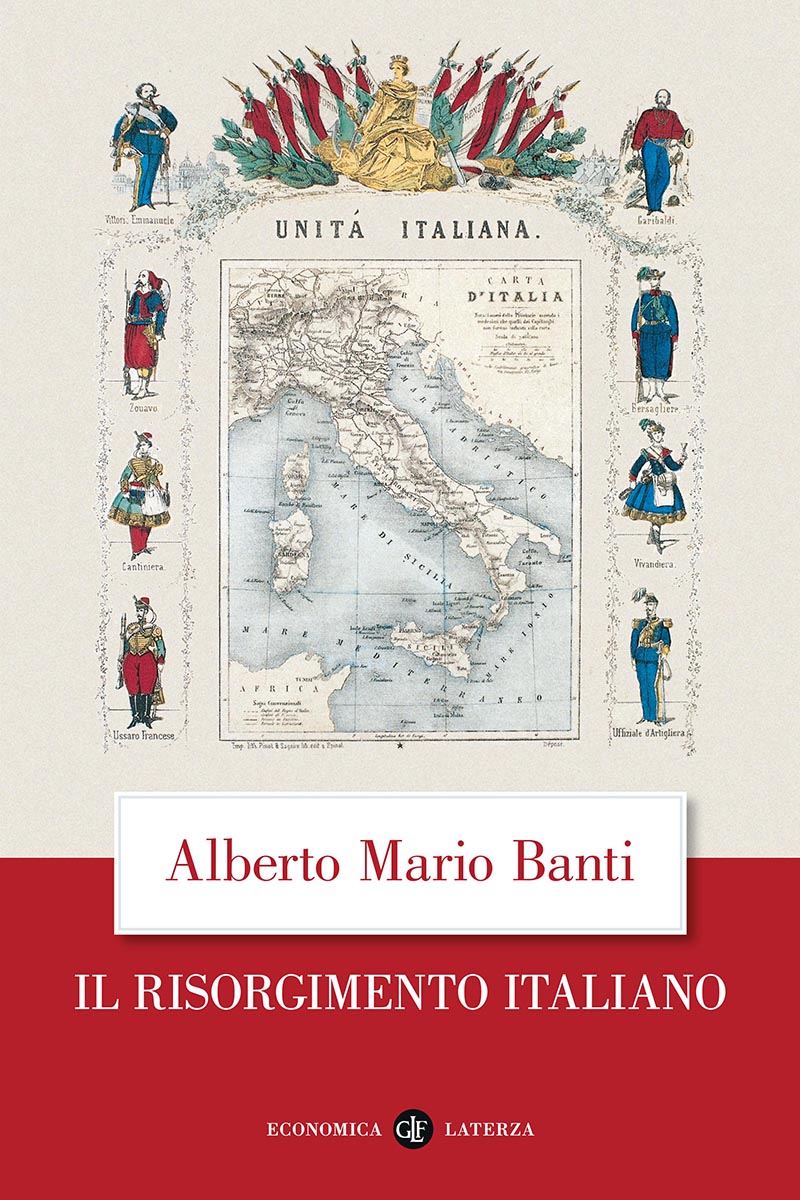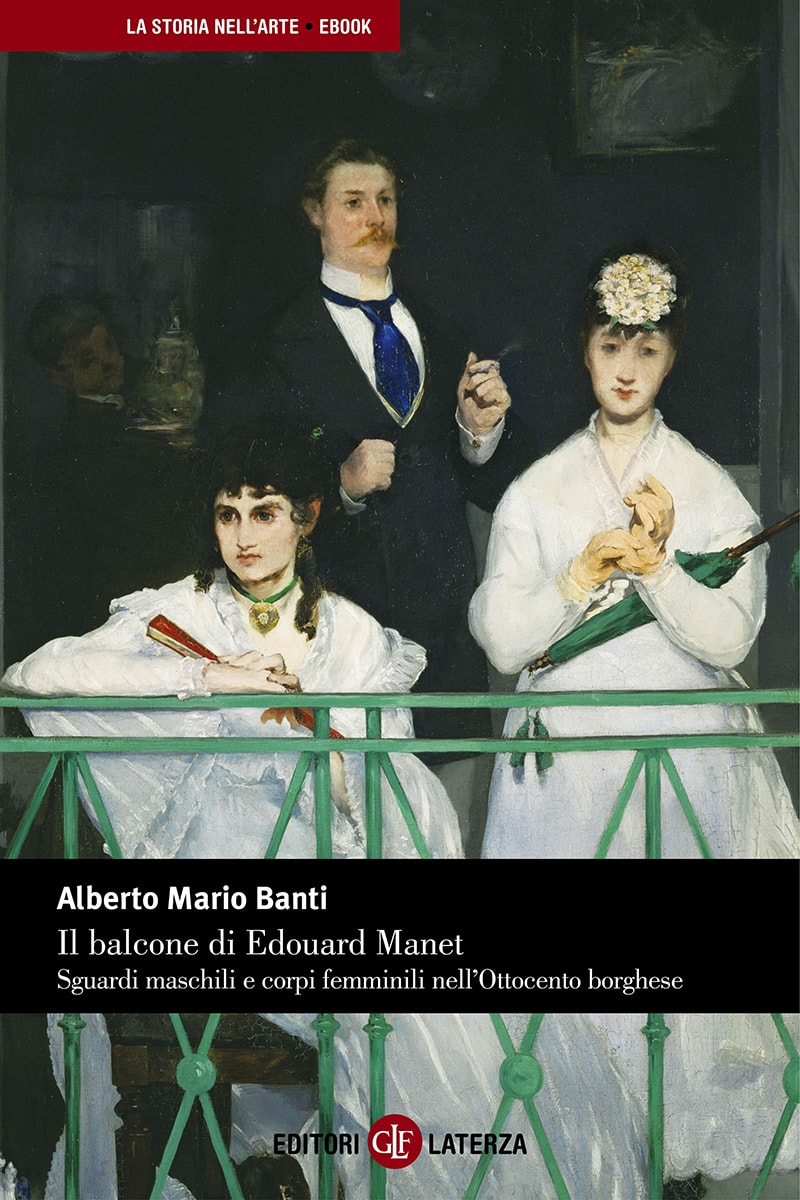Wonderland
C’era una volta Wonderland, una terra di racconti meravigliosi fatta dalle parole dei romanzi, dalle trasmissioni radio, dalle figure dei fumetti, dalle immagini del cinema e della televisione.
Wonderland è l’America con la sua industria culturale. Un soft power, che ha costruito una vera e propria ideologia. La sua storia ci consente di comprendere le eredità che solcano ancora l’immaginario dell’Occidente contemporaneo.
Nel 1933 viene lanciato nei cinema USA I tre porcellini di Walt Disney. Questo piccolo avvenimento segna l’inizio della parabola della cultura mainstream promossa dai film delle majors hollywoodiane, raccolta e amplificata dalla radio e dalla tv. Questo tipo di cultura, basata su un’idea consolatoria dell’intrattenimento, fondata su una visione manichea del bene contro il male e sul must del lieto fine, prende forma allora e mette radici nell’immaginario collettivo dell’Occidente. Basti pensare a film come Via col vento, Il mago di Oz e Gli uomini preferiscono le bionde, o a fumetti come Tarzan, Dick Tracy o i supereroi.
Dopo la seconda guerra mondiale si assiste invece alla nascita e al successo di una controcultura di massa, animata – sin dai primi anni Sessanta – soprattutto dalla formazione e dal successo della musica rock. Bob Dylan, Beatles, Pink Floyd intrecciano i loro rapporti con il coevo ‘nuovo cinema’ di Hollywood, da Easy Rider a Il laureato, fino alla nuova produzione teatrale di Broadway e alle nuove forme della programmazione televisiva. Una cultura alternativa, con al centro gli afroamericani, i ragazzi e le ragazze delle subculture giovanili, i militanti per i diritti civili.
Questa costellazione potente si dissolve a partire dalla metà degli anni Settanta permettendo alla cultura di massa mainstream di rinnovare la sua egemonia, ancora oggi evidente.