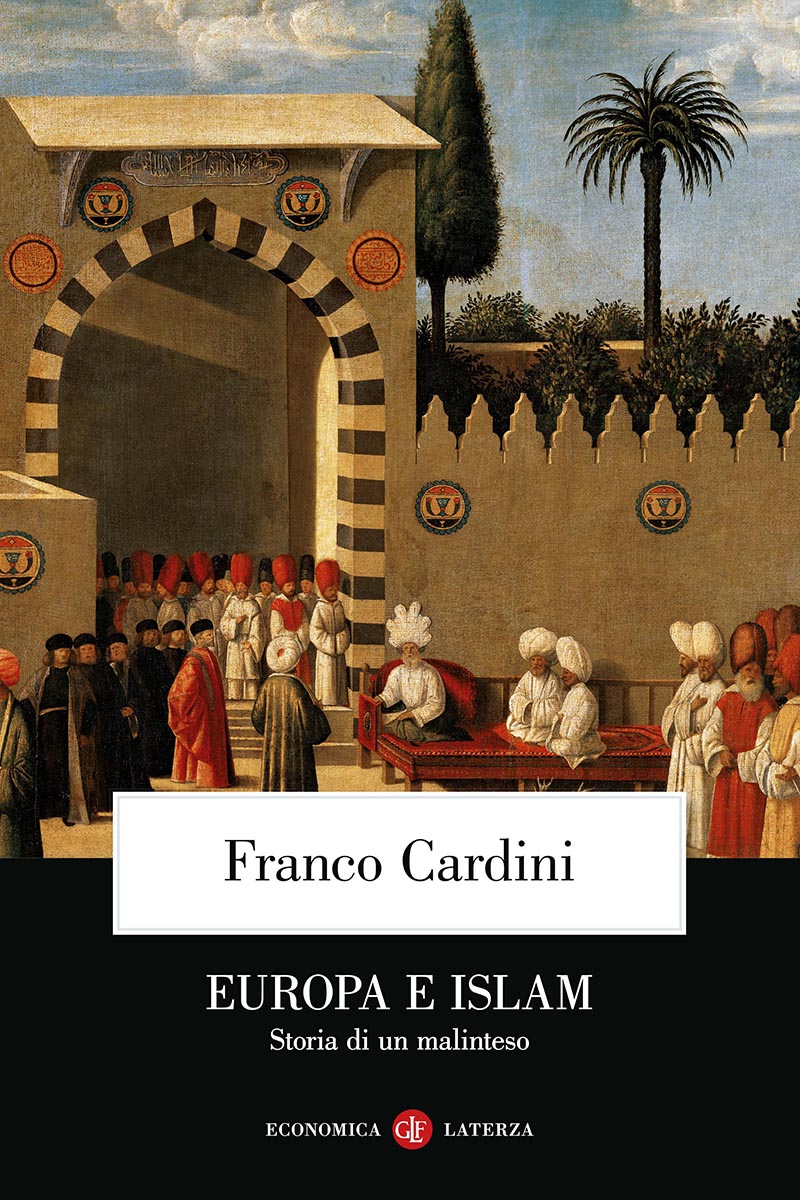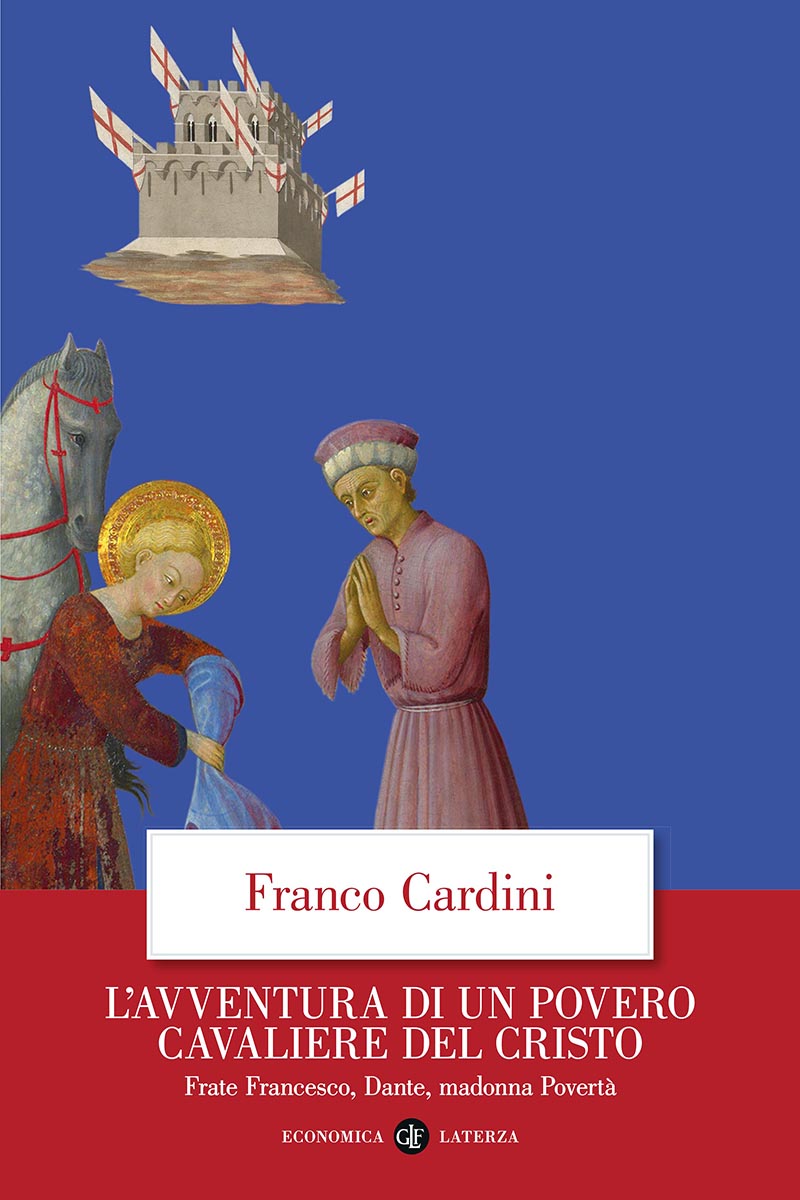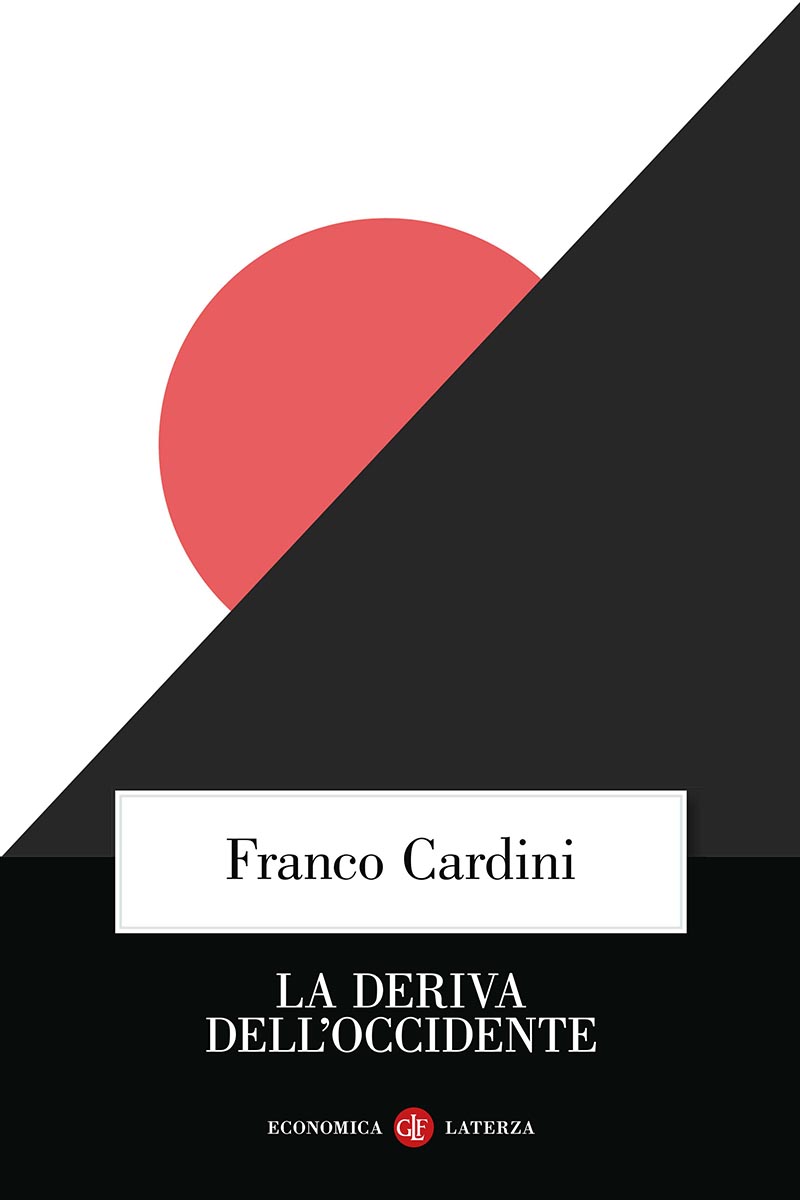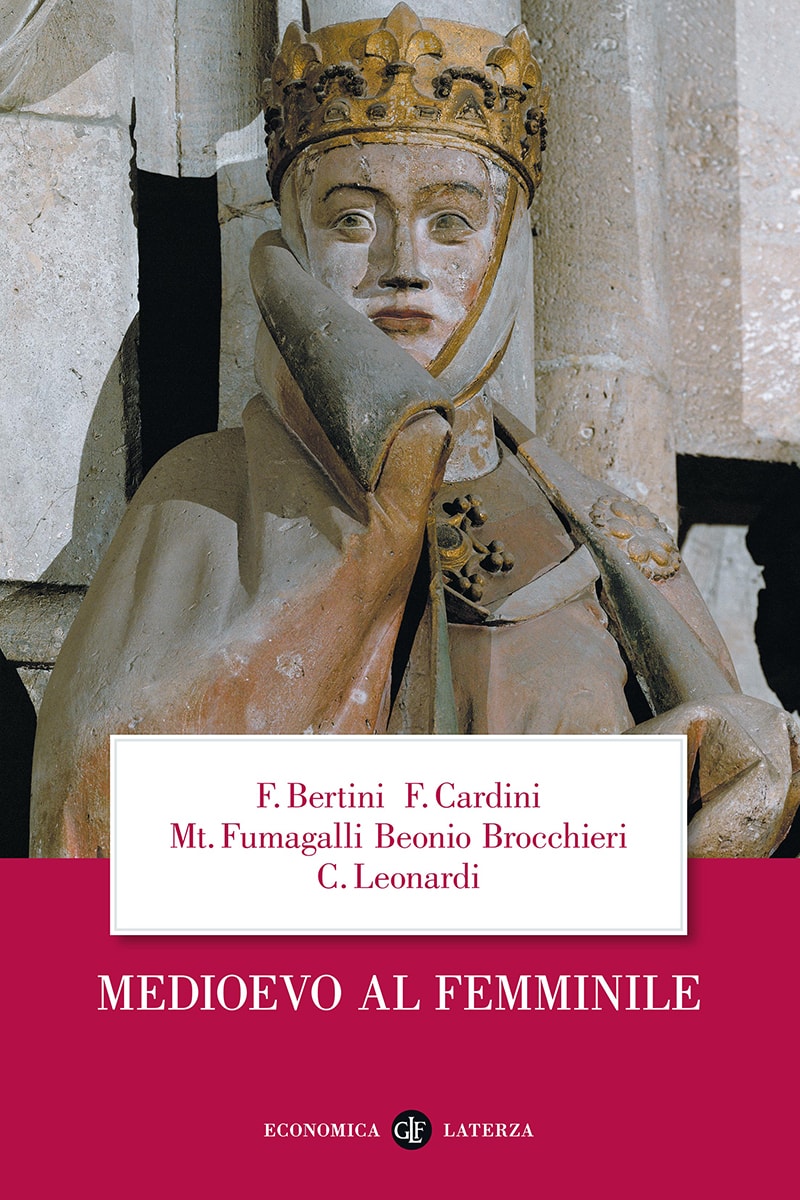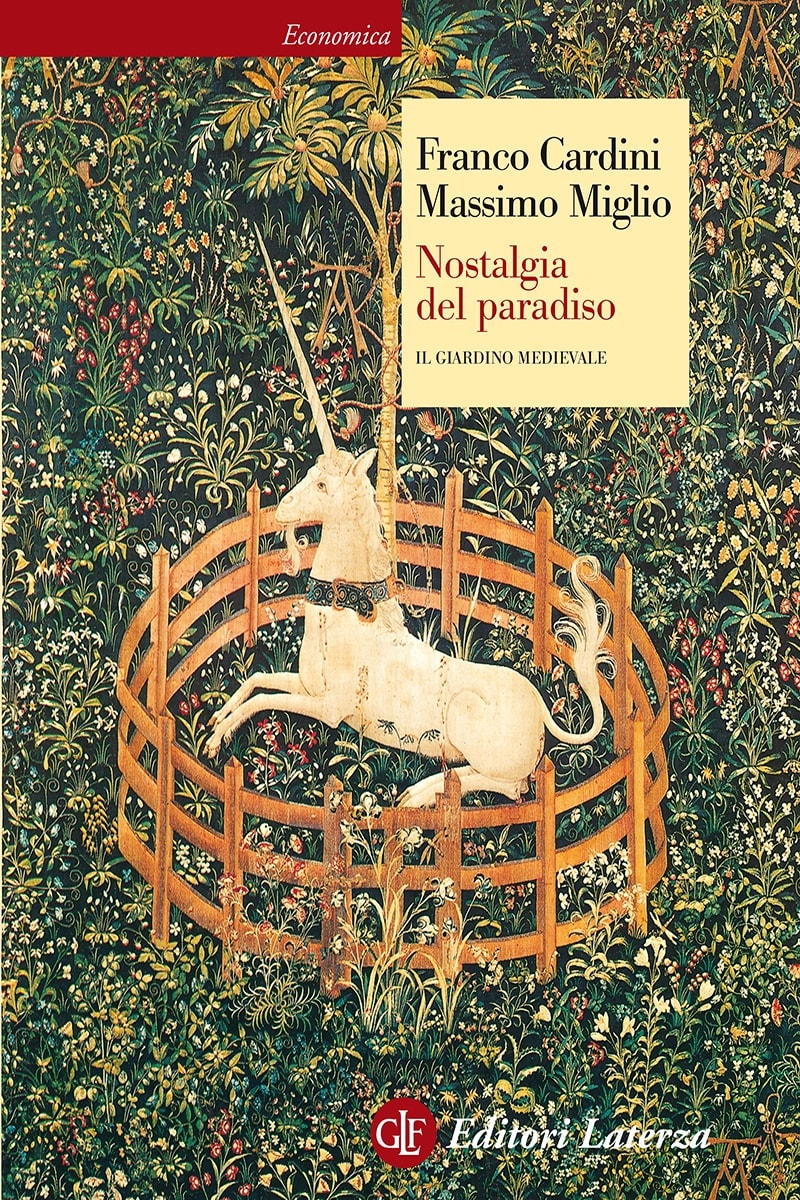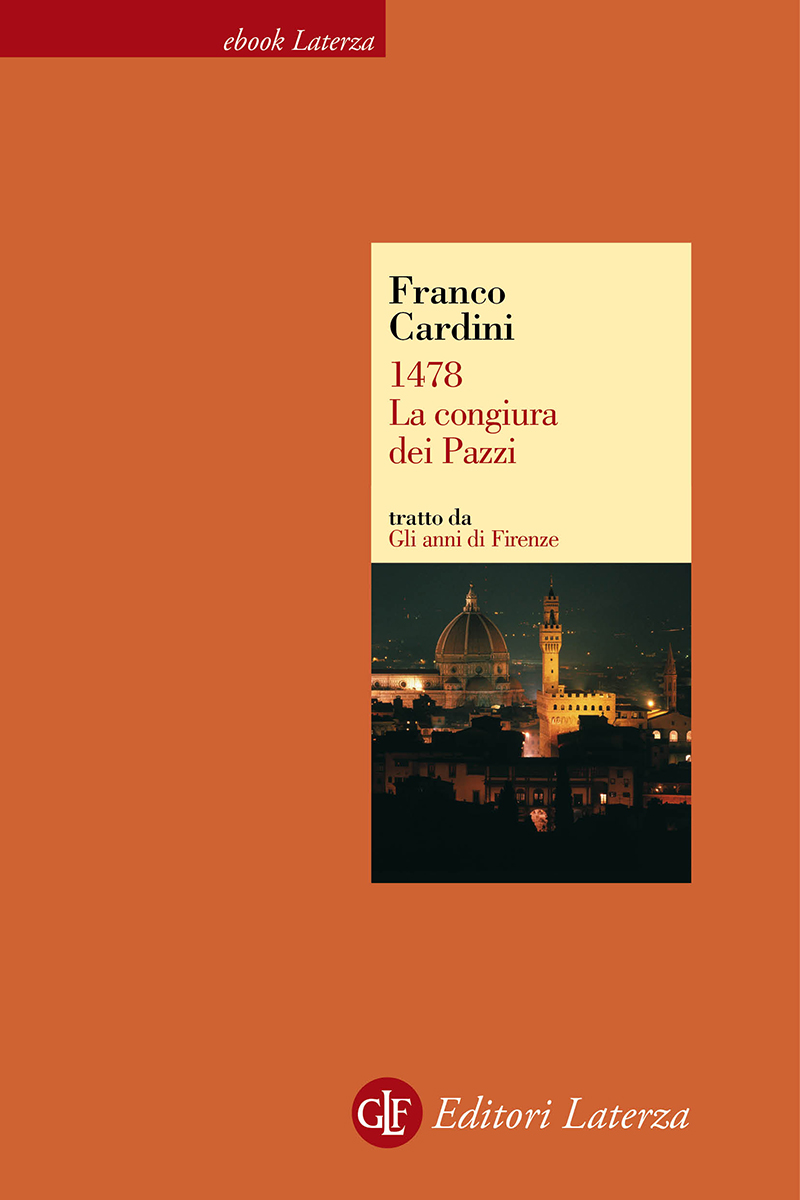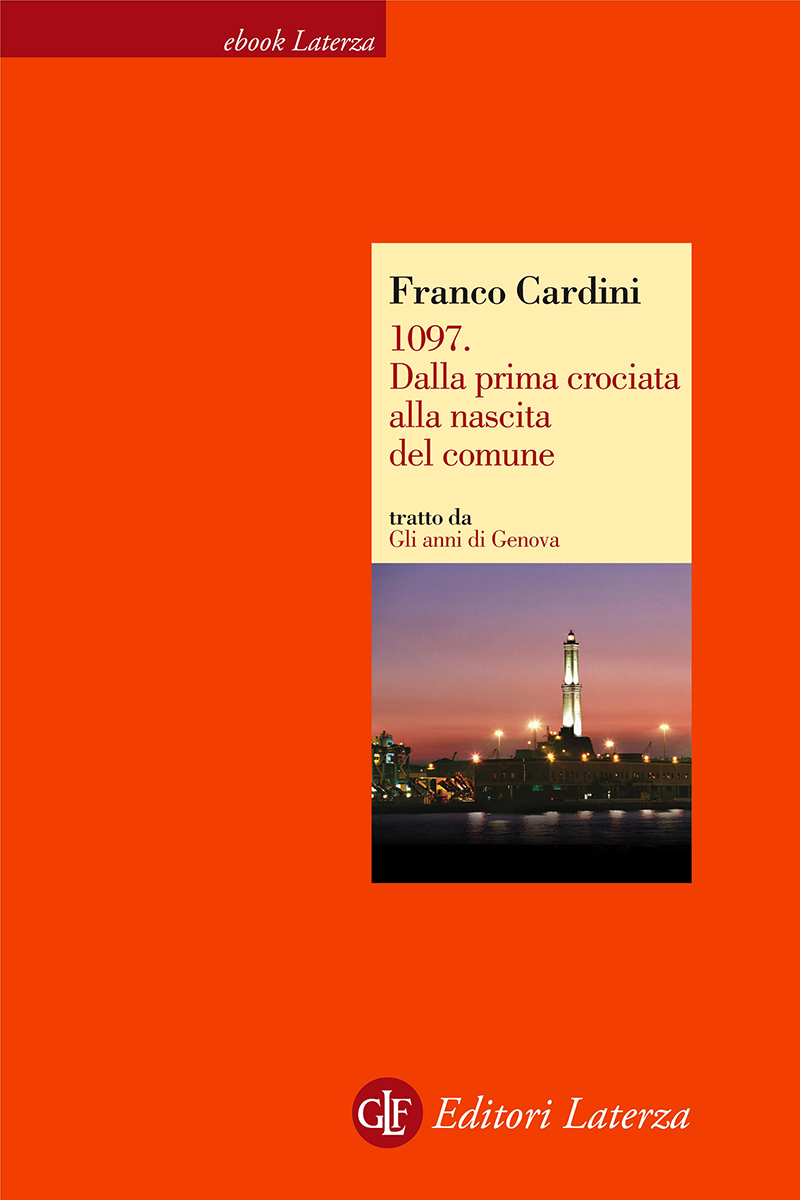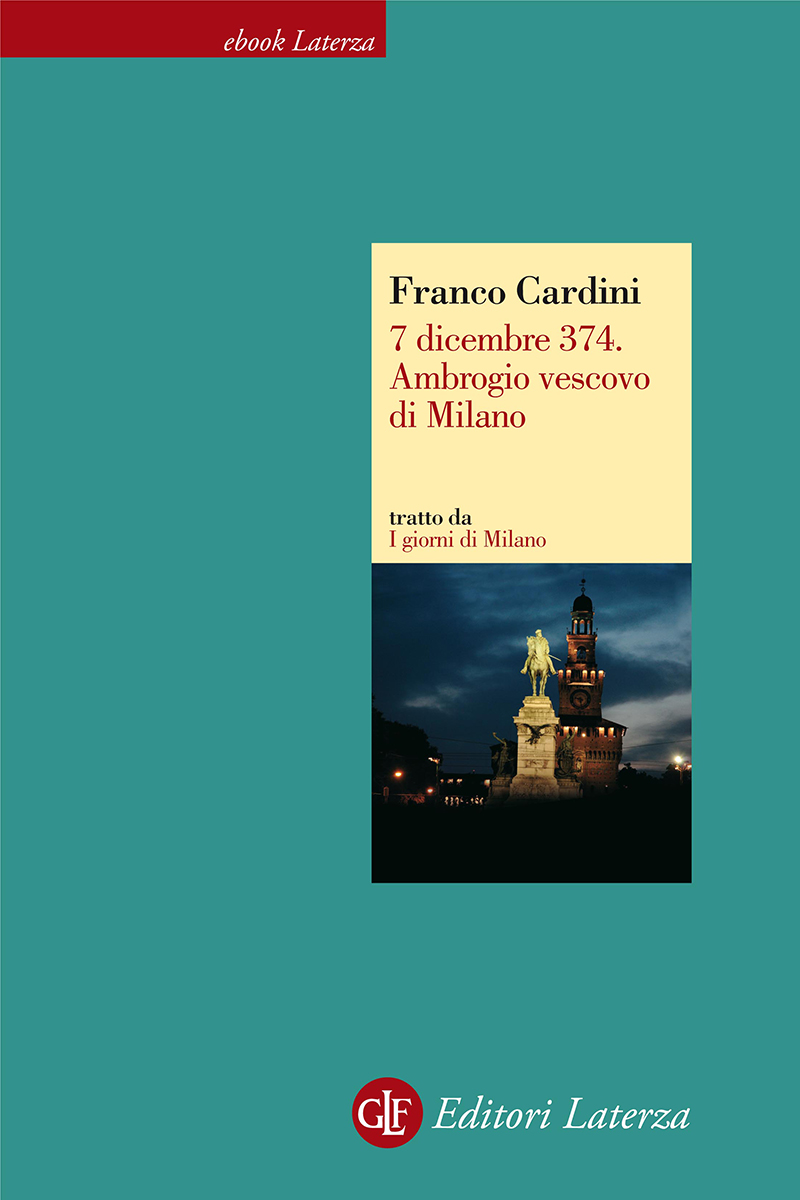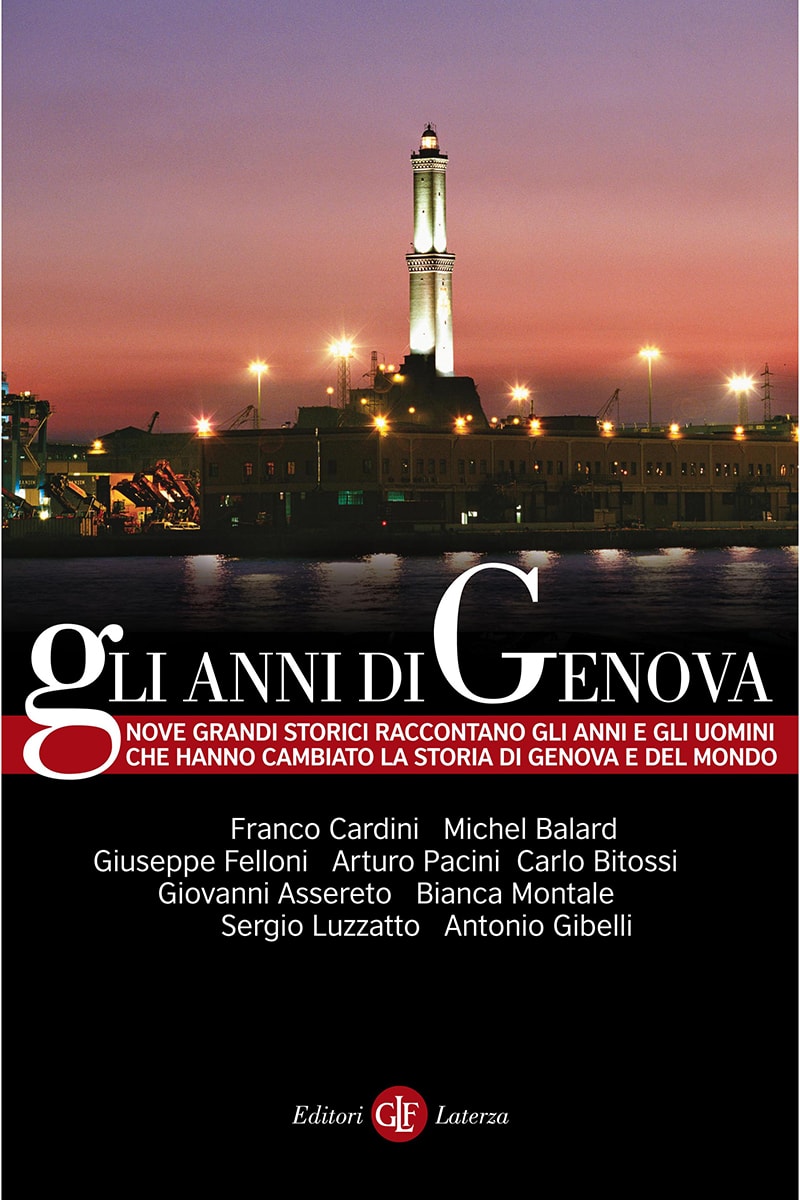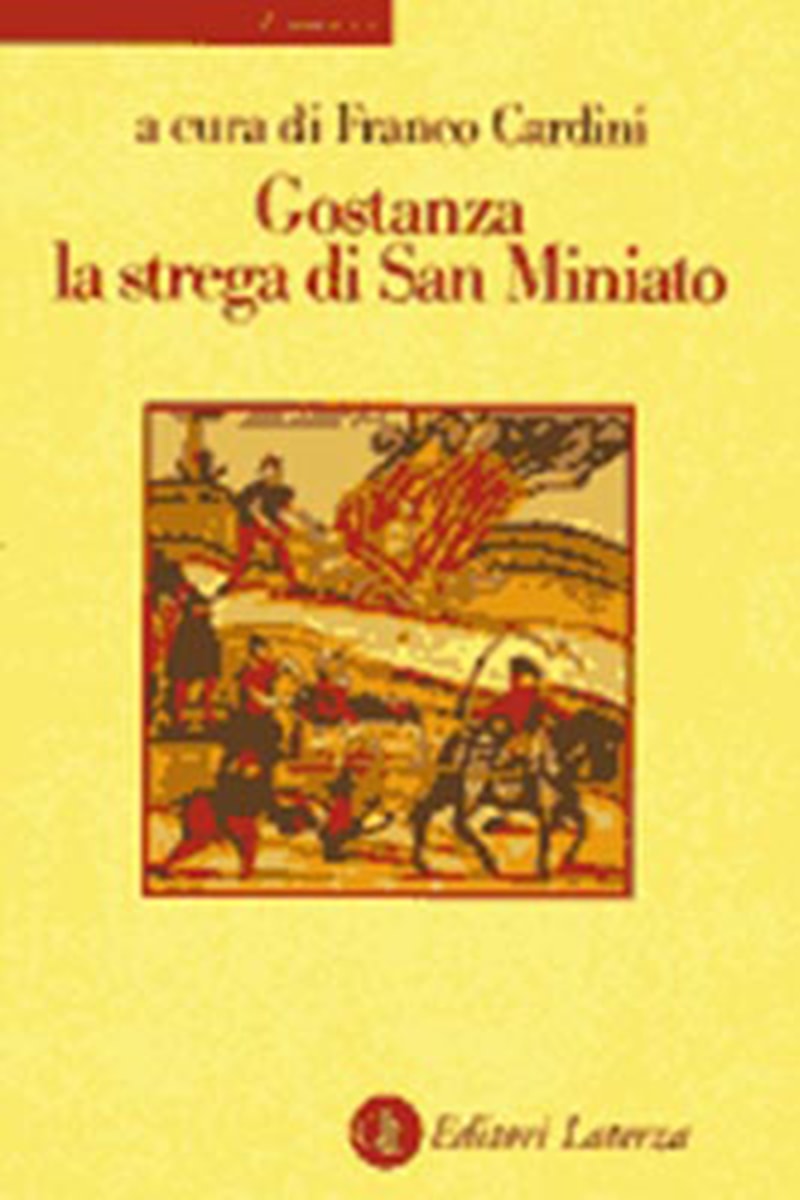Europa e Islam
Nonostante crociate e guerricciole, scorrerie di pirati, saccheggi e tratta di schiavi, nonostante Lepanto e l’assedio di Vienna, la verità è che con l’Islam abbiamo sempre commerciato bene e avuto, in sostanza, buoni rapporti. In tempi diversi si è sovrapposto un malinteso, dagli esiti spaventosi per l’una e l’altra parte. È la tesi originale di Franco Cardini. Mario Baudino, “La Stampa”
Franco Cardini ritesse i fili della memoria e fa piazza pulita di menzogne e pregiudizi. “Il Venerdì di Repubblica”
Il volume di Franco Cardini è un punto di riferimento ineludibile, un raro lavoro che riesce a sintetizzare in un preciso quadro d’insieme la storia del rapporto fra cristiani e musulmani. “Medioevo”
Dal Maometto ‘cristiano eretico’ all'Islam ‘religione diabolica’, dal ‘feroce Saladino’ al Turco ‘nemico della croce’, i rapporti e gli scambi fra Europa e Islam sono quasi sempre stati pensati alla luce di un preconcetto ostile.