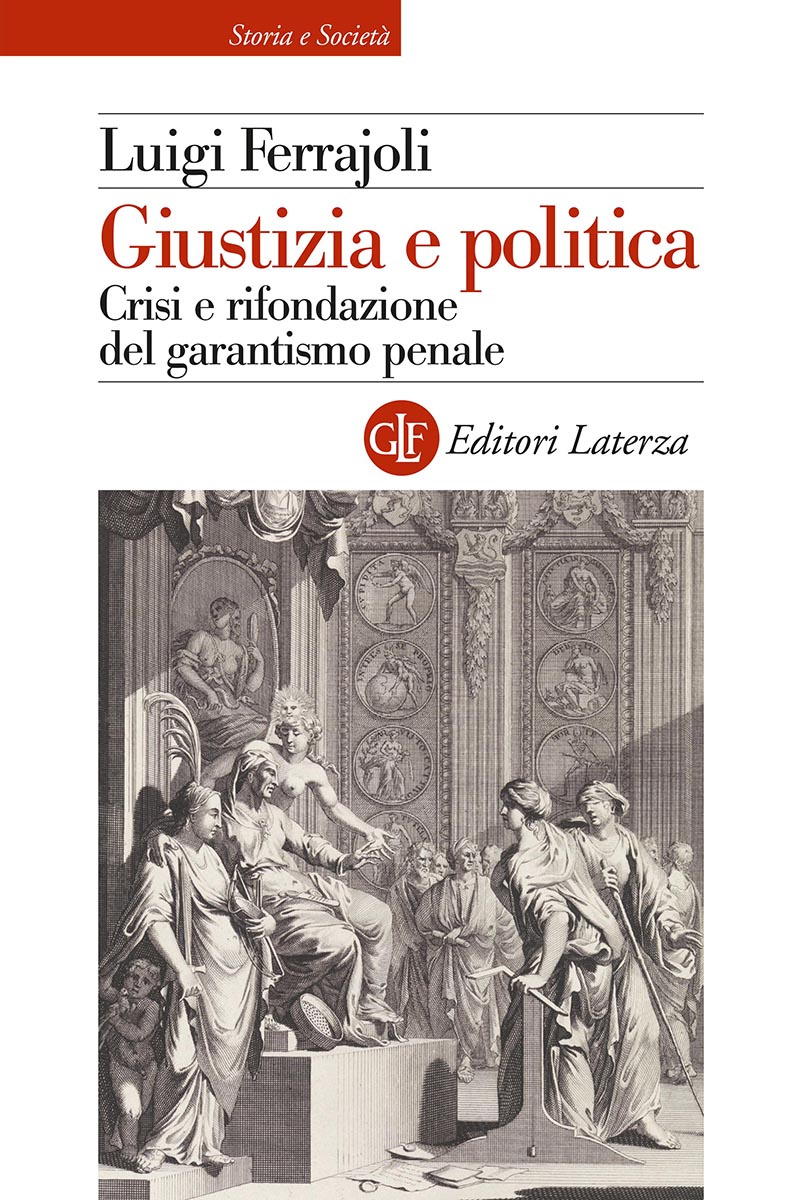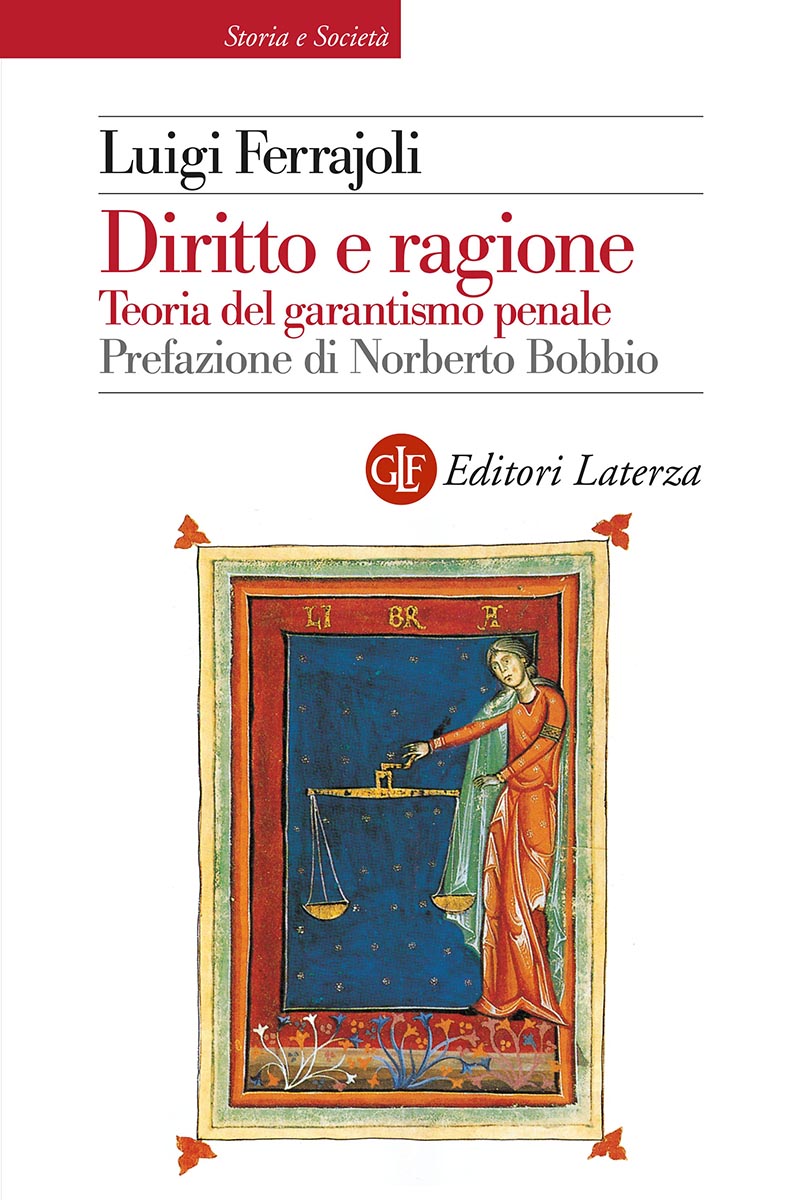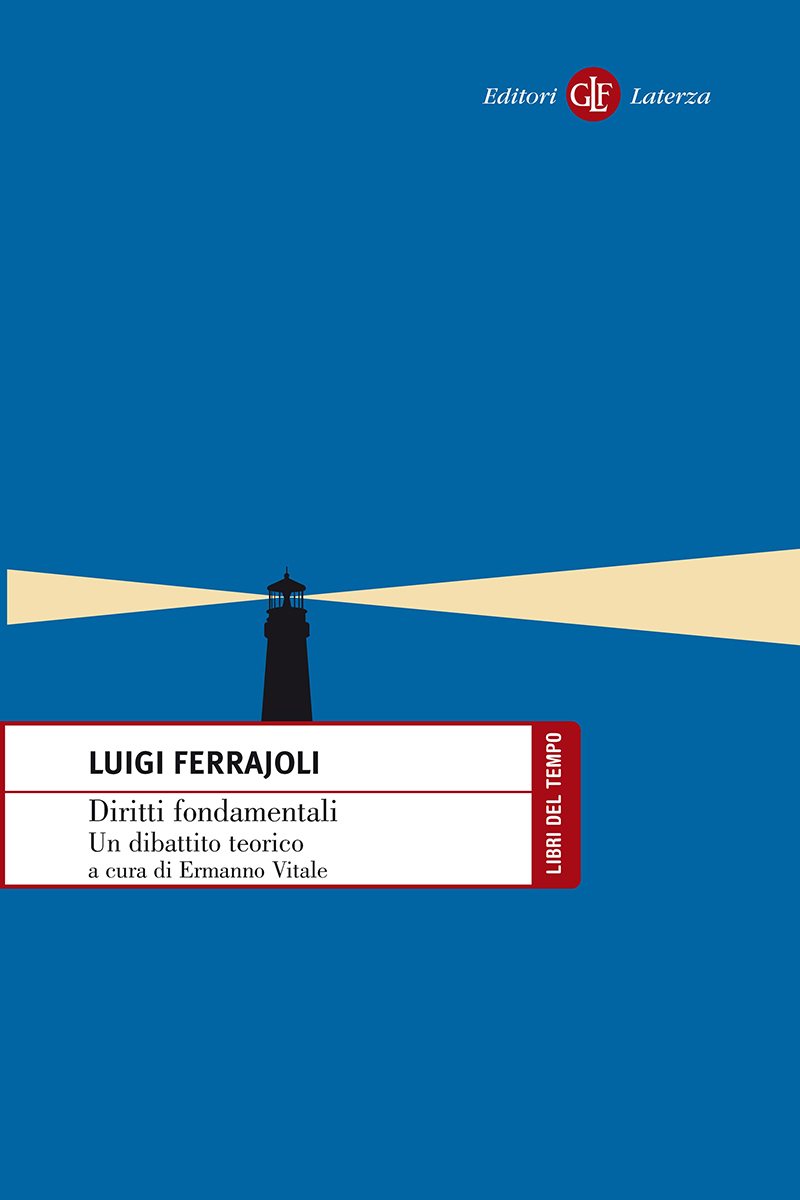Poteri selvaggi
L'idea di democrazia, ha scritto Hans Kelsen, implica l'assenza di capi.
In un paese come l'Italia che ha conosciuto il fascismo, l'idea stessa del capo quale espressione della volontà popolare è un'insidia micidiale per il futuro della democrazia.
I poteri, lasciati senza limiti e controlli, tendono a concentrarsi e ad accumularsi in forme assolute: a tramutarsi, in assenza di regole, in poteri selvaggi. Di qui la necessità non solo di difendere, ma anche di ripensare e rifondare il sistema delle garanzie. Solo un rafforzamento della democrazia costituzionale, attraverso l'introduzione di nuove e specifiche garanzie dei diritti politici e della democrazia rappresentativa, consente infatti di salvaguardare e di rifondare sia l'una che l'altra. L'idea elementare che il consenso popolare sia la sola fonte di legittimazione del potere politico mina alla radice l'intero edificio della democrazia costituzionale. Ne derivano insofferenza per il pluralismo politico e istituzionale; svalutazione delle regole; attacchi alla separazione dei poteri, alle istituzioni di garanzia, all'opposizione parlamentare, al sindacato e alla libera stampa; in una parola, rifiuto del paradigma dello Stato costituzionale di diritto quale sistema di vincoli legali imposti a qualunque potere.