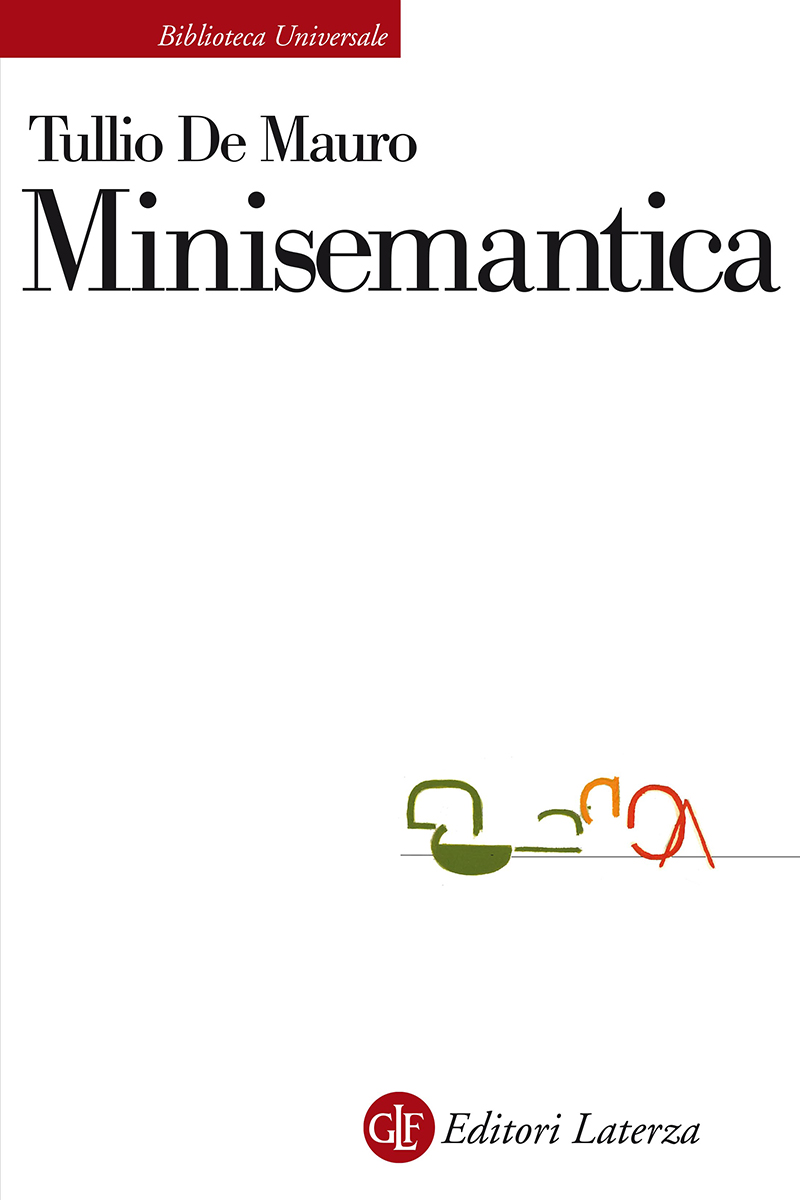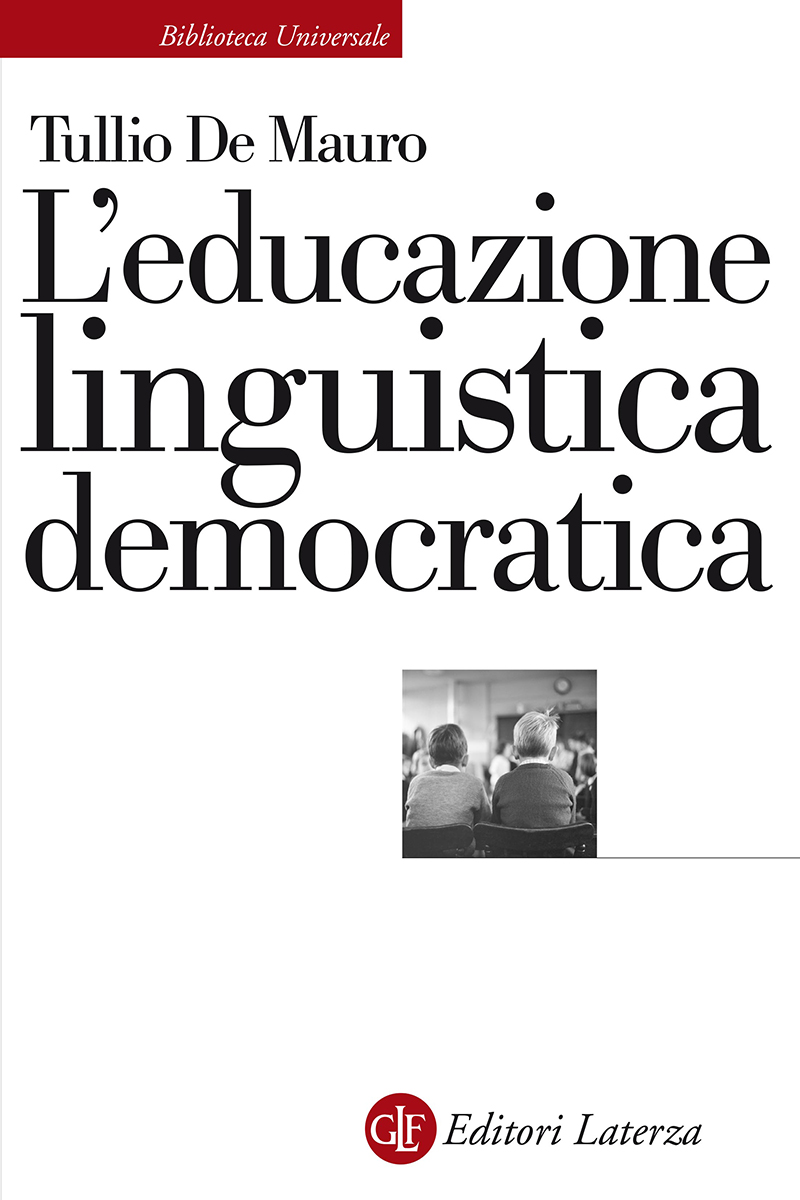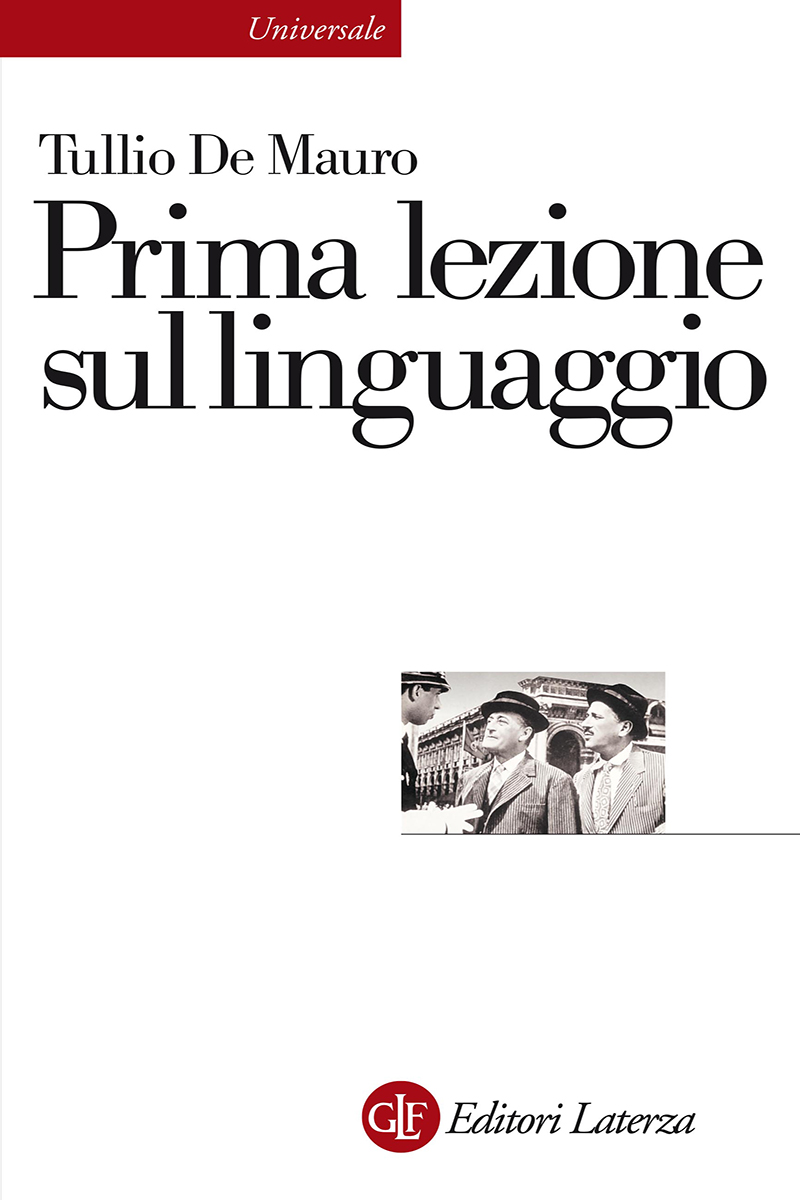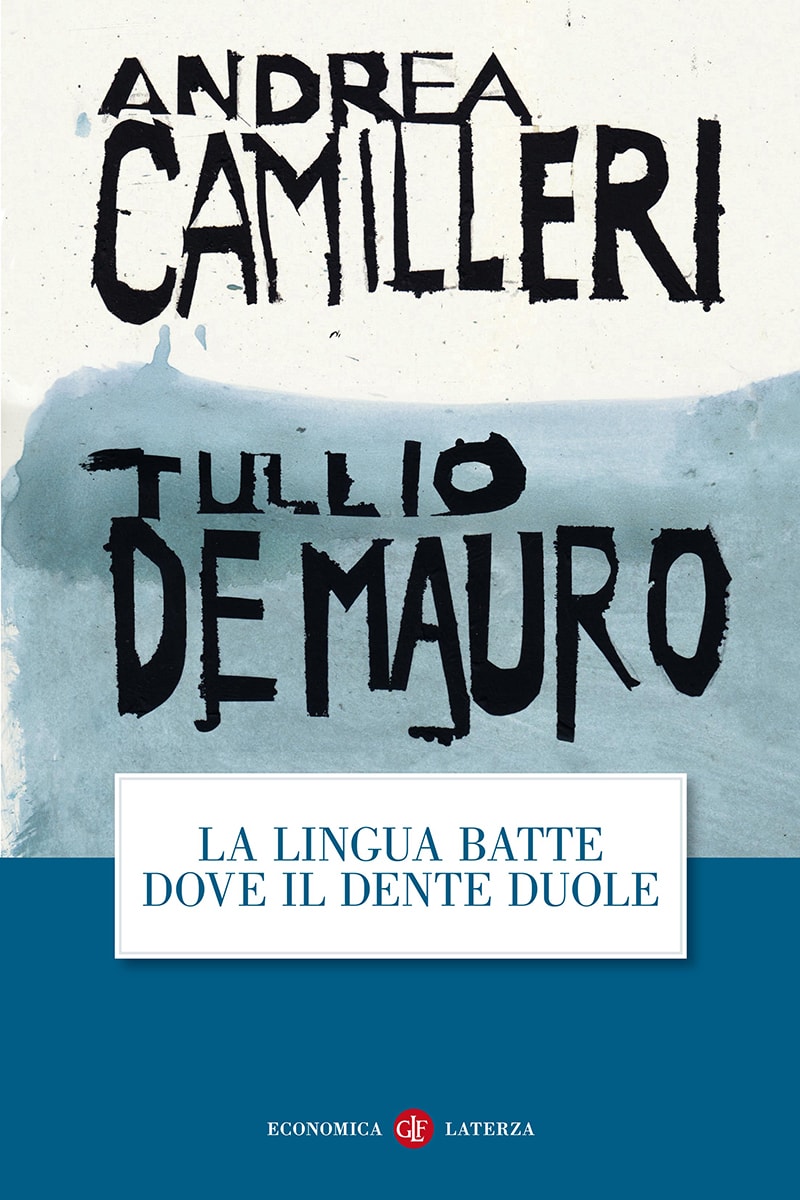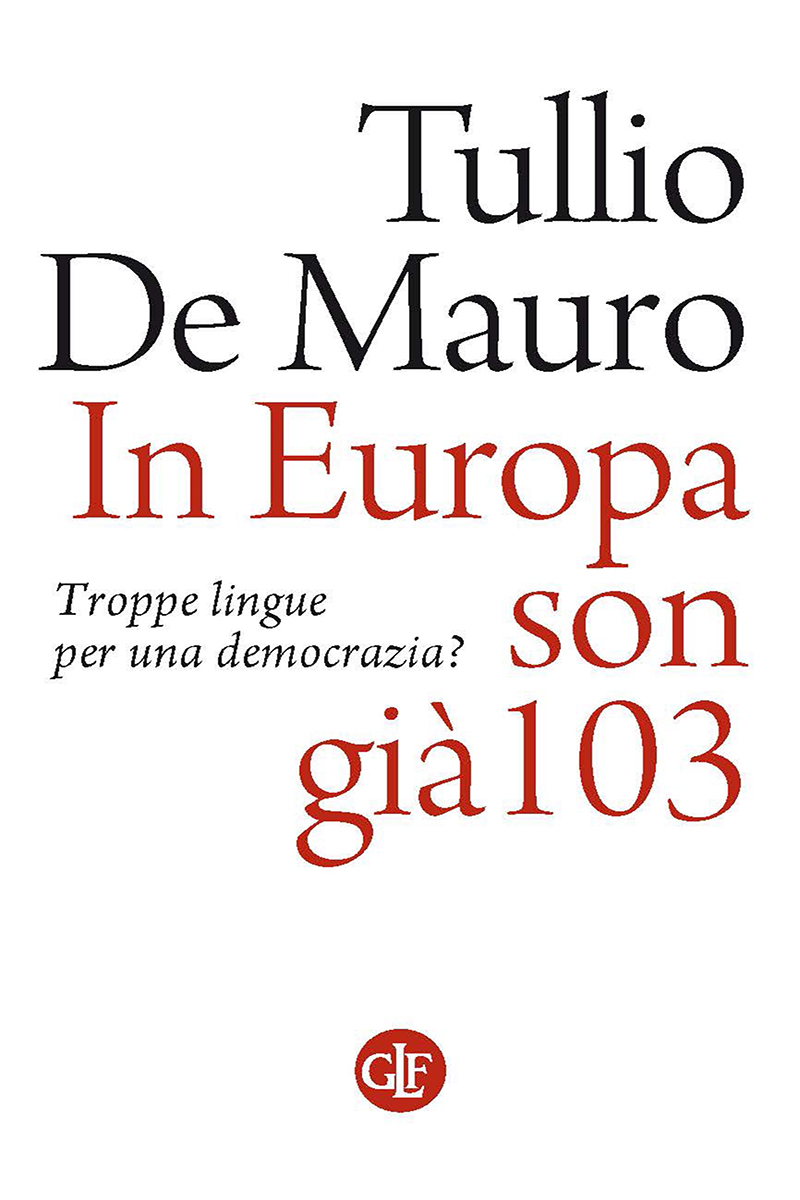Guida all'uso delle parole
«Chi scrive per dire qualcosa di utile agli altri, anche a uno solo, si chieda, finita la prima stesura, se le parole e frasi che ha scelto sono le più adatte al destinatario, le più adatte a farlo entrare nel senso che gli si voleva comunicare.» Un grande classico del più grande linguista italiano per imparare a scrivere e parlare in modo semplice e preciso.
«Scrivere ci espone al rischio della paralisi. Sappiamo bene di che vogliamo parlare, a chi, perché. Ma per la testa ci girano tutte le scelte possibili, tutti i possibili inizi. Ne buttiamo giù uno. Lo guardiamo. Non ci piace. Cancelliamo. Potremmo dire in un altro modo. Anzi, in un altro, e in un altro, e in un altro ancora. La pagina resta bianca. La paralisi tra le troppe scelte che la lingua ci concede ha vinto. Per evitare questo rischio, il miglior consiglio è cominciare comunque. Scrivere comunque, nel modo che ci capita, come ci viene. Ma questo consiglio ha un gemello, un fratello siamese. Una volta portato a termine uno scritto in prima stesura, a quel punto comincia il lavoro, delicato e decisivo, del controllo delle parole e delle frasi. Orazio, il poeta latino, consigliava di lasciar sei mesi nel cassetto ogni scritto. E di tornare poi a leggerlo con occhi fatti estranei. Ci accorgiamo allora bene di una quantità di difetti di ideazione e di espressione verbale che in un primo momento non avevamo sospettato. Non sempre possiamo aspettare sei mesi. La lettera va scritta, il rapporto finito per domani, l’articolo va buttato giù subito, per la relazione o il componimento di scuola abbiamo solo poche ore. Vale allora tanto più il primo consiglio: cominciare comunque, arrivare comunque in porto. E poi rileggere, strappare via aggettivi inutili, tagliare verbi inutili, sradicare frasi che ripetono il già detto, spuntare espressioni enfatiche, depennare luoghi comuni. Abbreviare e pulire. E, una volta fatto questo, anche per le parole e frasi, cercare di mettersi a guardare a quello che abbiamo scritto con occhi estranei, con gli occhi di chi, forse, leggerà.»