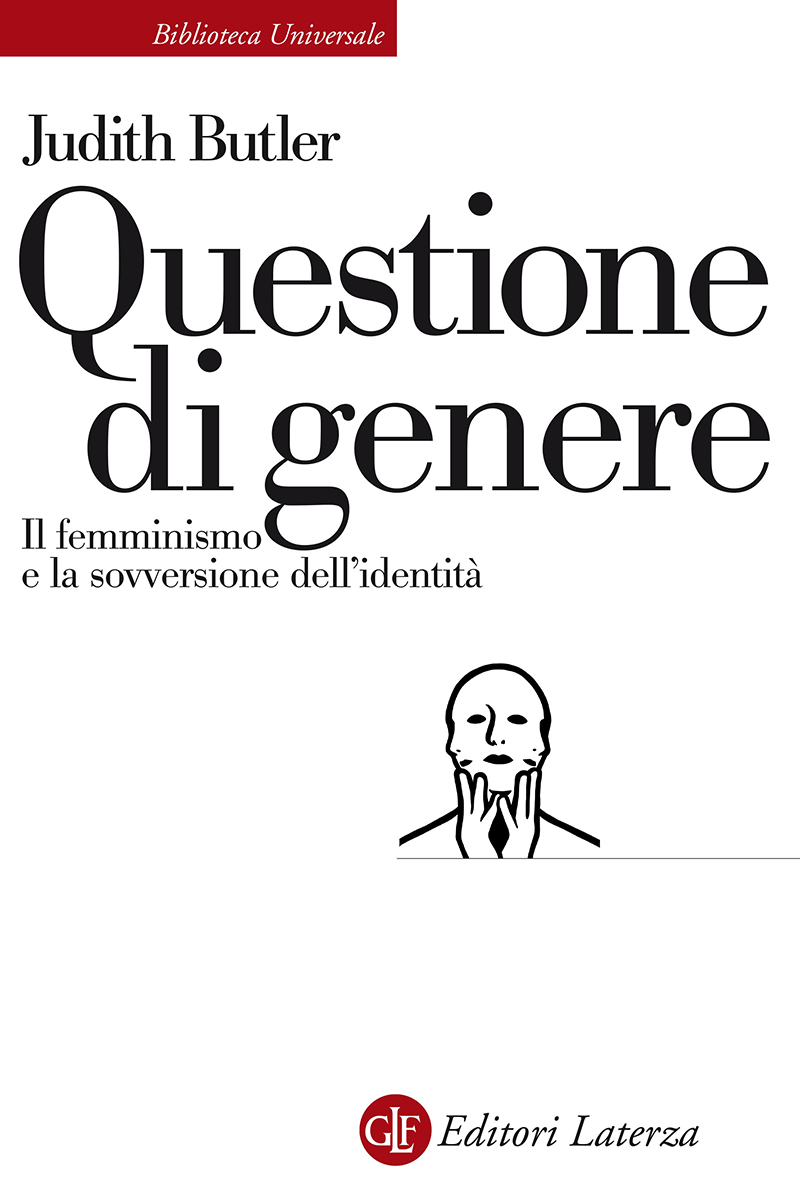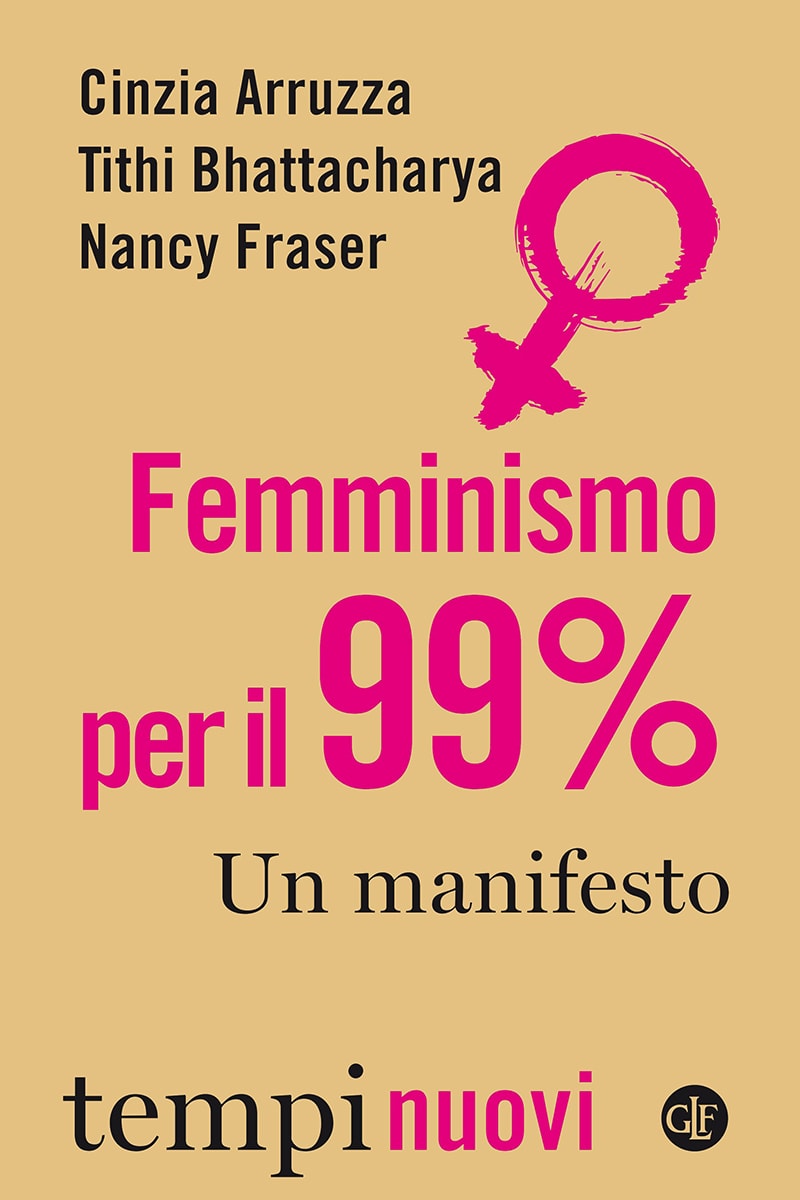Hate speech
Commenti sessisti, insulti razzisti, attacchi omofobici: le parole possono essere scagliate contro gli altri per deriderli, ferirli, umiliarli, e ancor più per rinchiuderli in ruoli e posizioni di inferiorità. Le parole possono essere potenti strumenti di oppressione, pesanti come pietre.
Chi parla, soprattutto se da posizioni di autorità o in contesti istituzionali, ha una pesante responsabilità: ciò che diciamo cambia i limiti di ciò che può essere detto, sposta un po’ più in là i confini di ciò che viene considerato normale, assodato, legittimo. E cambiare i limiti di ciò che può essere detto cambia allo stesso tempo i limiti di ciò che può essere fatto: ci abituiamo a una mancanza di attenzione e vigilanza sulle parole, che rende più accettabile la mancanza di vigilanza sulle azioni. Il silenzio, l’indifferenza o la superficialità con cui spesso accogliamo gli usi offensivi di altri corrono il rischio di trasformarsi in consenso, approvazione, legittimazione – e muta noi in complici e conniventi.Così il libro indaga una delle declinazioni più interessanti del tema della violenza: quello che è diventato comune chiamare hate speech (‘linguaggio d’odio’ o ‘discorso d’odio’). Con questo termine si indicano espressioni e frasi che comunicano derisione, disprezzo e ostilità verso gruppi sociali e verso individui in virtù della loro mera appartenenza a un gruppo; le categorie bersaglio dei discorsi d’odio vengono identificate sulla base di tratti sociali come etnia, religione, genere, orientamento sessuale, (dis)abilità. Lo hate speech raccoglie usi discorsivi estremamente vari: dalla propaganda nazista alle leggi sull’apartheid, dal discorso ideologico di certe formazioni politiche fino agli esempi quotidiani di linguaggio d’odio divenuti ormai tristemente frequenti. Un tema diventato ancor più d’attualità con il diffondersi dei nuovi media: commenti sessisti, insulti razzisti e attacchi omofobici hanno trovato un ambiente ideale per esprimersi online, dove spesso mancano mediazioni, filtri o (auto)censure.