La caduta
L’anno moriva dolcemente. Ma il 21 dicembre 2022 risultai positivo al covid, e il 27, primo giorno di libertà (o di negatività al virus, se vogliamo dargli un tono dialettico), mi sono spaccato il braccio sinistro su un sasso a Matera: omero scomposto, questa la diagnosi. Una botta, in tanti sensi, e in qualche modo una illuminazione. E una riflessione, nel momento in cui, sotto la forma di un incidente banale, una caduta e un braccio rotto, la vita sembra darci un avviso e suggerirci che tutto quello che avevamo ritenuto stabile, robusto, assodato, potrebbe andare in pezzi come l’omero che sbatte sul taglio vivo di un gradino bianco, abbagliante, illuminato da un sole invernale ma più brillante che mai.
La botta ha generato un omero decostruito, non solo nel senso che la composizione fisica della testa dell’omero era variata, e si doveva aspettare con pazienza un lavorio di ricostruzione, callificazione, calcificazione, mentre un processo del genere aveva luogo, in parallelo, nello spirito del dislocato e del decostruito, del fuor di sesto e del fuor di testa che ero diventato non solo e non tanto per l’incidente, quanto piuttosto per la piega che aveva preso la mia vita. Fuor di sesto appariva infatti, ed è apparsa per tanti mesi (e in parte tutt’ora, siamo franchi) la mia vita, con tutti i programmi messi sottosopra e insieme rimessi in discussione. Così, riassestare l’omero scomposto e l’ometto sconvolto che ne era detentore ha preso del tempo e minaccia di prenderne a voi.
 Diciamo, a voler essere ottimisti, che ha occupato uno spazio anche più ampio di quello che va dal solstizio d’inverno, giorno della positività al covid (e passando da un equinozio di primavera che vorrei poter dimenticare) al solstizio d’estate. In quel giorno, cortesemente invitato dalla mia Università a tenere una breve allocuzione sul significato della conoscenza, soprattutto in ambito umanistico, ho dato una primissima forma ad appunti, note, frammenti e scritti vari sull’“imparare a vivere” che ero venuto accumulando negli anni e che l’incidente aveva – è il caso di dirlo – fatti precipitare.
Diciamo, a voler essere ottimisti, che ha occupato uno spazio anche più ampio di quello che va dal solstizio d’inverno, giorno della positività al covid (e passando da un equinozio di primavera che vorrei poter dimenticare) al solstizio d’estate. In quel giorno, cortesemente invitato dalla mia Università a tenere una breve allocuzione sul significato della conoscenza, soprattutto in ambito umanistico, ho dato una primissima forma ad appunti, note, frammenti e scritti vari sull’“imparare a vivere” che ero venuto accumulando negli anni e che l’incidente aveva – è il caso di dirlo – fatti precipitare.
Quegli appunti, ovviamente, non contavo di leggerli per intero agli astanti, che ne sarebbero stati sbigottiti, costernati, annoiati; non avrei osato sfidare a tal punto il buon senso e la buona educazione (il tempo assegnatomi era venticinque minuti). Inoltre, a volte, i frammenti erano parte di riflessioni personali o di scritti occasionali composti in precedenza. In molti altri casi, invece, si è trattato di aggiunte e di sviluppi nati da seconde, terze e quarte stesure in un libro la cui dimensione è smilza ma la stesura è stata laboriosa perché non è uno dei tanti libri che, per lavoro, per passione, spero non per abitudine, ho scritto in vita mia.
In queste pagine, per esser chiari, non si tratta di filosofia. Nella materia e nella forma vi trovate di fronte a un mélange di argomenti che ruotano intorno alla vita e a come si possa imparare a vivere. Non siamo ai brevi cenni sull’universo, insomma, ma poco ci manca. Il loro scopo non vuole essere autobiografico, ma rappresenta un tentativo di mettere a fuoco, a grandi linee, la galassia di sentimenti, risentimenti e ragionamenti emersi nell’era dell’osso dissestato e del tempo disossato, diventato più informe e fluido, tra impegni che sparivano per indisponibilità fisica e poi corse ad ostacoli per recuperare in affanno gli appuntamenti mancati.
Con tutta questa insistenza sul dissesto e sul fuor di sesto ovviamente ho in mente Shakespeare. The time is out of joint: O cursed spite, That ever I was born to set it right! Così Amleto, succube di quella droga pesantissima che è l’autocommiserazione. “I tempi sono fuor di sesto; brutta sorte, che io debba essere nato per mettere ordine!” Così il principe depresso, alla fine del primo atto, lamentando le condizioni del regno di Danimarca.
“Out of joint” è la disfunzione di un oggetto tecnico (dunque anche di un omero scomposto, se consideriamo il corpo come una macchina chiamata a servire le nostre volontà). Ma è anche il malfunzionamento del tempo, che esce dalle sue coordinate, dalla scansione regolare che le nostre occupazioni e le nostre abitudini gli avevano dato. Un tempo che, come una porta rotta, è scardinato o sgangherato: talvolta, infatti, il verso si traduce con “il tempo è uscito dai suoi cardini”, oppure – con una espressione che ormai si usa quasi soltanto come la metafora di uno stato d’animo alterato – “è fuori dai gangheri”. Per parte sua, Amleto si sente chiamato a una azione che è, insieme, tecnica e politica, manuale e spirituale: “to set it right”. Aggiustare, anzi, proponiamo, “riparare”, perché non solo in Danimarca c’è bisogno di una azione tecnologica e umanistica per rimettere in sesto i tempi, le vite collettive così come i destini individuali.
Lungi da me aspirazioni così titaniche. Titanica e ciclopica è apparsa, già da sola, l’idea di raccapezzarsi in una vita diventata friabile e scoperta, “offesa”, come recita il sottotitolo dei Minima moralia di Adorno, “Meditazioni della vita offesa”, con un termine che si usa anche in medicina (“l’arto offeso”). Mi è costata, come si può immaginare, tanta fatica. Forse uno sperpero che ha attinto a tutte le forze di autoanalisi che potevano nascere, per un paradosso che non è tale, dalla comprensione di ciò che non ho conosciuto se non per quella forma particolarmente insidiosa di “sentito dire” che è la letteratura e la saggistica. Perché questo mio libretto deriva non solo dall’esperienza viva e dai vari eventi, fausti o infausti che la caratterizzano, ma anche, se non più, dai libri, dalle scritture, dalle storie e dai racconti, da quel mormorio indistinto, industrioso e industriale, che chiamiamo “letteratura”.
Così, la residenza e la resilienza coatte successive all’incidente mi hanno suggerito di passare, con un semplice cambio di accento, a Omèro, provando a dare forma (dopotutto, il braccio era quello sinistro) a un’idea che mi portavo dietro da tempo, sebbene in forma alquanto sconnessa anche lei. Ossia entrare e soggiornare in un mondo strutturalmente frantumato, come frantumate e disperse sono, con uno sguardo retrospettivo non troppo indulgente, le vite degli umani, anche di coloro (statisticamente, la maggioranza) il cui omero non è fuori dai gangheri.
Un Òmero o Omèro, insomma, letterariamente spezzettato, non proprio come un ossobuco, ma di certo fatto a pezzi, ed è per questo che il modo in cui presenterò questo imperfetto tentativo di riparazione consiste in frammenti o rappresentazioni, aforismi della vita e aneddoti del pensiero in cui, mi auguro, riuscirò a riassestare, se non l’osso, lo spirito; visto che un calzino rammendato rimane rammendato e un osso calcificato è più robusto, ma non è più lo stesso, mentre può darsi il caso che le ferite dello spirito si ricompongano. Quando un inciampo ci suggerisce che forse non abbiamo ancora imparato a vivere, vale la pena di tentare ancora una volta, sperando in una brezza favorevole che ci disincagli dalla secca (come diceva Valéry? “Il vento si leva!… Bisogna provare a vivere”).
Prima di concludere questo esordio, vorrei spendere qualche parola per motivare la suddivisione degli argomenti. Quanto segue è, in fondo, una cauta apologia della tradizione tecnoumanistica, ossia umanistica in quanto tecnologica, e viceversa. Il che significa semplicemente questo: di apologie dell’umanesimo come fonte di ogni bene è pieno il mondo, così come, d’altra parte, le librerie traboccano di libri il cui scopo è metterci sull’avviso circa i pericoli con cui la tecnica onnipotente minaccia l’umano, scatenando una battaglia in cui si vaticina il trionfo dell’intelligenza artificiale che soggiogherà l’intelligenza naturale.
Sono radicalmente scettico rispetto a questa versione, semplicemente perché l’umano è l’impasto inestricabile tra un organismo, come tale portatore di bisogni e di fini, e una serie di mezzi – dai più rudimentali attrezzi all’intelligenza artificiale, e soprattutto al mondo sociale, che è il più complesso fra gli apparati tecnologici che abbiamo costruito e che ci definisce –: per cui l’ultima iniziativa, la decisione fausta o infausta, rimarrà sempre all’umano. Senza mai dimenticare, tuttavia, che l’umano come costrutto naturale e sociale, il protagonista della bella favola che ci raccontiamo (“da animali a dèi”), non è che il testimone secondario di eventi che hanno avuto inizio prima della sua comparsa e che si concluderanno in anni di cui avrà perso il conto perché sarà sparito da chissà quanto tempo. È dunque su questo batter d’occhio della storia naturale, e su una porzione infima, quella che ho visto e vissuto io, direttamente o attraverso la cultura, che si concentrano le quattro stazioni di questo percorso.
La prima, “Vivere”, si domanda che cosa significhi imparare qualcosa in merito al processo vitale in cui ogni umano si trova coinvolto, volente, nolente e spesso dolente. Che cos’è quell’evento, oscuro e controverso, in cui ci troviamo avviluppati dalla nascita alla morte, quel puzzle composto di primi giorni di scuola e di appuntamenti mancati, di viaggi indimenticabili perché stupendi o orrendi, di conti al ristorante, di figli che nascono, di amici che muoiono, di giornate che non vogliono finire? Val la pena di chiederselo perché non è assolutamente chiaro che cosa significhi “vivere”, tanto nel senso biologico della nostra prima natura, quanto in quello sociale, psicologico e culturale, della nostra seconda natura. E ancor meno chiaro è capire se e come sia possibile imparare a vivere, o quantomeno capacitarsi di quel che accade, fra peripezie e noia, pietà e terrore, timori, tremori e inaspettate felicità. Come ci si raccapezza? E, soprattutto, chi ci assicura che tutto questo sia solo l’illusione di capire e dar senso a ciò che non è detto che ne possieda? Anzi, che a stretto rigore di senso non ne ha, trattandosi di una infiammazione locale e passeggera, che sia la vita di un umano rispetto alla società o della vita in generale rispetto agli spazi e ai tempi dell’inorganico.
La seconda stazione, “Sopravvivere”, è dedicata invece ai molteplici e manchevoli tentativi che noi umani abbiamo escogitato per darci un’altra chance, altra vita dopo la vita. Un modo di prolungarla come Shahrazād con il suo sultano. Per esempio, minimalisticamente e massimalisticamente insieme, di celebrare un trionfo della fama sulla morte, cercando di lasciare qualche vestigio dopo che tutto è finito per noi. Con il dubbio risultato di consumare – su papiro o al computer, come me in questo momento – del tempo utile per far qualcosa di buono, se non per noi, almeno per altri. E sì che ce ne sarebbero di cose da fare, dal tagliar l’erba in giardino alla raccolta differenziata dei rifiuti; mentre spesso dilapidiamo i nostri giorni nel raccogliere e custodire le tracce da lasciare per il futuro, come i kamikaze che, prima delle loro missioni senza ritorno, deponevano in un astuccio le loro unghie e i loro capelli, tutto ciò che era destinato – se il termine non suonasse totalmente inappropriato – a sopravvivere allo schianto.
La terza stazione, “Previvere”, riguarda la giovinezza, l’unica fase della vita in cui abbiamo davanti tanto tempo, almeno in linea di principio e dando credito alle statistiche. Non è necessariamente un’età allegra, e personalmente non ne nutro alcun particolare rimpianto. Non sappiamo cosa ci riserva la vita che verrà, qui, sulla terra. La guardiamo spingendoci in avanti come qualcosa che non c’è ancora, anche se ci siamo già dentro sino al collo. Un po’ come, finita la scuola, i primi giorni non contavano come vacanza perché quella vera iniziava con la partenza per il mare. Certo si è colmi di speranze che non hanno nome e di curiosità ingenue o bizzarre, e la prefigurazione del dolore non è così limpida e tremenda come da adulti. E poi da adolescenti, si dice, si sottostimano i pericoli per via dei neuroni sovrabbondanti e non ancora stabilizzati. È in questi anni che, per farsi un’idea di come la vita può accadere, si leggono molti romanzi, ci si appassiona alla vita degli altri, scritta o vissuta. La letteratura entra in noi, un po’ come le fiabe nell’infanzia, e prosegue a modellare una natura che non è mai prima, è sempre seconda, contaminata, influenzata, condizionata.
La quarta e ultima stazione, “Convivere”, raccoglie il sugo della storia. A lungo anch’io mi sono coricato di buonora, maledicendo le portiere delle auto che si chiudevano sbattendo e dei motori di avviamento di quelli che uscivano dall’ultimo spettacolo di un cinema vicino alla casa in cui vivevo da bambino e da ragazzo. Per un periodo ancora più lungo, per decenni, fino forse al giorno della caduta, ho coltivato il mito di una vita non dico eroica ma quantomeno solitaria, un po’ come Faust nel suo studio. Di certo per l’influenza delle letture fatte, ma anche per una questione di carattere. Il convivere mi sembrava un obbligo imposto dalla nostra natura di animali sociali, una sorta di caduta e di ingiunzione sociologica o zoologica. La convivialità restava confinata a ricreazioni più o meno obbligate, a pranzi di famiglia e simili (le feste di compleanno tra compagni di scuola erano ancora una rarità), mentre la vita beata, che spesso confondevo con la vita attiva, anzi, fattiva, e principalmente solitaria, era un gioco aperto e spesso promettente.
La grande bellezza l’ho trovata per lungo tempo in certi agosti torinesi degli anni Settanta del secolo scorso, con la città deserta, la casa vuota, la tesi da scrivere perdendo un mare di tempo in letture secondarie e marginali. Oggi mi chiedo chi me lo facesse fare e cosa ci trovassi di bello nelle fantasticherie di un passeggiatore solitario che attraversava piazze e strade deserte come dopo un attacco nucleare o il passaggio della peste nera. Non c’era niente di bello, se non la speranza, sfocata al punto da non farmi capire che se c’è un senso del vivere sta proprio nel convivere, nel passare il proprio tempo con i propri simili, e nell’eleggerne alcuni come portatori di significati unici. Come diceva Rabelais? “Non costruisco che pietre vive, sono degli uomini.” E le pietre, lasciate sole, combinano poco, magari sono d’inciampo, e di sicuro non costruiscono niente; soprattutto se sono vive, e dunque non sono pietre, ma organismi destinati, in solitudine, a morire di fame, o di sete, o di noia.
Per simmetria con questo prologo o apologo, chiuderò con una coda, in senso zoologico o musicale, come si preferirà, o magari con una coda di paglia, che fa da controcanto alla caduta che ho appena raccontato, e costituisce l’inventario di quello che mi sembra di avere imparato in un corso di vita che, purtroppo ma in realtà per fortuna (avrei potuto essere caro agli dèi e morire giovane), è ormai lungo abbastanza da avermi fatto superare quella sottile linea rossa che separa l’uomo maturo dal vecchio. Ma anche il prologo si è fatto troppo lungo, è tempo di passare dai parerga all’ergon, dalla cornice al quadro, sperando che non vi deluda troppo (e qualora ciò avvenisse, beninteso, “credete che non s’è fatto apposta”).
[>> Maurizio Ferraris, Imparare a vivere]
 L’analisi individua la causa di tale incapacità nell’interpretazione del sesto comandamento quale divieto di commettere «atti impuri», secondo una «concezione di sessualità tipica di un gruppo umano che si difende stabilendo le regole di purezza», spiega l’autrice, col risultato di rinchiudere «ogni peccatore dentro sé stesso, nel tentativo di cancellare l’impurità». Si è finito così per colpevolizzare la vittima, in fondo sempre complice, senza lasciar «spazio per il partner sessuale come persona».
L’analisi individua la causa di tale incapacità nell’interpretazione del sesto comandamento quale divieto di commettere «atti impuri», secondo una «concezione di sessualità tipica di un gruppo umano che si difende stabilendo le regole di purezza», spiega l’autrice, col risultato di rinchiudere «ogni peccatore dentro sé stesso, nel tentativo di cancellare l’impurità». Si è finito così per colpevolizzare la vittima, in fondo sempre complice, senza lasciar «spazio per il partner sessuale come persona».








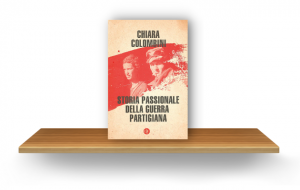 L’obbiettivo dichiarato è quello di indagare su «cosa accade nell’animo e nel comportamento egli essere umani quando vivono circostanze eccezionali» e, quindi, di riflettere sui «sentimenti» di quelli che scelsero di armarsi contro i fascisti e i nazisti, sulla loro capacità di amare e di odiare, sulle loro speranze di futuro e sulla cupa realtà che li avvolgeva nel presente, sui lutti e i dolori che accompagnarono la loro lotta ma anche sulla felicità e le tempeste emotive dalle quali furono attraversate le loro vite, sospese tra l’eccezionalità di quei tempi e una grande voglia di quiete e di normalità. E poi il pensiero della morte, la paura di non essere all’altezza, di poter tradire i compagni sotto tortura, in una dimensione in cui l’eroismo, già noto, di figure come Fanciullacci o Capriolo si intreccia con i dubbi e le incertezze che, oltre che al movimento partigiano, appartenevano alla gente comune.
L’obbiettivo dichiarato è quello di indagare su «cosa accade nell’animo e nel comportamento egli essere umani quando vivono circostanze eccezionali» e, quindi, di riflettere sui «sentimenti» di quelli che scelsero di armarsi contro i fascisti e i nazisti, sulla loro capacità di amare e di odiare, sulle loro speranze di futuro e sulla cupa realtà che li avvolgeva nel presente, sui lutti e i dolori che accompagnarono la loro lotta ma anche sulla felicità e le tempeste emotive dalle quali furono attraversate le loro vite, sospese tra l’eccezionalità di quei tempi e una grande voglia di quiete e di normalità. E poi il pensiero della morte, la paura di non essere all’altezza, di poter tradire i compagni sotto tortura, in una dimensione in cui l’eroismo, già noto, di figure come Fanciullacci o Capriolo si intreccia con i dubbi e le incertezze che, oltre che al movimento partigiano, appartenevano alla gente comune.



