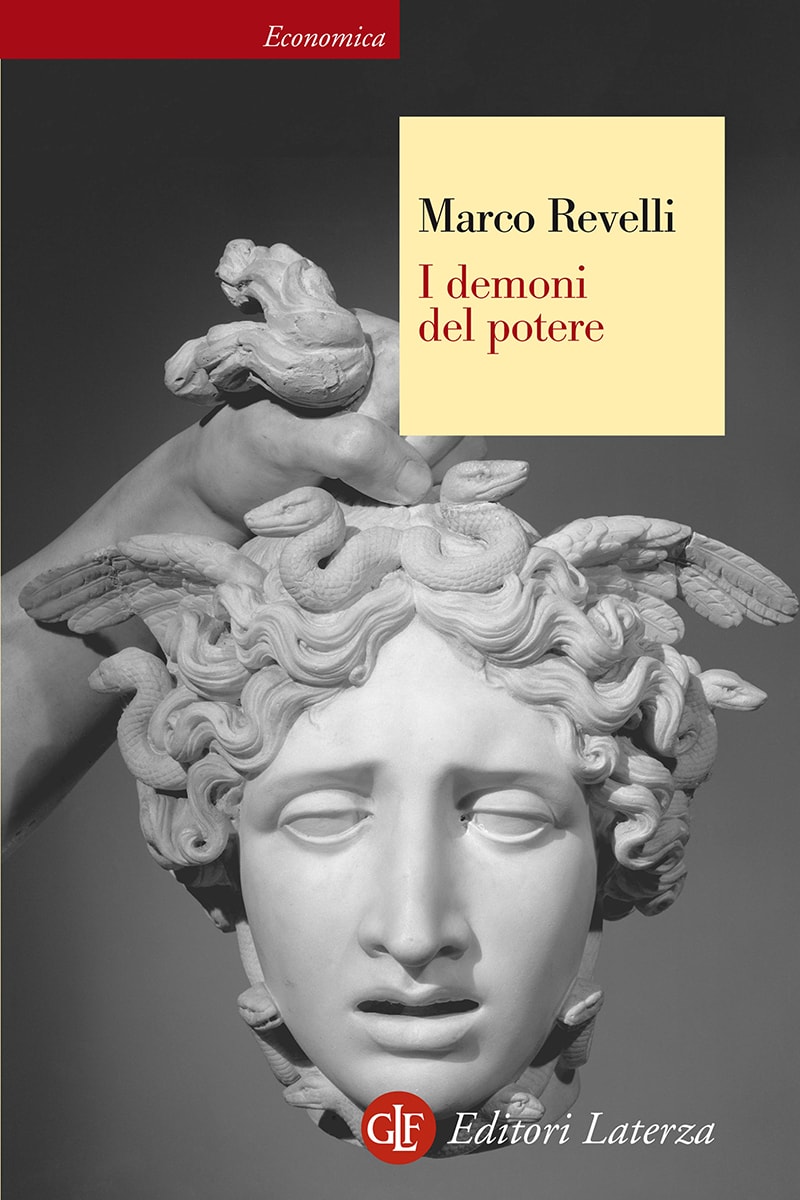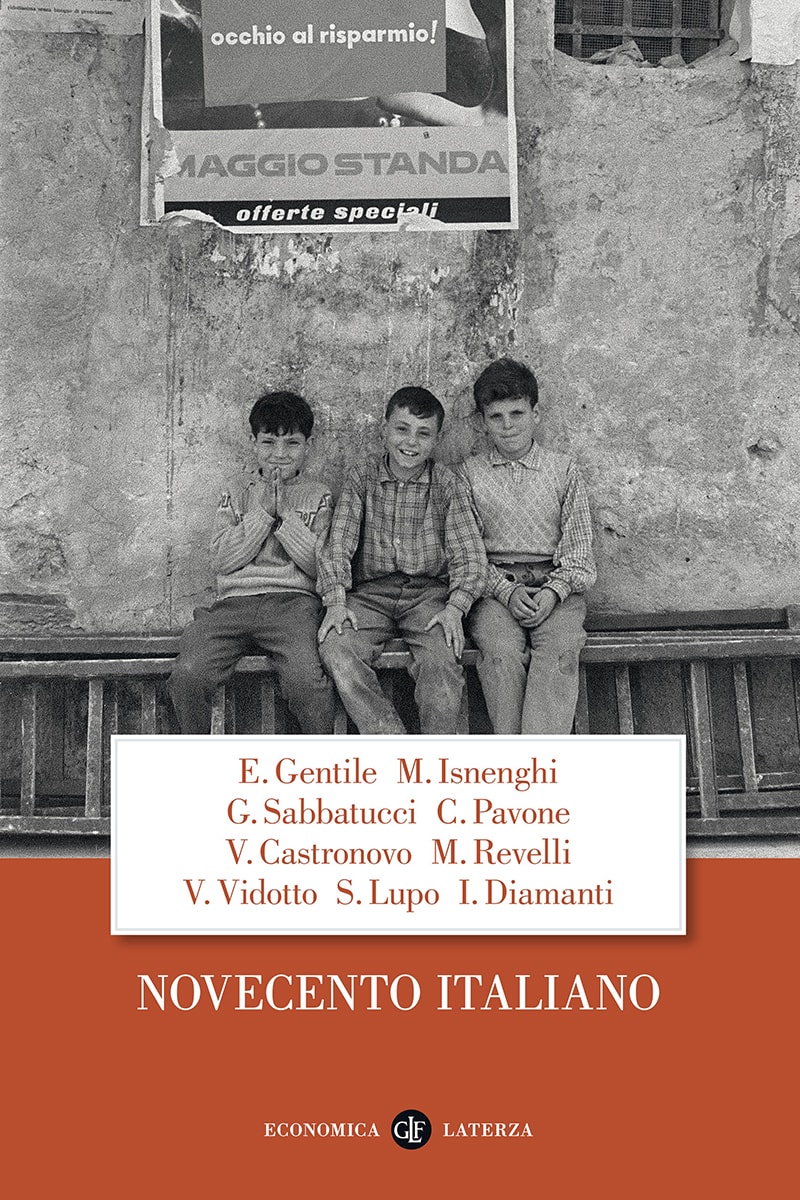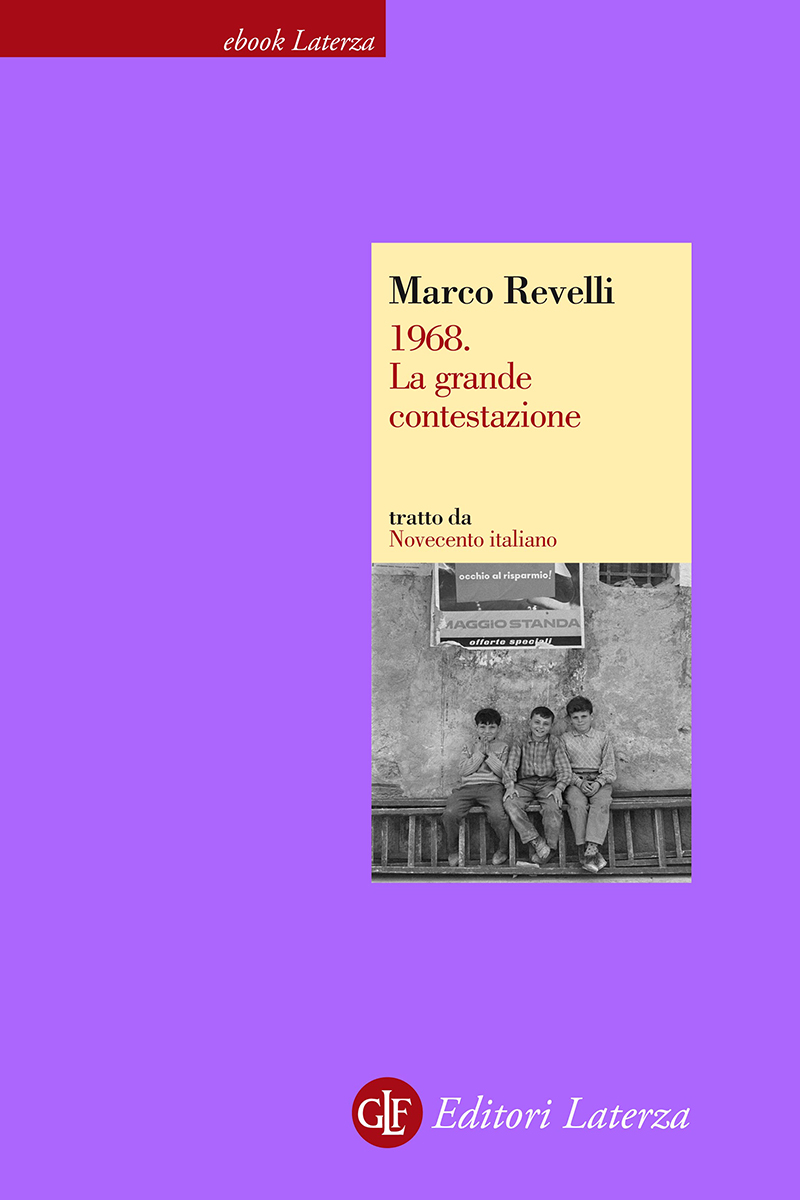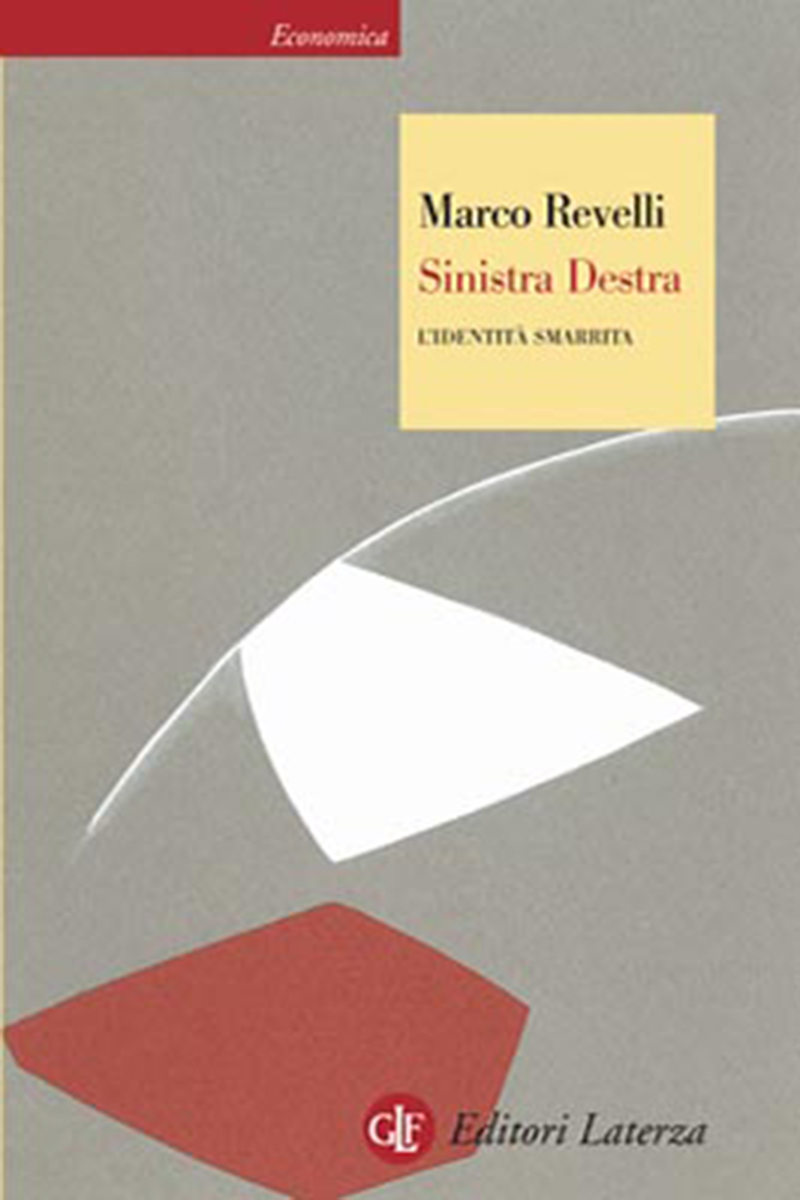I demoni del potere
Quanto più la sovranità confonde i propri tratti nel potere anonimo dei mercati finanziari, tanto più la vita di interi popoli resta non solo offesa, ma anche denudata, esposta allo sguardo pietrificante della nuova Gorgone. Un libro capace di scuotere la coscienza del lettore, spingendolo al diretto contatto con la vita offesa dei nostri giorni. Roberto Esposito, “la Repubblica”
A creare il mondo pietrificato è un potere impalpabile, immateriale, astratto. Il libro di Revelli, di rara efficacia, invita a riflettere sulle caratteristiche permanenti del potere e sull’enorme difficoltà di incatenarlo con la forza del diritto. Maurizio Viroli, “il Fatto Quotidiano”
C’è qualcosa di più selvatico dei mercati a briglia sciolta? Si tratta di allestire un nuovo rito sacrificale, pronto a qualsiasi saccheggio e a qualsiasi violenza, questa volta sull’altare dell’ottimizzazione delle risorse. Il bottino c’è ma non si deve vedere, la preda viene braccata ma dirlo non è chic. Bruno Accarino, “il manifesto”
Rassegna stampa
-
I demoni del potere
Revelli, quando il potere seduce e rende amorali
di Maurizio Viroli
-
I demoni del potere
Il potere della finanza come un antico demone
di Silvia Golfari
-
I demoni del potere
La barbarica civiltà che ha smarrito la ragione
di Bruno Accarino