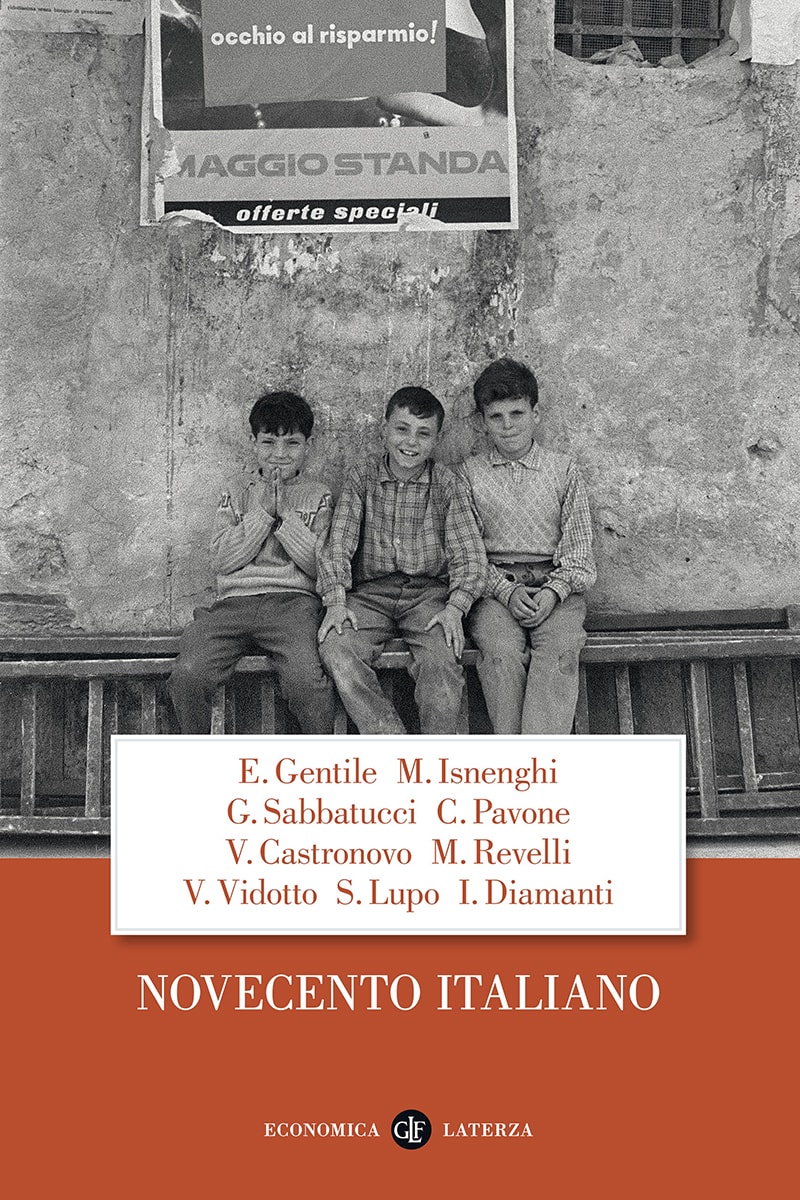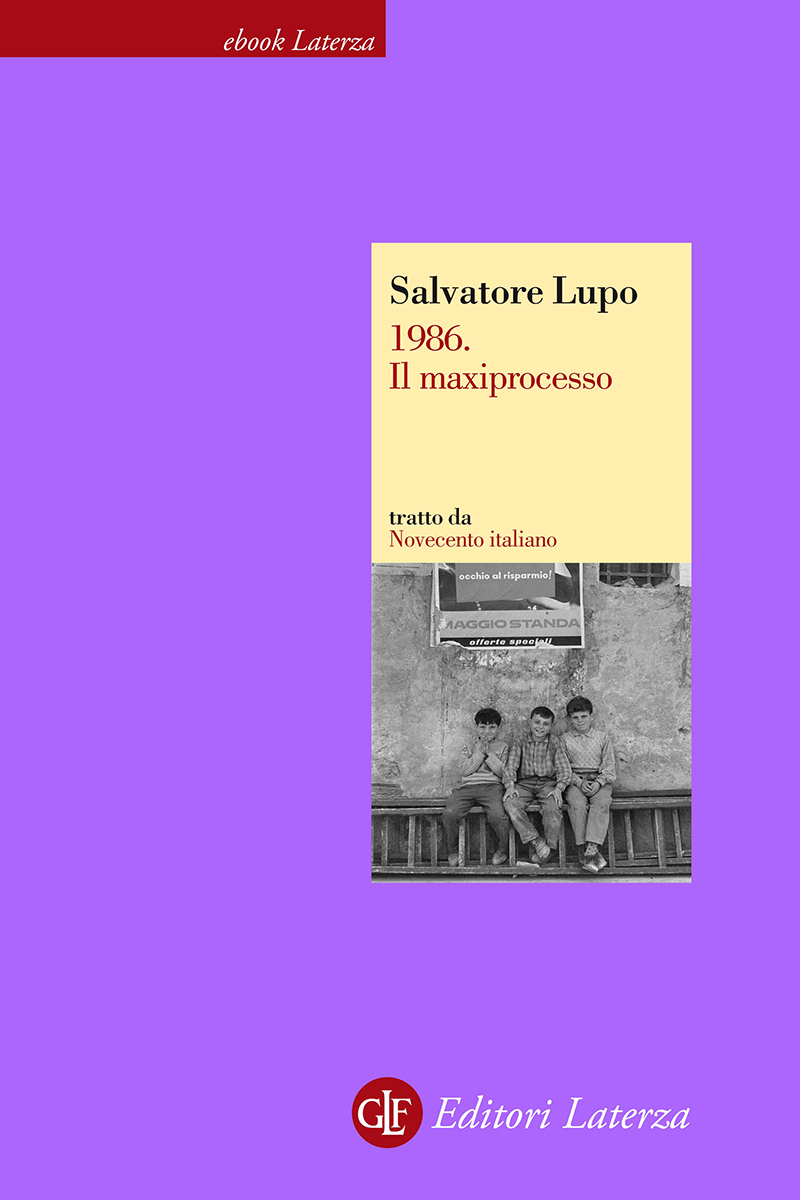Il passato del nostro presente
Questo volume disegna un ponte tra l’antico regime e la modernità: il lungo Ottocento, il periodo tra le rivoluzioni (americana e francese) e la prima guerra mondiale. È il luogo di formazione delle nostre idee e del nostro mondo, di cui però non va nascosto il carattere antico, in cui vanno riconosciute tutte le incrostazioni di una storia secolare. La scintilla dell’industrializzazione genera soggetti sociali nuovi, anche se al centro della scena rimangono protagonisti che poco hanno a che fare con essa: aristocratici, proprietari fondiari, professionisti, contadini, artigiani. Si affermano le idee di libertà, democrazia, diritti individuali, ma persistono imperi antichi e se ne formano di nuovi. Nel momento in cui l’eguaglianza viene posta a fondamento della vita collettiva, viene con altrettanta forza giustificata l’ineguaglianza, a tutela delle gerarchie che regolano il funzionamento della società. Prospettive diverse, in apparenza incompatibili, si sovrappongono formando un mix complesso che tocca ancora al nostro tempo sciogliere.
Rassegna stampa
-
Il passato del nostro presente
Salvatore Lupo, l'ottocento in accelerazione
di Romano Costa