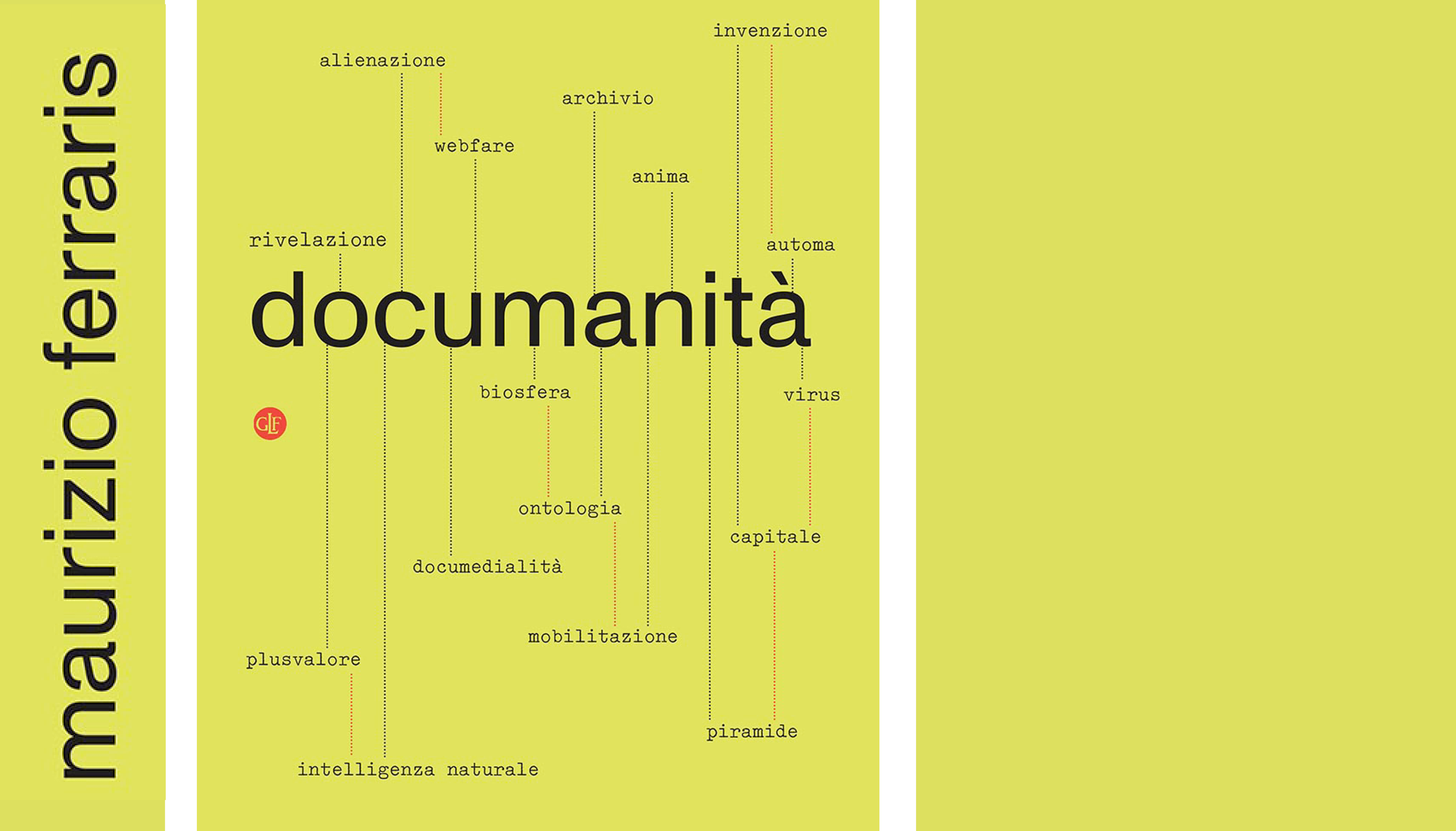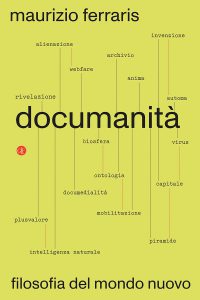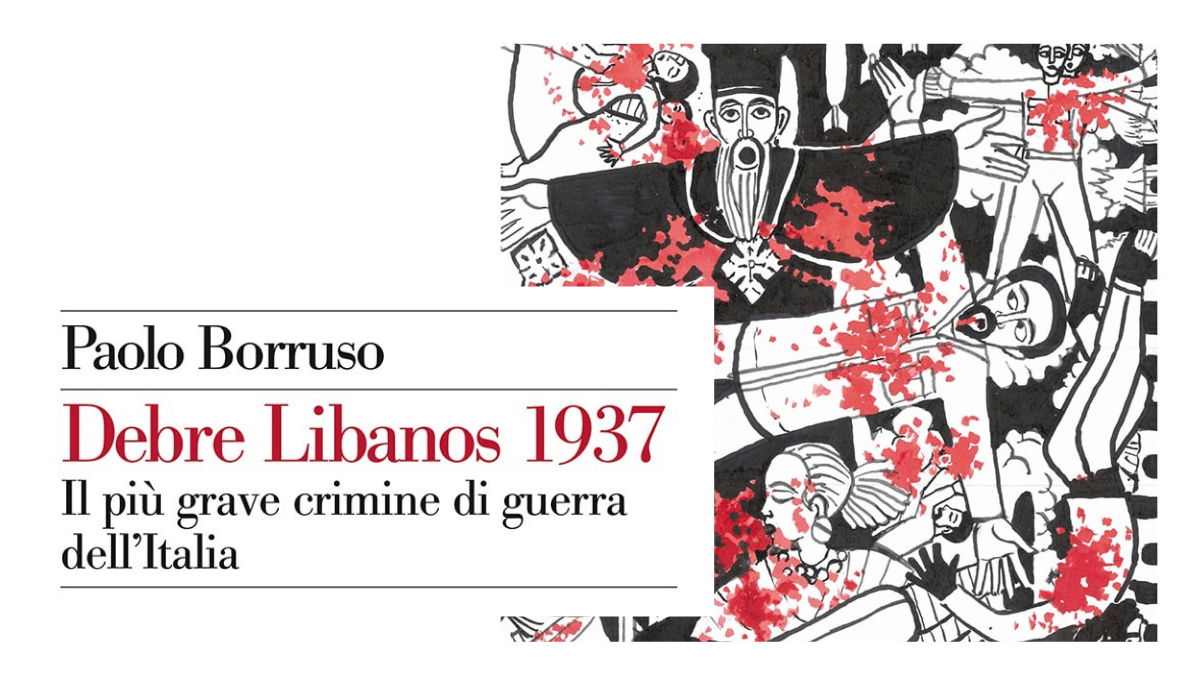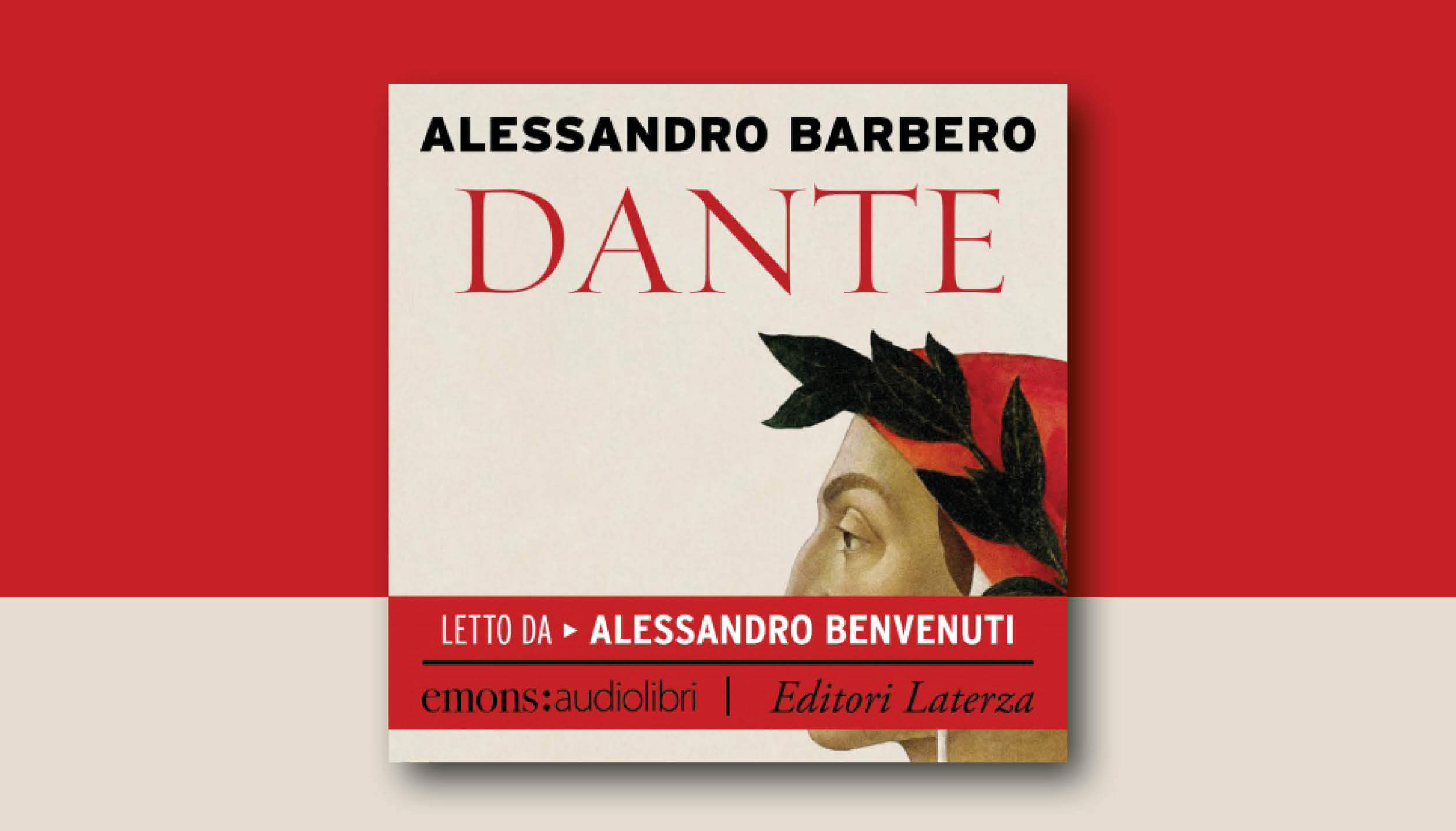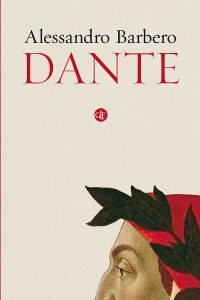“Le smanie per la villeggiatura”, la nuova rubrica estiva della pagina Facebook Lezioni di Storia Laterza, prosegue con un contributo di Massimiliano Papini.
Domenica dopo domenica, la rubrica accompagnerà i lettori alla scoperta del significato delle ‘vacanze’ e dei viaggi in diverse epoche e contesti storici, dall’antica Roma alla Germania della DDR, dai Greci dell’Odissea al Medioevo, fino all’avvento del turismo di massa, con gli scritti di Simona Colarizi, Alberto Mario Banti, Laura Pepe, Massimiliano Papini, Maria Giuseppina Muzzarelli, Alessandro Marzo Magno e Gianluca Falanga.
> Prossimo appuntamento: domenica 8 agosto,
con Maria Giuseppina Muzzarelli e Il dì di festa. Vacanze medievali, fra lussuria e penitenza.Già online il contributo di Laura Pepe.
L’otium rivelatore dei Romani
Massimiliano Papini
L’otium va aggiunto all’operosità (industria) e all’impegno (studium), benché ne sembri l’opposto: attenzione, non quello che fa svanire la virtù, ma l’altro che la ristora, con il primo da evitare anche per i pigri e il secondo da desiderare talvolta dagli attivi, affinché, dopo una rapida sospensione del lavoro, più freschi possano tornare a nuovi impegni. Qualche esempio: nel II sec. a.C. i grandi amici P. Cornelio Scipione Emiliano e C. Lelio, vagando per le spiagge di Gaeta e di Laurento, raccoglievano conchiglie e testacei. Inoltre, il giureconsulto Q. Muzio Scevola, genero di Lelio e testimone di quelle pause, si dice che fosse bravissimo nel gioco della palla, perché soleva trovarvi un diversivo con il quale distendere l’animo spossato dagli impegni forensi: sembra inoltre che egli, dopo avere bene e a lungo dato norme di diritto civile e di pratiche religiose, giocasse ai dadi e agli scacchi. Come nelle cose serie egli si atteggiava da Scevola, così negli svaghi si comportava da uomo, cui la natura non permette di affaccendarsi in modo ininterrotto. Questo riporta lo storico di età tiberiana, Valerio Massimo (VIII. 8), il quale aggiunge come persino Omero avesse concesso ad Achille di rilassarsi dalla guerra con la cetra. Il poeta d’età flavia Stazio, abituato ad allietare con il canto gli otia vitae, in un’epistola all’amico avvocato Vitorio Marcello (Silvae IV. 4), lo ritrae mentre si allontana dalla calura estiva di una Roma ormai deserta di abitanti, partiti in villeggiatura (a Praeneste, Aricia, Tibur, Tusculum): maior post otia virtus, una sentenza di nuovo giustificata con l’esempio di Achille che, dopo avere cantato Briseide e deposta la cetra, si lanciò contro Ettore con maggior ardore.
Il termine otium, non chiaro etimologicamente e traducibile con difficoltà – anzi, forse è meglio non tradurlo: è reso a volte in modo inappropriato con “vacanza” – include un ampio spettro di interessi e attività svincolato dalla sola stagione estiva e ha una valenza mutabile nel tempo ma è sempre bisognoso di una legittimazione morale, così che è tutto un fiorire di specificazioni: moderatum, honestum, litteratum…Fu un concetto non solo inteso come pausa dagli affari (negotia, altro vocabolo dalle mille sfumature) ma anche distintivo di condotte alternative, distanti dai più tradizionali modelli etici. Di contro a un otium otiosum (nel coro dell’Ifigenia di Ennio, con i soldati dell’esercito acheo a disagio per l’inattività), l’otium doveva quasi negarsi per profilarsi virtuoso. Come per il condottiero P. Scipione Africano, il quale non era mai meno otiosus di quando era otiosus né meno solo di quando era solo: parole magnifiche e degne di un grand’uomo, commenta Cicerone nella sua ultima opera filosofica (De officiis III. 1-4), che dimostrano come nell’otium egli pensasse agli affari pubblici e nella solitudine parlasse con sé stesso. Certo, l’Arpinate avrebbe voluto che di lui si fosse detto altrettanto. Ma il suo otium, ammette, non è paragonabile a quello dell’Africano. Quello, per ristorarsi dalle più insigni cariche pubbliche, a volte cercava rifugio nella solitudine, come in un porto; invece, il proprio otium era dovuto alla mancanza di negotium causata dalla disgregazione dell’autorità del Senato. Proprio Cicerone (Pro Sestio 27. 66) riteneva tra le massime più nobili in assoluto quella leggibile all’inizio delle Origines di Catone il Censore: «Gli uomini illustri e grandi devono rendere conto dell’otium non meno del negotium». Bene, ma quella massima nel periodo imperiale non parve più valida: Galba, futuro imperatore fugace (per sette mesi), sotto Nerone preferì lasciarsi andare all’inerzia per non offrirgli il minimo pretesto e non compromettersi, nella convinzione che nessuno fosse obbligato a rendere conto del proprio otium.
Cicerone usa spesso il vocabolo: quasi nella metà delle occorrenze implica pace, nel senso del ristabilimento dell’unità della res publica negli anni turbolenti delle guerre civili; qui rientra anche lo slogan politico del cum dignitate otium, lo scopo di tutti i cittadini assennati, onesti e agiati: ma la più autentica gloria è sapere procurare otium e piaceri agli altri, non a sé stessi. Che fatica però tenere a bada la voglia di otium: perché era facile che, una volta perduta la misura, collidesse con i negotia, scivolando verso vizi quali luxuria, desidia, inertia, ignavia per entrare nei discorsi moralistici intorno al declino dei più ancestrali valori romani, come nella visione di storici come Sallustio e in Tacito. Diversamente, poteva diventare, in modo negativamente paradossale, occupatum; brontola Seneca nel De brevitate vitae (12. 2) come taluni, neanche in villa, nel loro letto o in solitudine, riescano a stare in pace. Perciò la maniera di riposarsi diventa un criterio di valutazione, con risvolti tutt’altro che “privati”. In un discorso tenuto in senato il 1 settembre del 100 d.C., Plinio il Giovane elogiò Traiano quale cacciatore e timoniere: passatempi non contaminati dall’infingardaggine di un imperatore per il quale ritemprarsi significava passare da una fatica all’altra. Viceversa, il cattivo predecessore, Domiziano, è detto incapace di sopportare l’otium del lago di Albano o il sonno e il silenzio di quello di Baia e di tollerare il movimento dei remi, dal che l’abitudine di farsi trascinare a rimorchio da un’altra nave: uno spettacolo indecente. Indi il bilancio: «proprio i piaceri consentono un retto giudizio sulla gravità, la probità e l’equilibrio di un uomo. Chi è mai talmente dissoluto da non mostrare, quando è occupato, qualche parvenza di austerità? È l’otium a rivelarci. Parecchi principi non lo trascorrevano forse nel gioco dei dadi, nella libidine, nel lusso, chiedendo sollievo dalle occupazioni impegnative alla frenesia dei vizi?» (Panegyricus 82).
Quali erano i luoghi dell’otium? Già dal II sec. a.C. intorno a Roma si formò un anello di aree con giardini: horti vicini al centro dell’Urbe, con il vantaggio di assicurare l’oblio temporaneo dei negotia. Per esempio, L. Licinio Lucullo, console del 74 a.C., eccellente uomo d’armi distintosi specie in Oriente e allontanatosi dalla vita politica dopo il 63 a.C., fu famigerato come maestro di voluttuosità e per la costruzione di lussuosi edifici, per l’allestimento di passeggiate e di bagni e per la raccolta di pitture e statue con enorme dispendio di denaro. Oltre agli sfarzosi horti sul Pincio, egli possedeva magnificenti ville, tra cui una a Tusculum con una biblioteca ricca di libri preziosi e aperta a tutti i Greci (e non solo). Stando a un aneddoto, il rivale politico Pompeo gli aveva rimproverato che quella fosse disposta in modo meraviglioso per l’estate, ma che d’inverno fosse inabitabile, donde la risposta divertita: «Ti pare che io abbia meno senno delle gru e delle cicogne, da non cambiare residenza a seconda delle stagioni?». Come uccelli migratori, nei mesi invernali egli preferiva soggiornare nelle proprietà in Campania, dove ancora nella tarda antichità restava viva la memoria degli opera Lucullana. Non era anomalo il possesso di più ville, dotate ciascuna di una propria amoenitas, care ai proprietari grazie alla diversità delle posizioni nel territorio nonché del clima e in grado di offrire così diverse intensità di otium. Le ville specie nel Lazio e in Campania, oltre a permettere lo sfoggio di ricchezza adeguato al ruolo sociale dei possessori ma senza essere luoghi soltanto di lusso improduttivo, inducevano ad atteggiamenti più disinvolti rispetto a quanto tollerato nell’Urbe. Per il proprio Tusculanum, Cicerone volle impianti dai nomi evocativi della cultura greca, come xystus (nel senso di ambulacro scoperto), Lyceum con annessa biblioteca e Academia, forse consistenti in lunghi peristili porticati con vasto giardino, adatti per lo svolgimento di conversazioni letterarie: quindi era una villa non insana ma quasi philosopha, per parafrasare le parole dell’Arpinate in una lettera del 54 a.C. a proposito di quella del fratello Quinto a Laterium presso Arpino, non priva di piacevoli abbellimenti come le statue di palliati che tra gli intercolunni parevano fare giardinaggio e vendere l’edera sparsa ovunque (Ad Quintum fratrem 3. 1. 5). Il giudizio sulla scelta di una vita rilassata dipendeva dai punti di vista. Come per il ricco ex pretore Servilio Vazia, invecchiato in una villa in una posizione molto favorevole presso Cuma in Campania per sottrarsi ai rischi della politica e noto unicamente per il suo otium: «O Vazia, solo tu sai vivere», questo il ritornello del volgo ogni volta che qualcuno pativa un rovescio causato dall’instabilità del potere. Era però scontato che uno come Seneca, avverso alle esibizioni plateali dell’otium e oltretutto indifferente ai luoghi, avesse da ridire. Secondo la credenza comune l’uomo otiosus è sereno e soddisfatto di sé, ma tali privilegi spettano al sapiens; insomma, altro che saper vivere: secondo il filosofo, la condotta appartata di Vazia, l’opposto del ritiro spirituale, equivaleva all’esistenza di una bestia che si rintana impaurita (Epistulae 55).
Il rapporto tra villa e (buon) otium è celebrato al meglio nell’epistolario del senatore Plinio il Giovane, uomo colto dall’illustre cursus honorum. A Roma i lacci delle occupazioni sono soffocanti, è raro poter ascoltare in tranquillità una pubblica lettura o perdersi tra tavolette e libri (salvo nei giorni dei giochi del circo), mentre il soggiorno in villa garantisce un otium studiosum tanto prolifico da assimilarsi a un negotium e a una fatica (labor): tante letture, traduzioni dal greco al latino e viceversa, ideali competizioni con testi celebri, studio di qualche episodio della storia, scrittura di lettere e redazione di orazioni senza dimenticare le composizioni brevi e argute, anch’esse capaci di generare ristoro. È il ritiro in campagna a fare apparire un’insulsa perdita di tempo i negotia (quali il presenziare a fidanzamenti e nozze, la controfirma di un testamento, l’assistenza in tribunale, la partecipazione a un consiglio), percepiti come necessari solo il giorno in cui si compiono; si aggiungono i negotia amicorum, i doveri dell’amicizia, altro intralcio al piacevole fare nulla. Nella sua villa al mare di Laurentum, presso l’odierna Castelfusano, Plinio può ripararsi dalle chiacchiere e stare solo con sé stesso e con i propri libri in un asilo delle Muse che funge da ispirazione. Ma occorreva vigilare affinché l’otium non divenisse esagerato: in una lettera a Bruttio Presente, il quale fu attivo sotto Domiziano (come tribuno militare) e Traiano (nel ruolo di comandante di legione), di fronte alla sua assenza prolungata dall’Urbe a favore dei possedimenti lucani e campani, Plinio lo invita a tornare ogni tanto alle seccature consuete a Roma, in modo tale che i piaceri non siano affievoliti dalla sazietà, e che la solitudine risulti meglio apprezzabile. Inoltre, se alla patria va assegnata la prima parte e quella centrale della vita, l’ultima va riservata a noi stessi, come fanno capire le leggi che restituiscono gli anziani all’otium, esentandoli dall’obbligo di frequentare le sedute del senato. Conosciamo l’organizzazione di una giornata-tipo estiva di Plinio nella villa in Toscana, ubicata ai piedi degli Appennini a diciassette miglia da Roma, preferibile ad altre a Tusculum, Tibur e Praeneste: sveglia nella prima ora di sole (tra le cinque e le sei), ancora con le finestre chiuse, quand’egli lavora con il pensiero come se stesse scrivendo, scegliendo le parole e correggendole; tra le nove e mezzo e le undici a seconda del tempo, si reca in terrazza o nel criptoportico continuando a meditare e a dettare; dopodiché monta in carrozza, lavorando alla stessa maniera di quando passeggia o sta sdraiato sul letto; dorme per un po’, poi cammina; dopo la lettura ad alta voce di un’orazione greca o latina per rinvigorire i polmoni, ecco un’altra passeggiata, un massaggio, un po’ di ginnastica e un bagno; durante la cena, se da solo con sua moglie o pochi convitati, egli legge un libro, e dopo è tempo di ascoltare un attore o un suonatore di lira; la giornata si conclude con un’ennesima passeggiata in compagnia dei propri dipendenti, tra cui diversi forniti di buona cultura, per discorrere degli argomenti più disparati. Eventuali modifiche alla routine: quando riceve amici in visita o gli capita di andare a caccia, un’attività che fa bene tanto al corpo quanto al pensiero, stimolato dal movimento del corpo e dai boschi; perciò non dimentica mai di portarsi dietro le tavolette, per mettersi a scrivere persino in quelle occasioni. Nella villa di Laurentum in inverno il programma resta affine, salvo la rinuncia al pisolino pomeridiano, le notti più occupate e l’eventuale soppressione dopo la cena dell’attore o del suonatore di lira per rivedere le arringhe, giacché in quel periodo sono più frequenti le cause. Resoconti affini si conoscono per la quotidianità di alcuni imperatori, con giornate oberate dagli impegni di governo benché intervallate da momenti di maggiore calma. Ma anch’essi vagheggiavano un riposo meno effimero. A proposito di Augusto, Seneca (De brevitate vitae 4. 2-5), a riprova di come ogni discorso del principe cadesse sulla speranza dell’otium e del poter vivere per sé, dichiara di avere trovato le seguenti parole in un’epistola (del 27 a.C.?) da lui indirizzata al senato. Egli, dopo avere promesso che la sua requies sarebbe stata decorosa e all’altezza della precedente gloria, dice: «Queste cose sarebbe più bello realizzarle che prometterle. Tuttavia, poiché la gioia della realtà si fa attendere, il desiderio di quel tempo così sospirato mi ha ridotto a pregustare un po’ di piacere parlandone». Sì gran cosa gli parve l’otium, chiosa Seneca, che, non potendo goderne, lo anticipava con il pensiero, sufficiente ad alleviargli le fatiche. Era felice, Augusto, pensando al giorno in cui avrebbe deposto la sua grandezza; ma l’abbandono degli oneri connessi al potere (guerre interne ed esterne, congiure) restò l’unico sogno per un uomo in grado di appagare tutti i desideri. Altri furono instancabili lavoratori, come Marco Aurelio, convertitosi in maturità a un modus vivendi asceticamente filosofico: colui che nei Pensieri afferma che il riposo è necessario, ma la natura ci ha posto un limite, come al mangiare e al bere; quando si è davvero appassionati e si ama il proprio mestiere, si preferisce né mangiare né dormire; è sempre lui ad ammettere di desiderare posti solitari in cui ritirarsi, in campagna, sulle rive del mare, sui monti, sebbene il rifugio più sereno per un uomo sia nella propria anima. In una sofisticata lettera del 162 d.C., il retore M. Aurelio Frontone si rivolge al suo discepolo ormai diventato imperatore, certo che egli nelle ferie nella località marina di Alsium (poco distante dall’odierna Ladispoli) riserverà quattro giorni pieni di divertimento, scherzo e otium. Se lo figura disteso al sole, in un angolo esposto a mezzogiorno e nell’atto dapprima, per assecondare il sonno, di ordinare che gli siano portati dentro i libri e più tardi, quando avrà voglia di leggere, di raffinarsi con lo studio di quattro scrittori come Plauto, Accio, Lucrezio, Ennio; a quel punto magari andrà in spiaggia per salire a bordo di un battello al fine di godere nel guardare e udire rematori e capiciurma; subito dopo andrà ai bagni, inducendo il corpo a una forte sudorazione per dare in seguito inizio al convito con frutti di mare di ogni genere, volatili, manicaretti, frutti e vini a volontà. Ma Frontone è ironico e sa bene che Marco Aurelio in quel luogo intende non dare piacere al suo animo ma continuare a tormentarsi con veglie e lavoro, patendo fame e sete. Eppure, anche il mare va in vacanza nei giorni di bonaccia; e poi quale arco è teso di continuo? Quali corde sono sempre tirate? Ancora, con l’otium non si procura fertilità al suolo? Altri exempla servono a demistificare un’immagine troppo augusta del potere: Traiano, sommo combattente, si dilettava degli attori e beveva molto (non solo caccia e navigazione, dunque); Adriano, diligente sia nel reggere il mondo sia nel percorrerlo con viaggi senza sosta, era entusiasta di melodie e suonatori di flauto e aveva fama di gran mangiatore; Antonino Pio, colmo delle virtù di tutti gli imperatori, frequentava la palestra, preparava gli ami e rideva dei buffoni. Siccome Marco Aurelio ha indetto guerra allo scherzo, all’otium, alla sazietà e al piacere, alla fine Frontone deve accontentarsi di poco e lo supplica scherzosamente di dormire almeno quanto basta a un uomo libero per rispettare i limiti del giorno e della notte, senza farsi travolgere dal fardello degli obblighi giudiziari. Prova a persuaderlo mediante una breve favola sul Sonno, che Giove creò con ali alle spalle in modo tale che potesse posarsi delicatamente sugli occhi degli uomini, fornendolo di sogni piacevoli. Marco Aurelio, mentre gli altri sono a cena, legge la lettera alsiense verso le venti, disteso e soddisfatto di un cibo leggero, quasi dando retta (in minima parte) alle raccomandazioni del precettore d’un tempo, ma senza scordarsi di insistere sull’implacabilità dei doveri. No, non era facile regolare l’otium; ma altrettanto difficile era impiegarlo serenamente, senza sensi di colpa, all’interno di una società basata sul prestigio derivante dall’adempimento dei negotia.