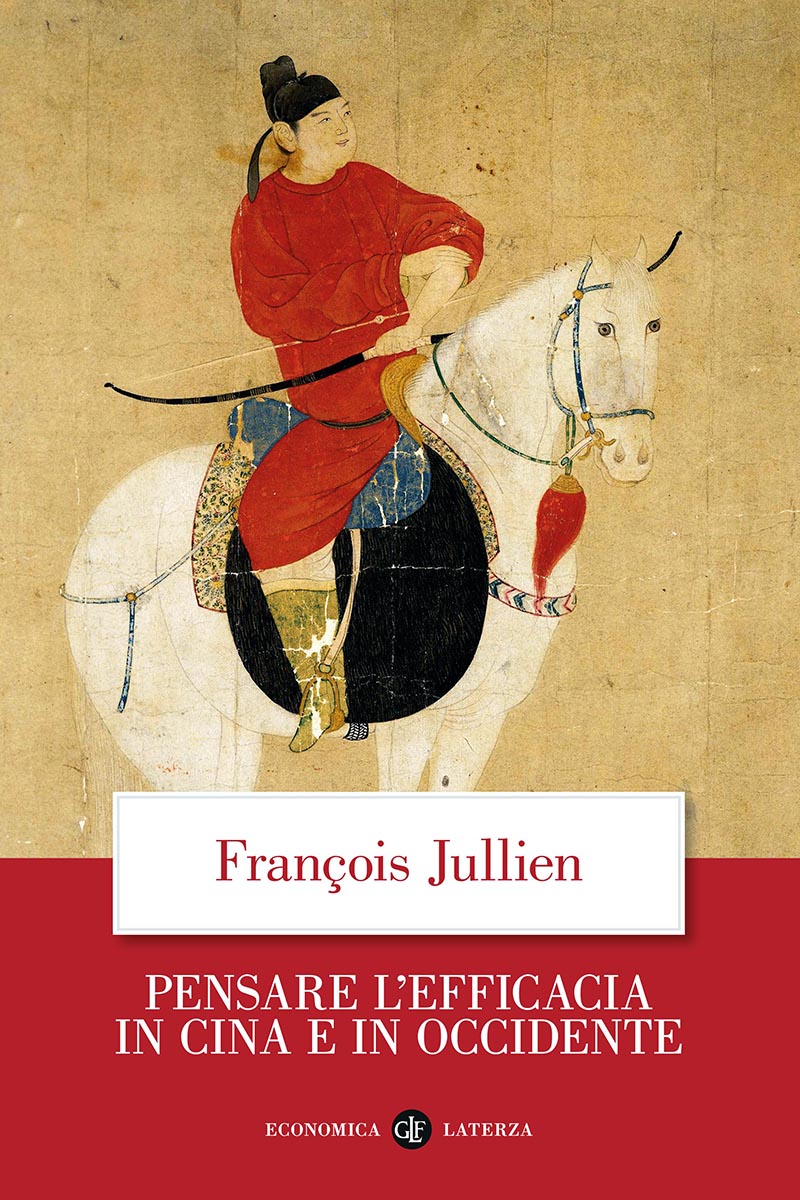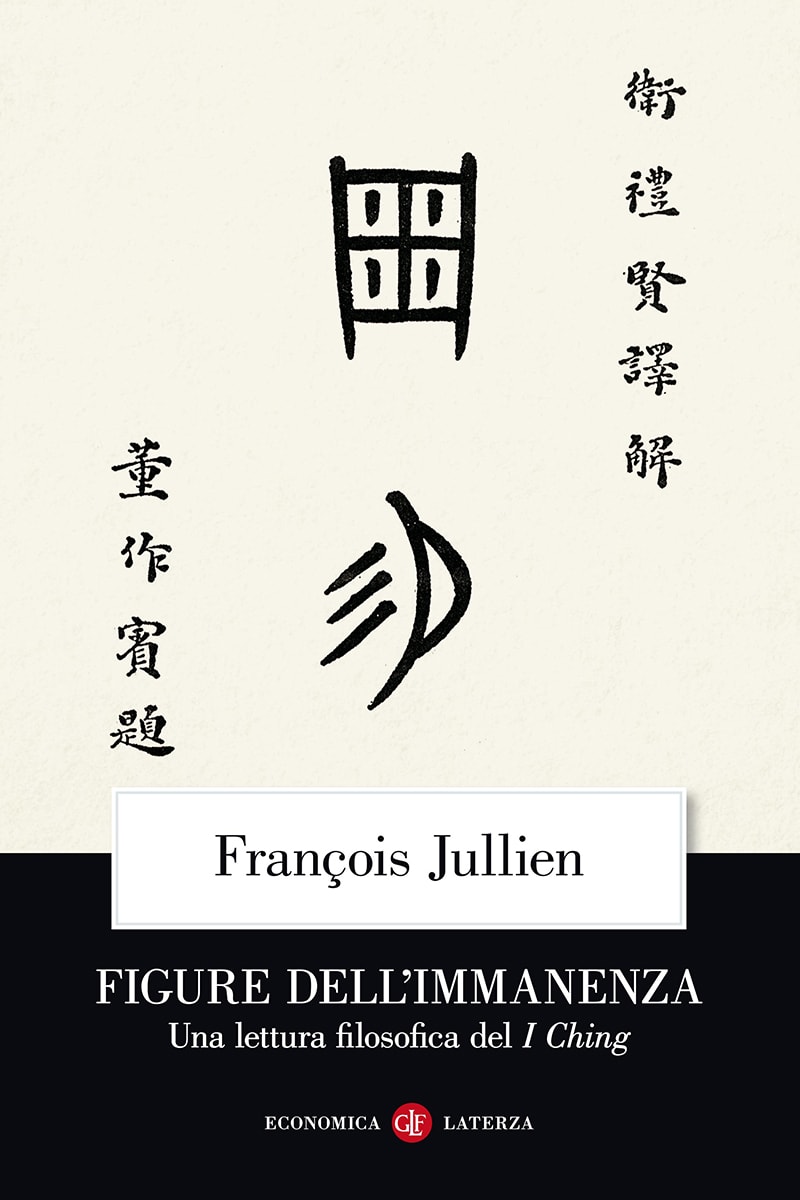Pensare l'efficacia in Cina e in Occidente
Un saggio brillante sull'immensa distanza tra il pensiero occidentale e quello cinese.
Federico Rampini, “la Repubblica”
Napoleone e Sun Tzu, il razionalismo greco e l'oracolo cinese, plasmare le situazioni o adattarsi a esse, elaborare strategie o esercitare la sapienza del non agire.
Occidentali e orientali misurano l'efficacia di un'azione secondo parametri radicalmente diversi.
François Jullien sigla un volume colto e inusuale che attinge alle sorgenti dell'immaginario delle due culture e svela due opposti sguardi sul mondo.