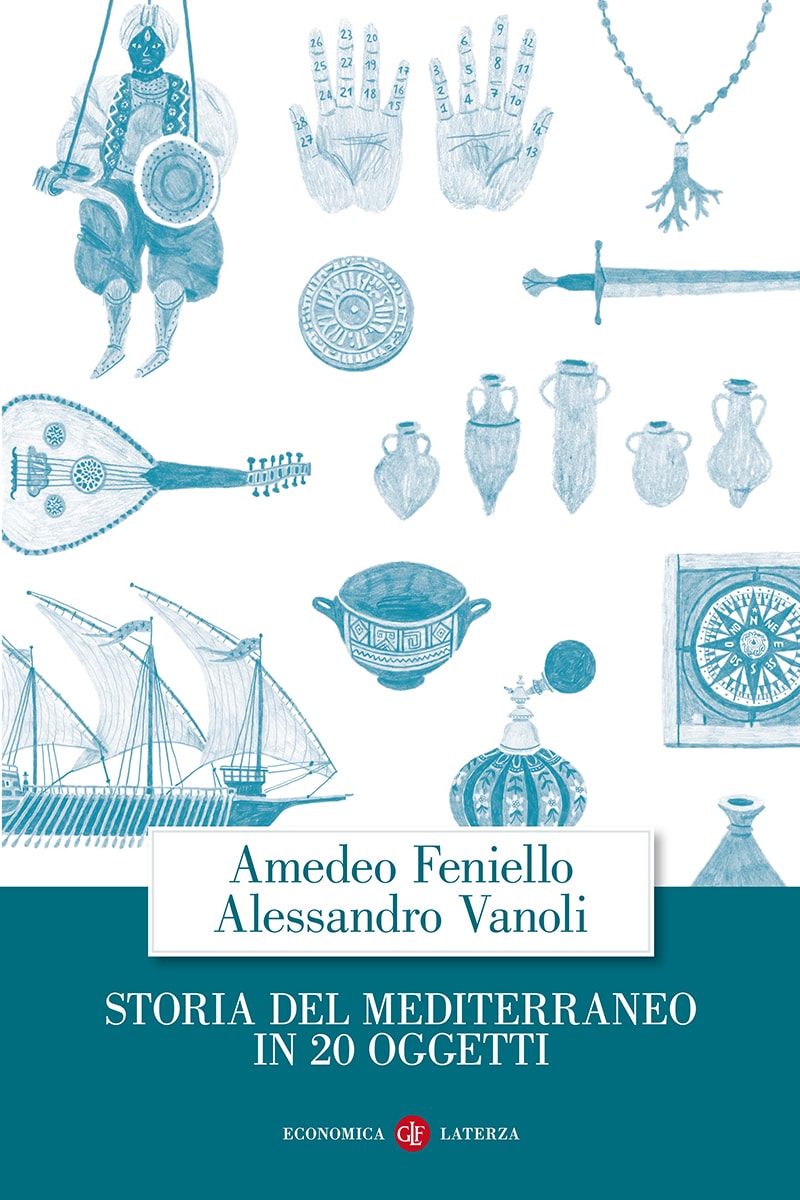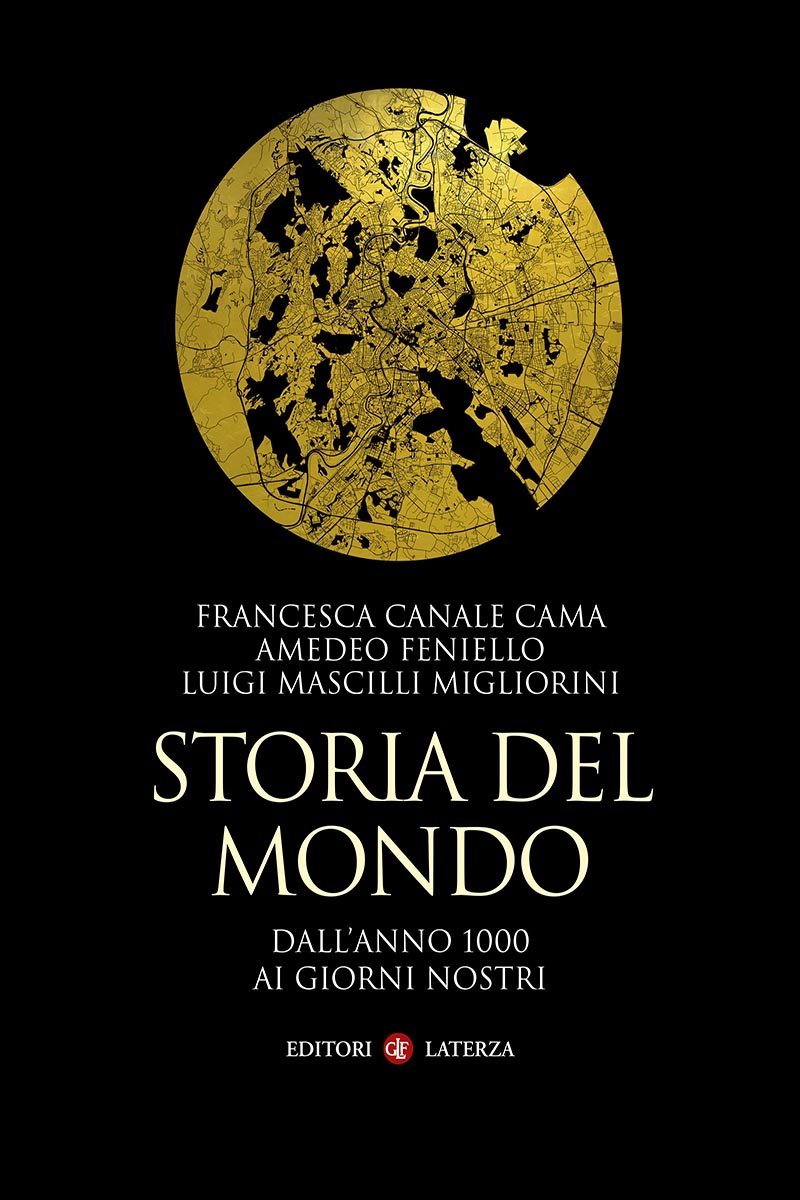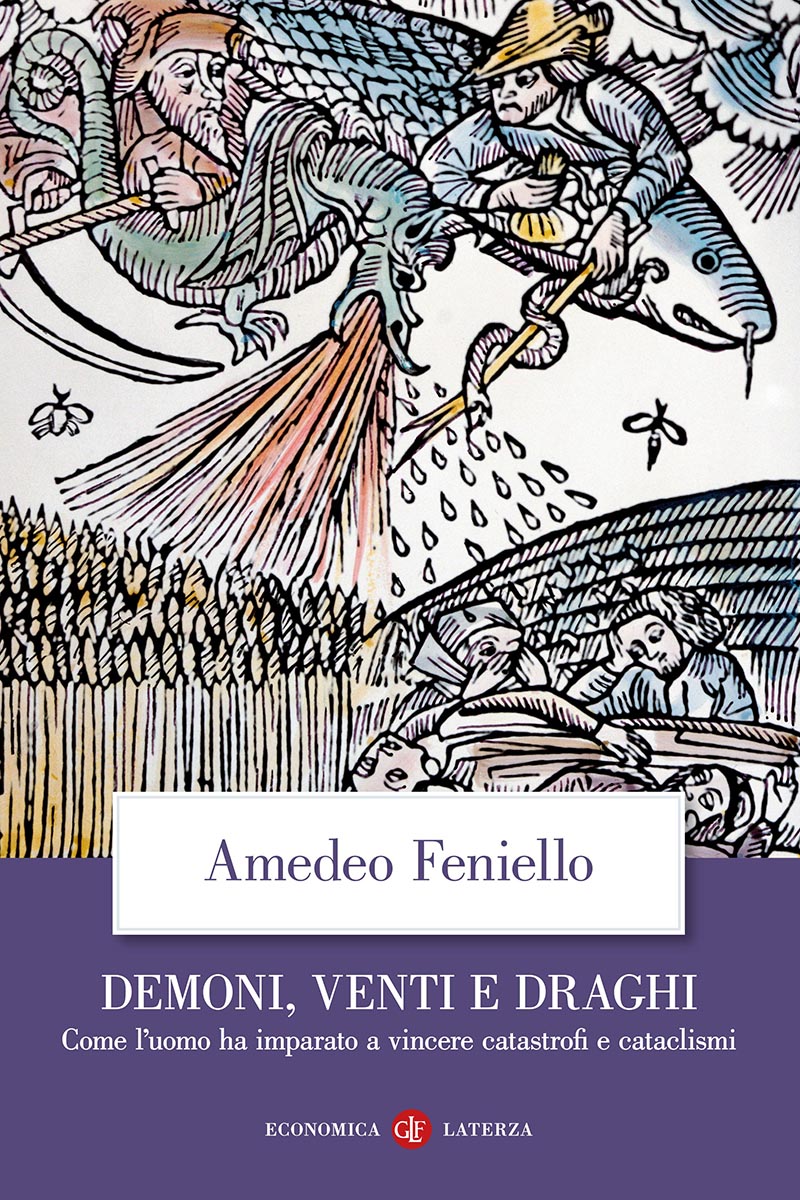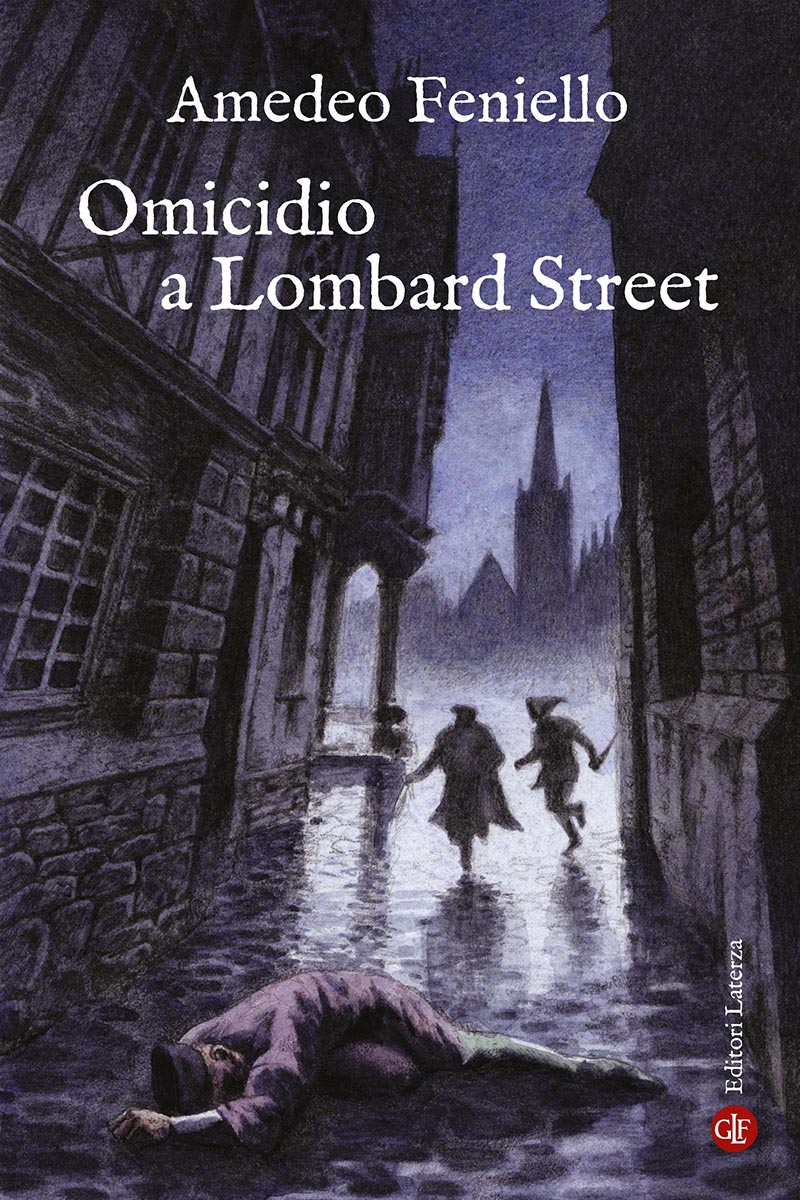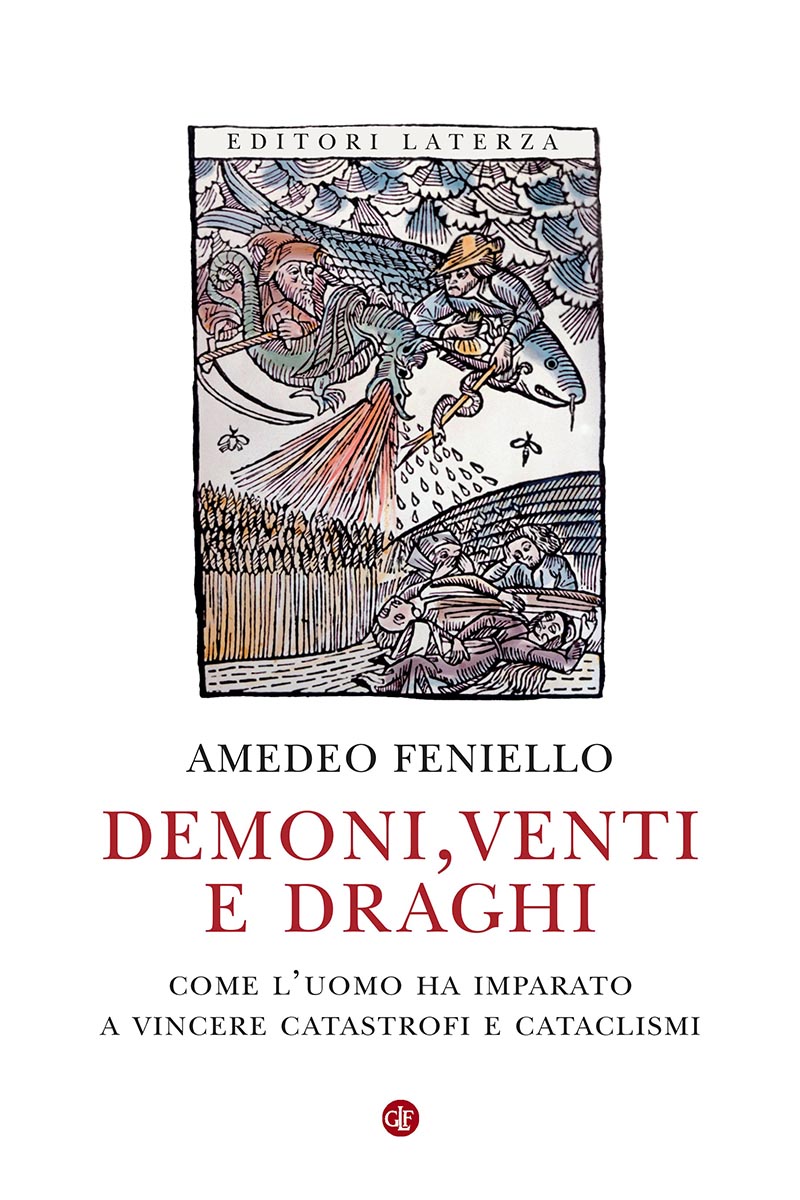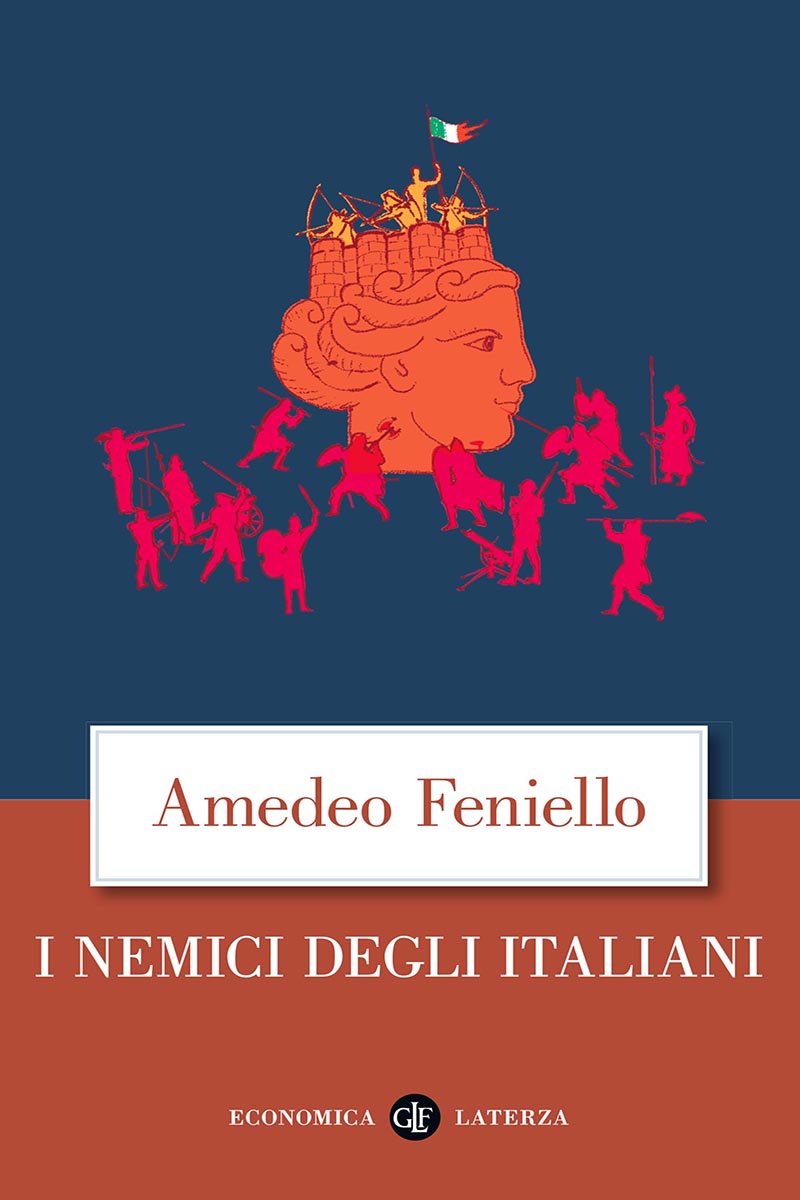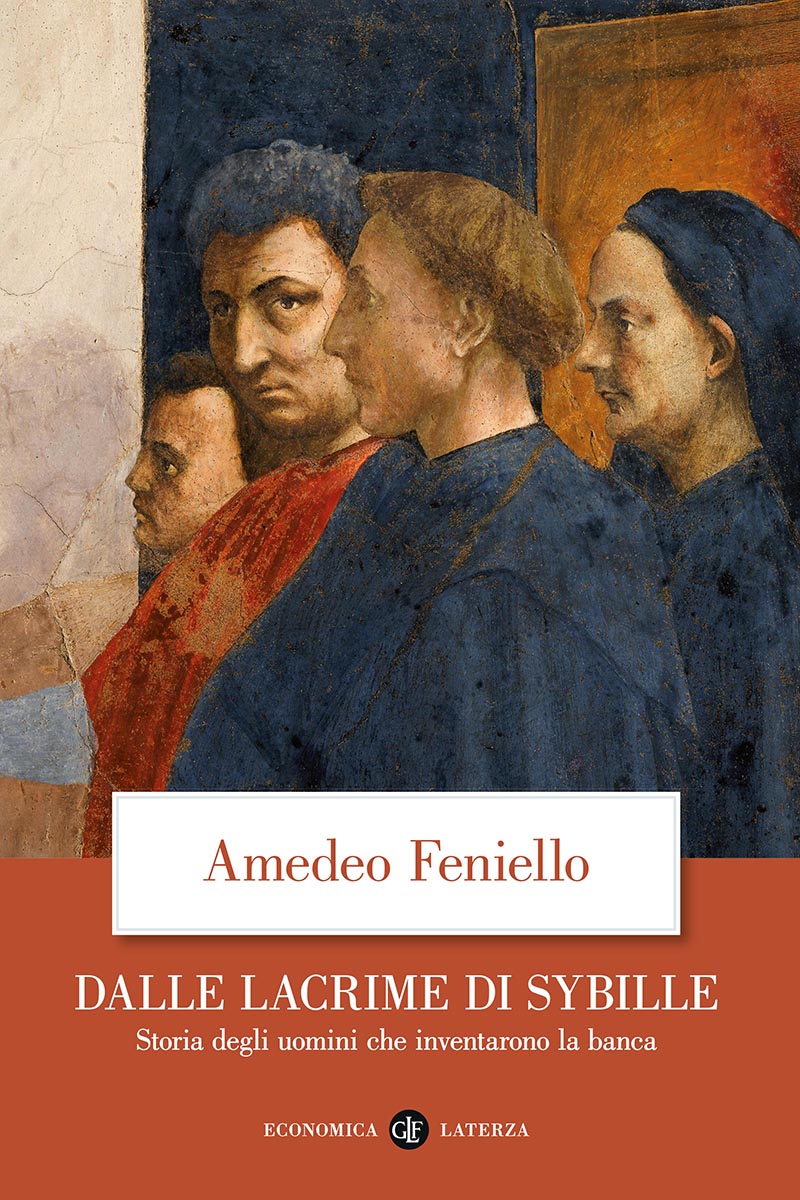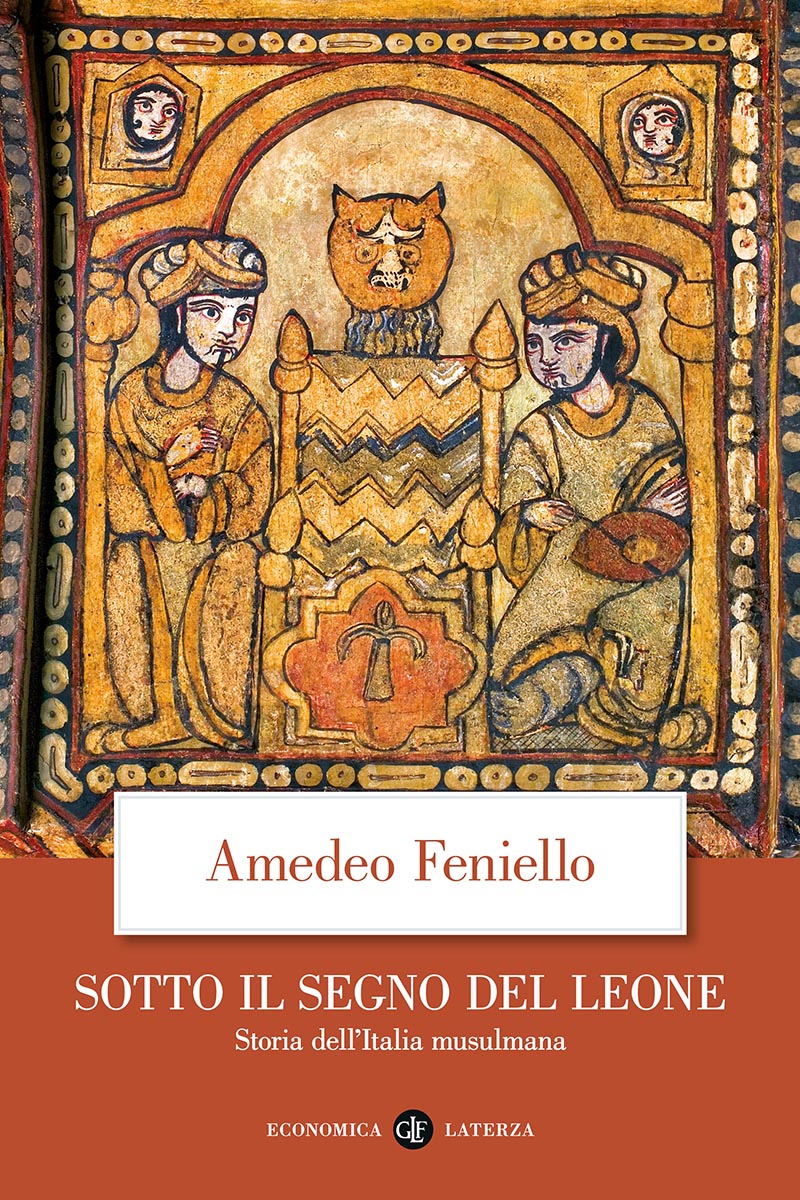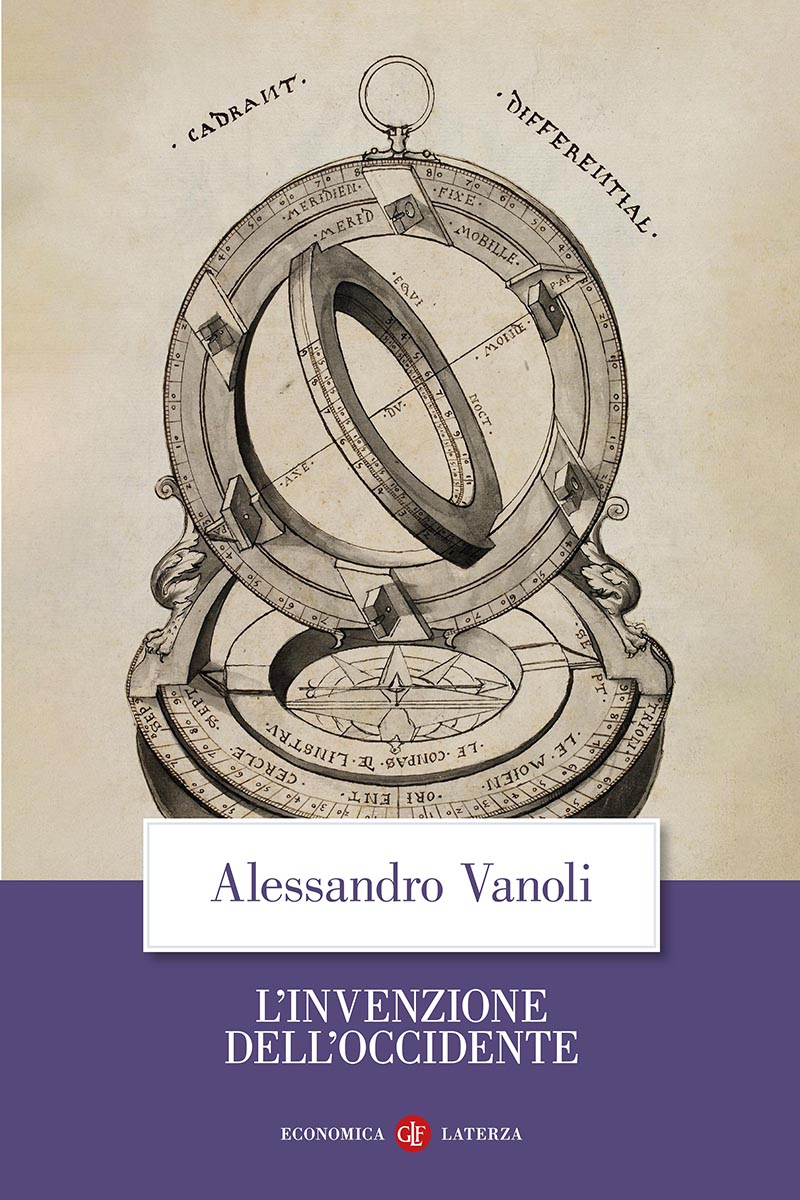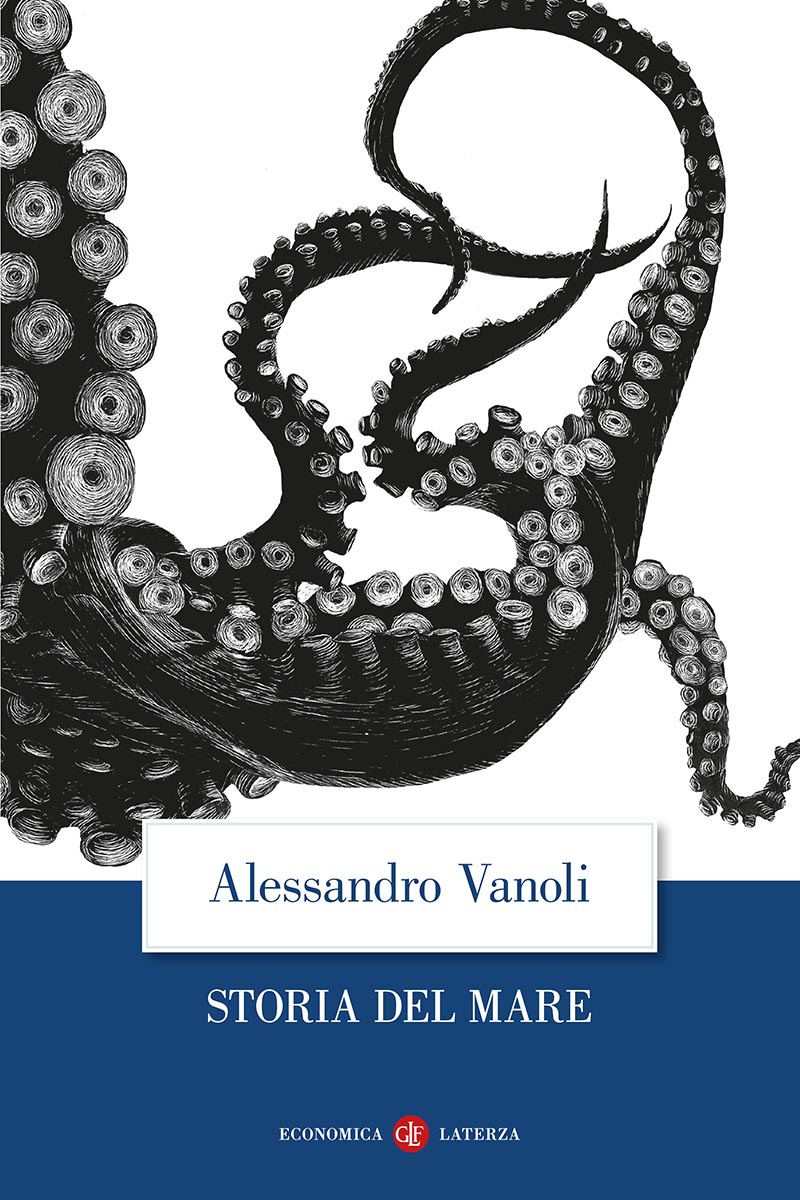Storia del Mediterraneo in 20 oggetti
Fra arnesi un tempo quotidiani e oggi confinati nei musei e altri che sono sempre con noi, scopriamo, grazie a una vivace narrazione, che il Mediterraneo è la sede di un’unica civiltà, che è diventata la civiltà dell’Europa, e poi del mondo.
Alessandro Barbero
La Storia del Mediterraneo in 20 oggetti è prima di tutto l’attestazione di un grande amore per il proprio oggetto di studio, il Mediterraneo, ed è percorsa dal desiderio di raccontarlo come veri e propri cantastorie.
Carlo Vulpio, “Corriere della Sera”
Un libro originale che ripercorre quel che accadde nel piccolo oceano permeato di cultura del Mediterraneo. Un racconto che segue le tracce di alcuni oggetti: a volte ordinari, altre volte curiosi o strani, comunque in grado di raccontare la storia e infinite storie.
Armando Torno, “Il Sole 24 Ore”
Seguiamo venti oggetti e la loro storia. Ci racconteranno l’anima di uno spazio geografico e culturale ricchissimo: il Mediterraneo.
Rassegna stampa
-
Storia del Mediterraneo in 20 oggetti
Oggetti e versi per raccontare il Mediterraneo
-
Storia del Mediterraneo in 20 oggetti
Pane e rete, chitarra e bussola. Il Mediterraneo in venti oggetti
-
Storia del Mediterraneo in 20 oggetti
Vanoli e Feniello, il Mediterraneo in 20 oggetti
-
Storia del Mediterraneo in 20 oggetti
http://www.tg2.rai.it/dl/tg2/rubriche/PublishingBlock-b23b19f4-eeb1-4f4f-a2ff-745741488706.html
-
Storia del Mediterraneo in 20 oggetti
Venti oggetti raccontano il Mediterraneo