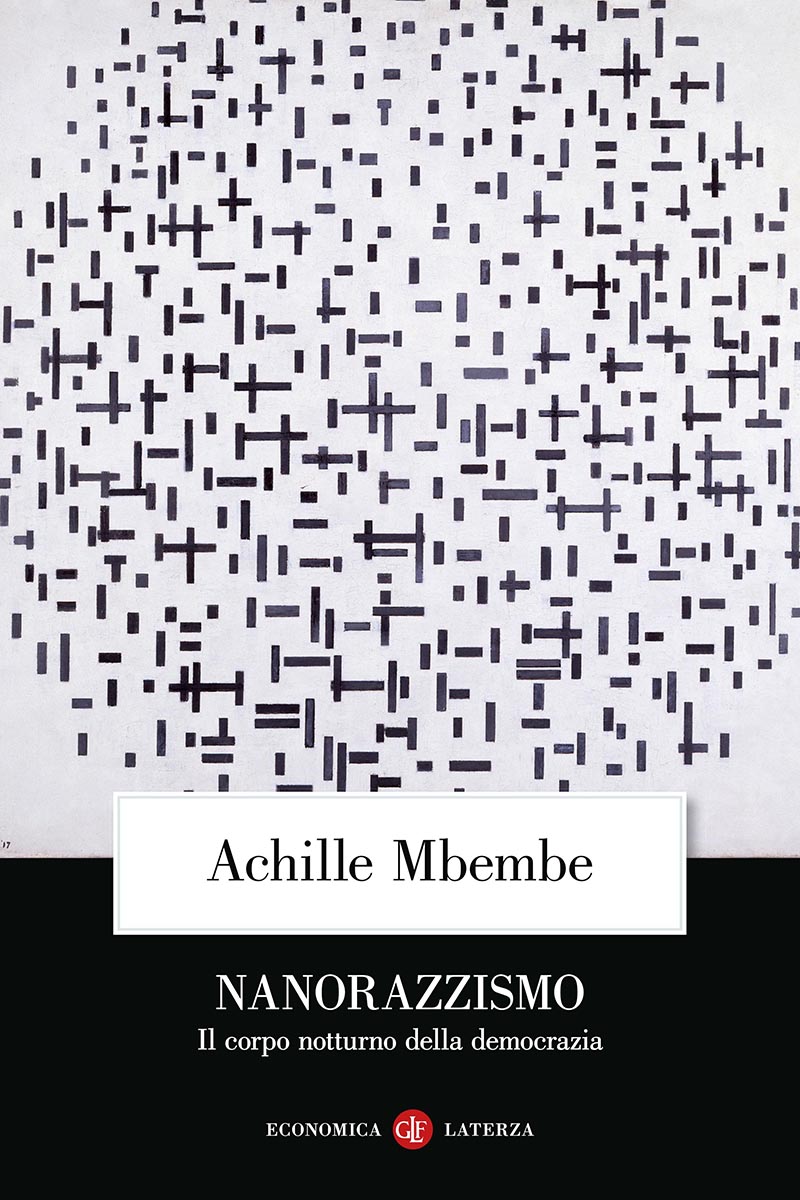Nanorazzismo
Il nanorazzismo è il razzismo fatto cultura e respiro, nella sua capacità d’infiltrarsi nei pori e nelle vene della società, nell’ora dell’ammaliamento di massa. È quella forma narcotica del pregiudizio che si esprime nei gesti in apparenza neutri di ogni giorno, nello spazio di un nulla, di una frase in apparenza inconsapevole, di una battuta, di un’allusione e, bisogna pur dirlo, di una cattiveria voluta, di un intento malevolo, di un’oscura voglia di stigmatizzare e soprattutto di fare violenza, ferire e umiliare, di infangare chi non si considera dei nostri.
Achille Mbembe, uno dei maggiori intellettuali contemporanei, si addentra nelle dinamiche che rendono l’identificazione dell’altro come nemico, la modalità dominante di relazione nella società contemporanea.