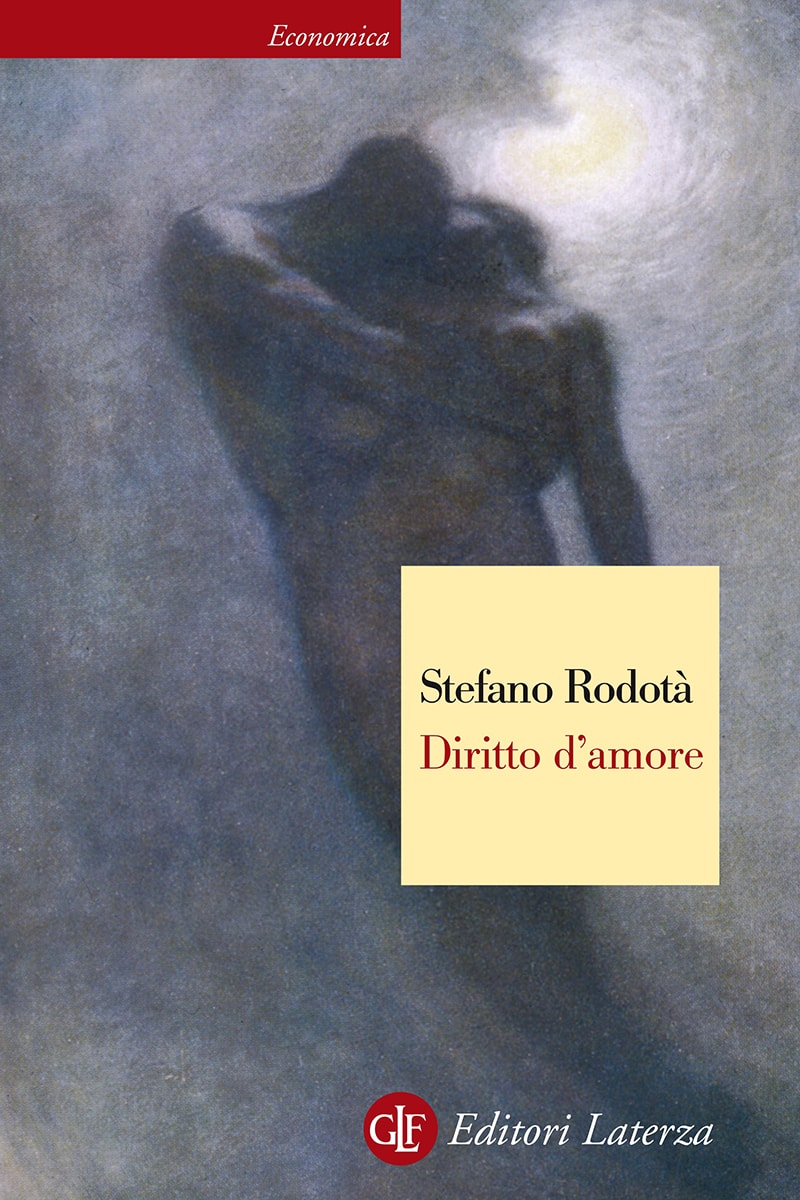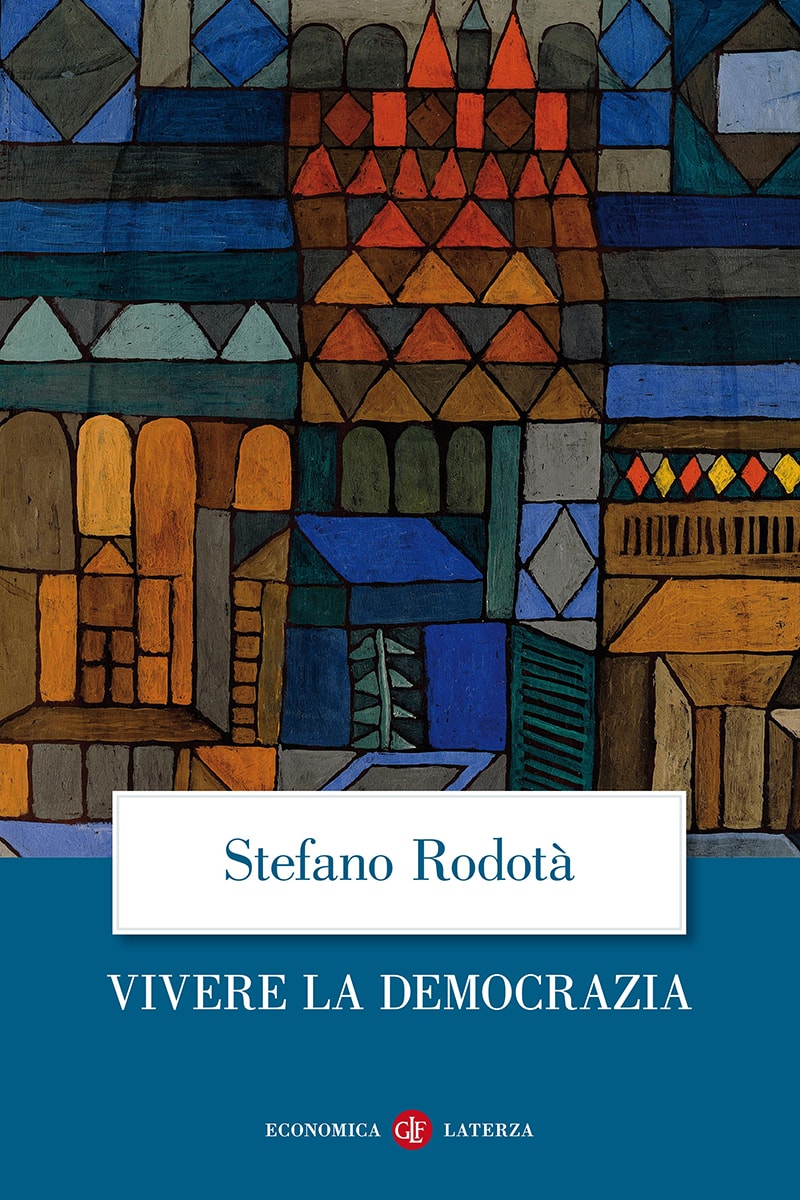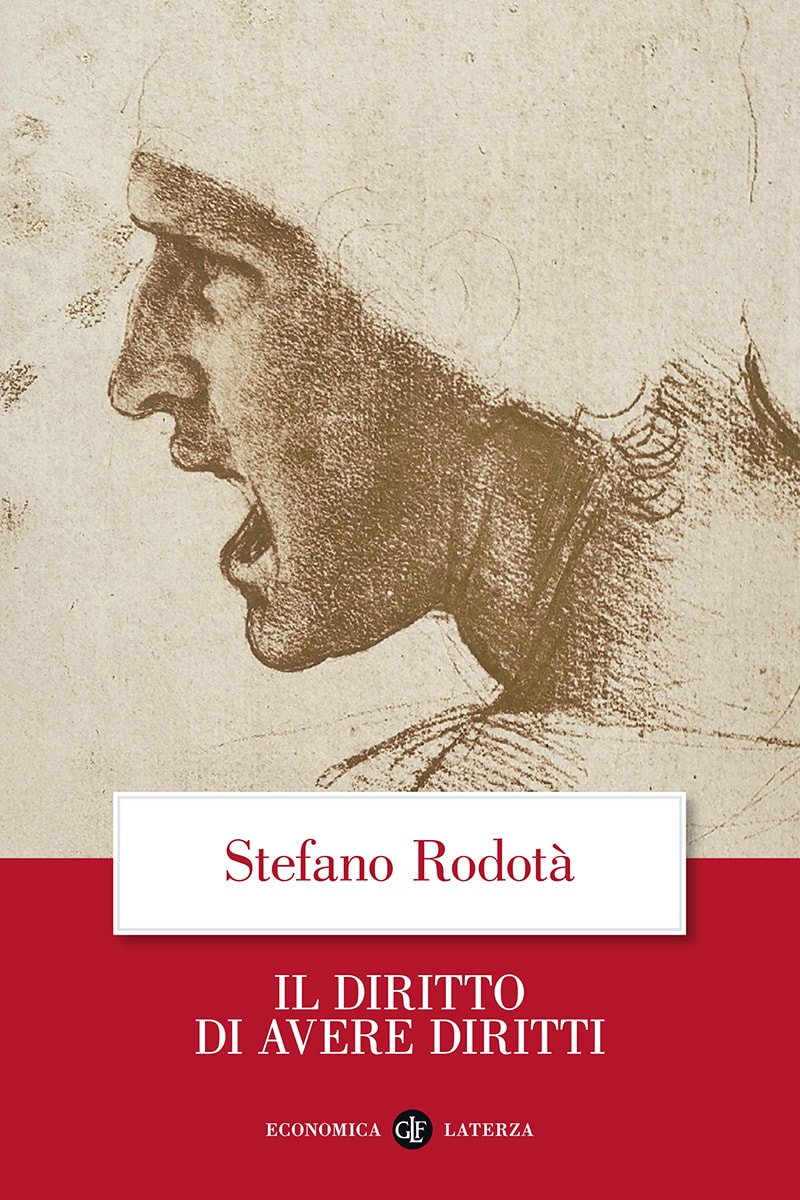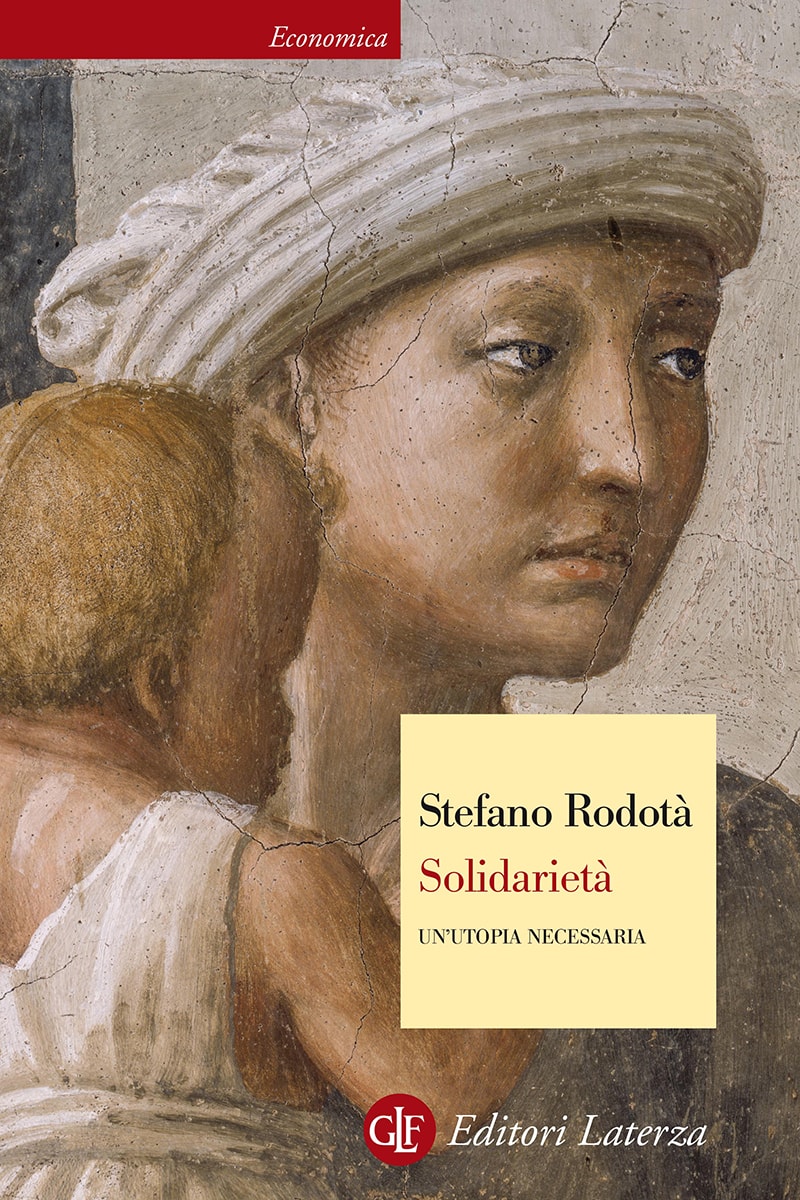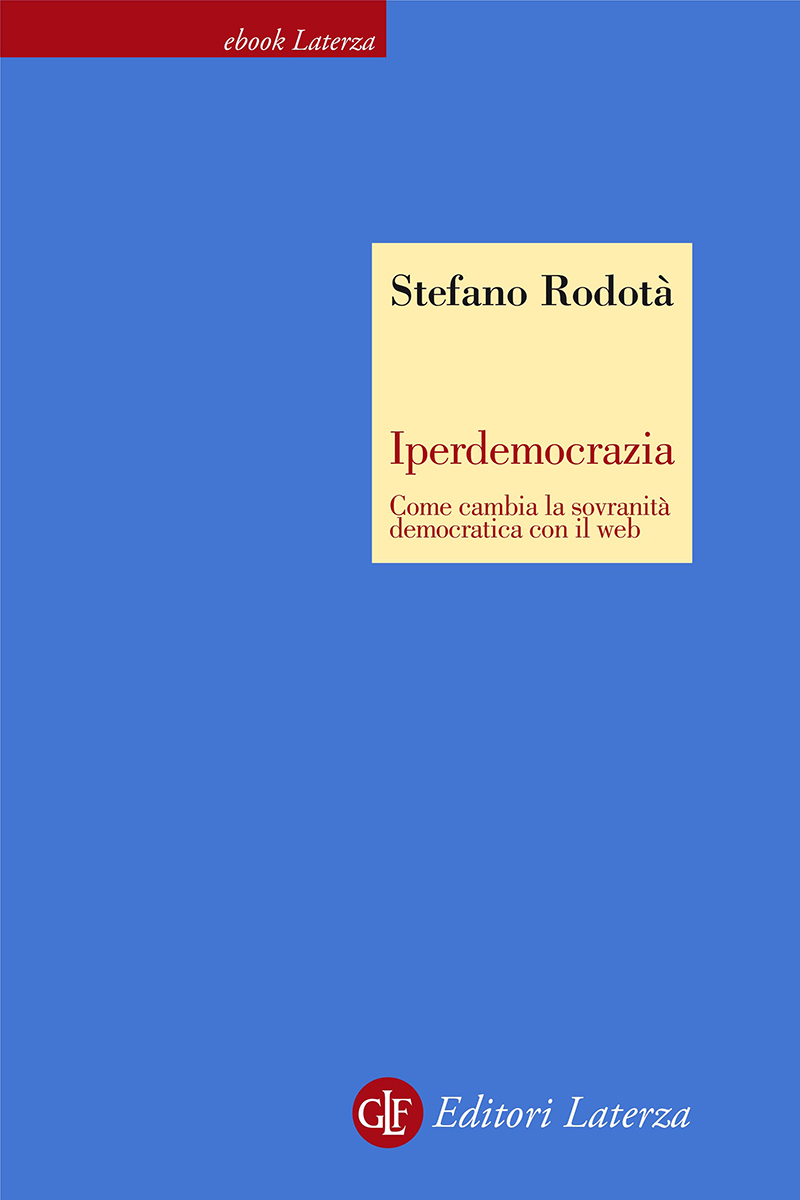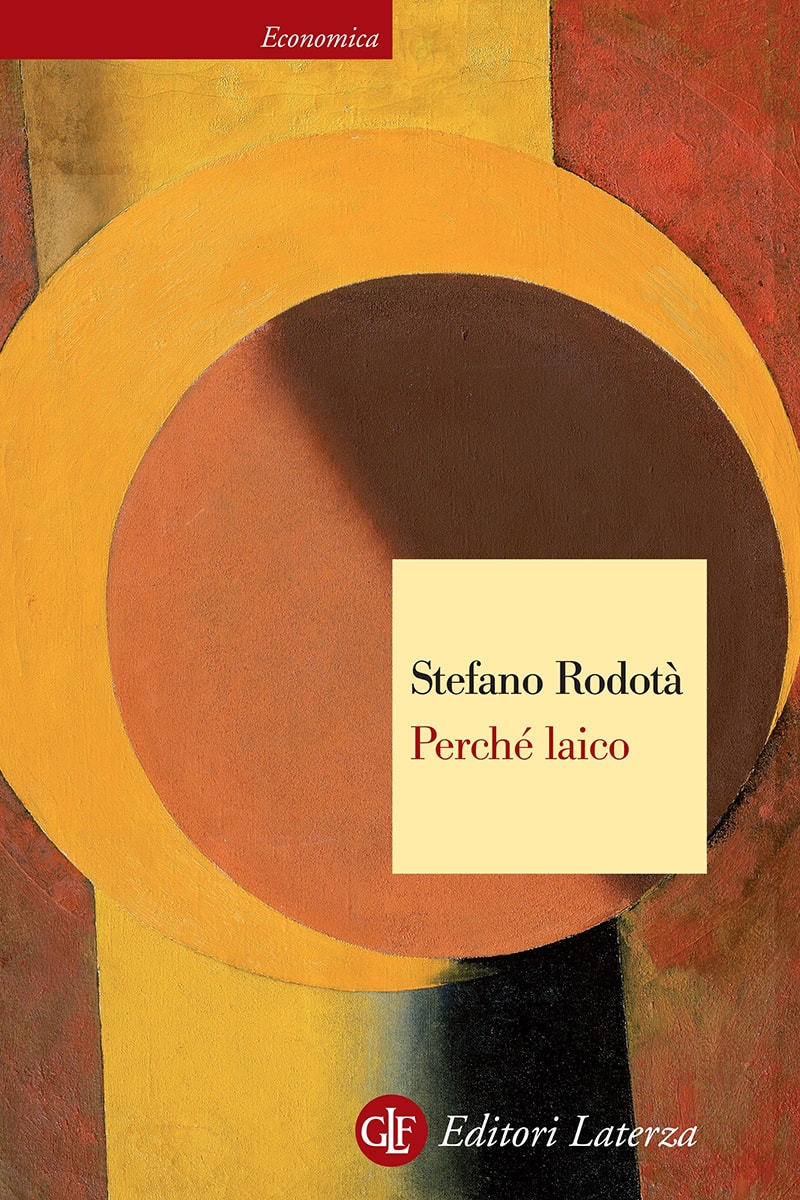Diritto d'amore
Parlare di diritto d’amore non serve a legittimarlo, l’amore non ha bisogno di legittimazione. L’amore vuol farsi diritto per realizzarsi pienamente.
La domanda che Stefano Rodotà si pone in questo libro – esemplare nelle sue affilate argomentazioni, nell’analitica lucidità – è se sia possibile conciliare queste due potenze, il diritto e l’amore. Se, in altre parole, sia possibile, per un verso, ‘liberare l’amore’, riconsegnandolo alla vita nella sua ricchezza e variabilità, e, per l’altro, trasformare il diritto da aggressivo gendarme dei sentimenti in rispettoso fautore del primato della persona. Remo Bodei, “Il Sole 24 Ore”
Al conflitto permanente tra diritto e amore dedica bellissime pagine Stefano Rodotà, giurista da sempre attento al tumultuoso rapporto tra l’irregolarità e l’imprevedibilità della vita e l’astrazione formale della regola giuridica. Inutile aggiungere da che parte stia Rodotà. Ed è superfluo anticipare che in questa storia i protagonisti non sono solo il diritto e i sentimenti ma anche la politica. Simonetta Fiori, “la Repubblica”
Rassegna stampa
-
Diritto d'amore
Come è povero il diritto se non parla d'amore
di Simonetta Fiori