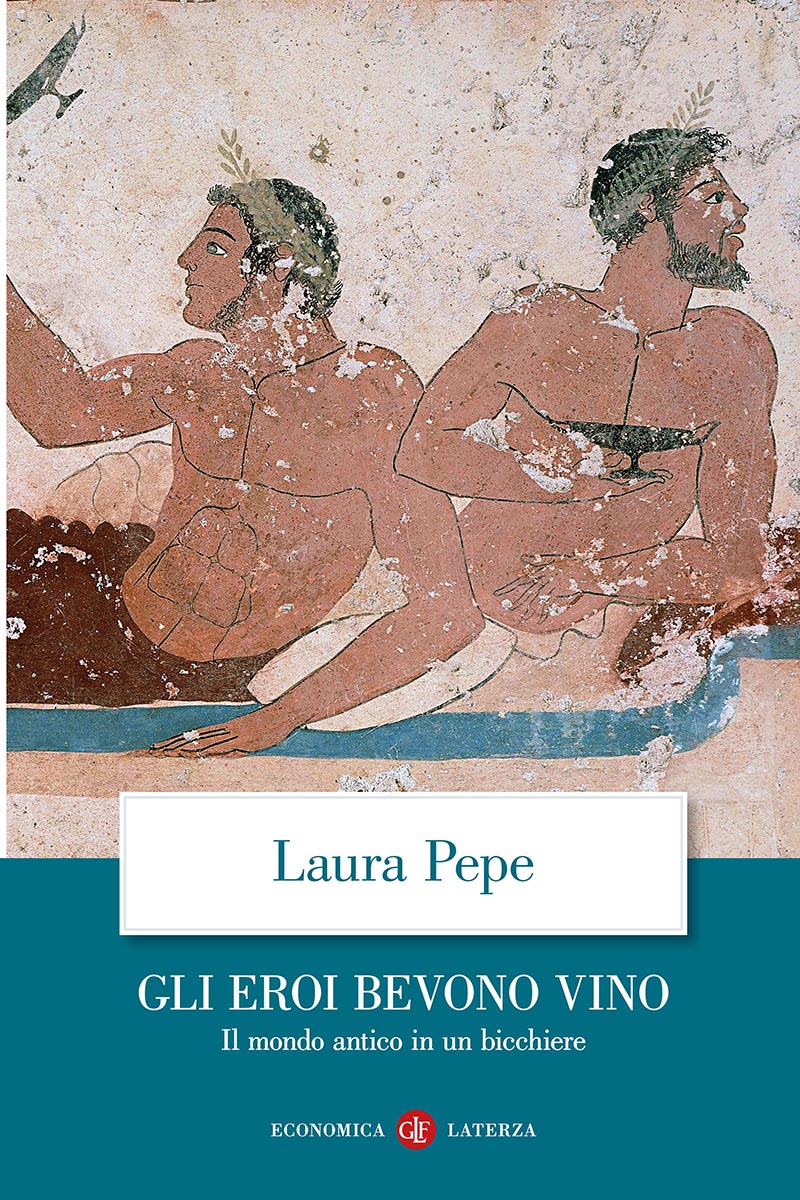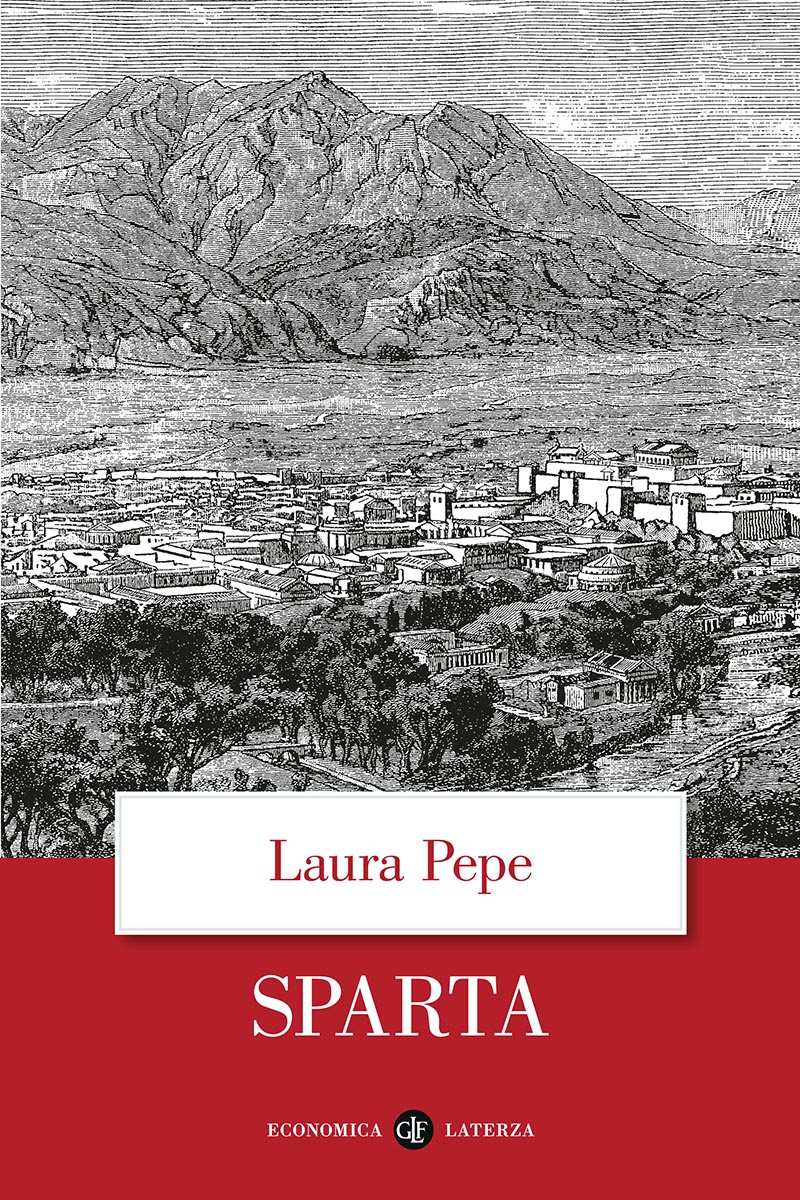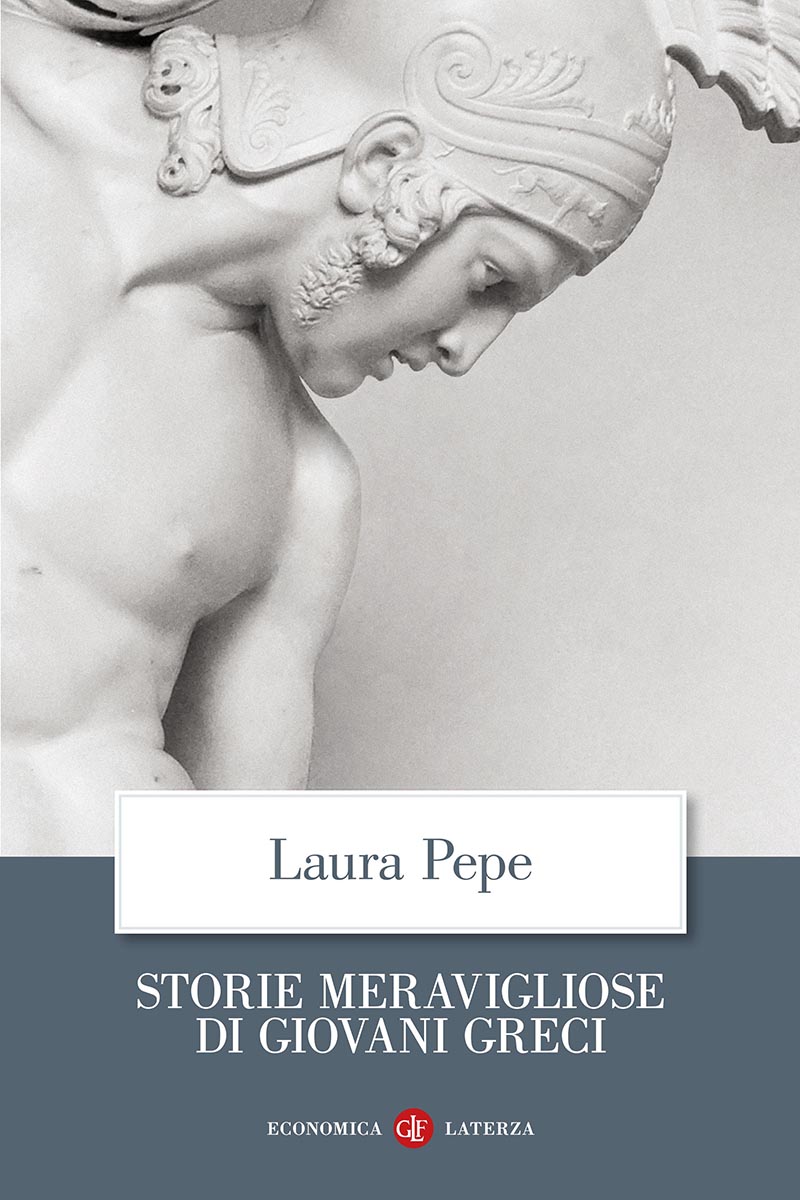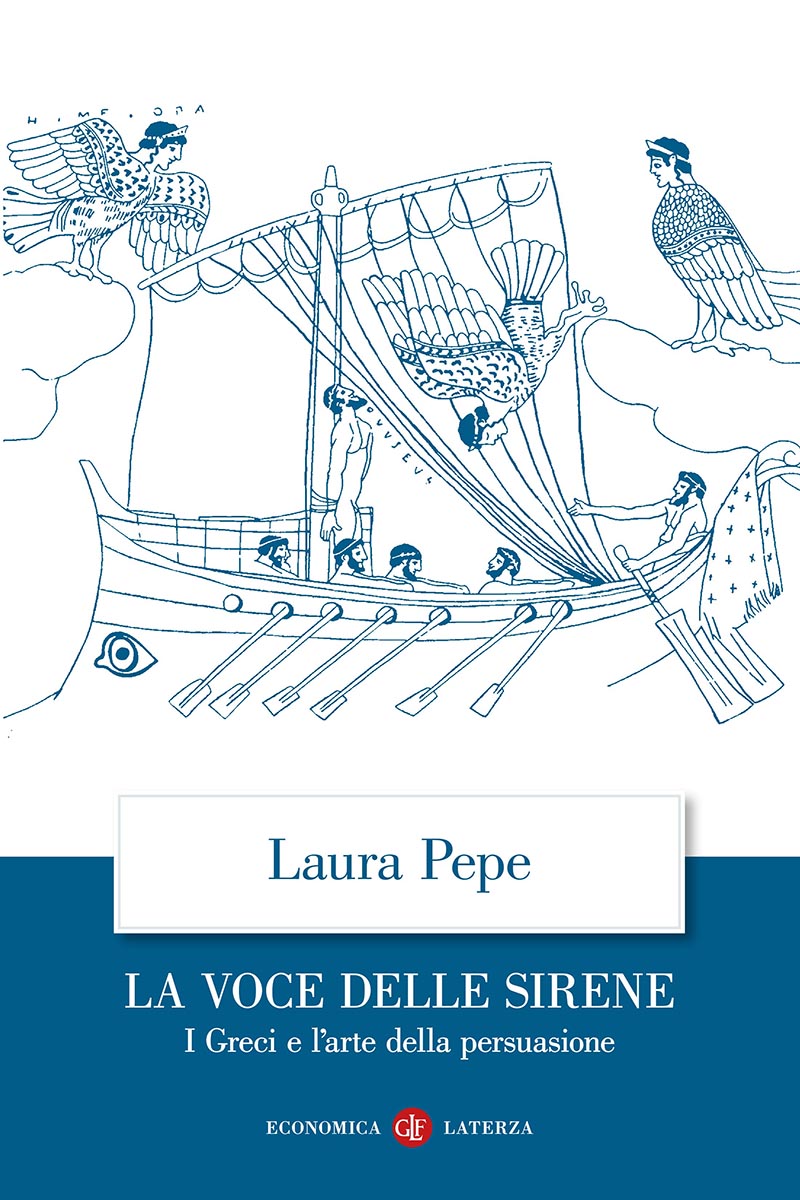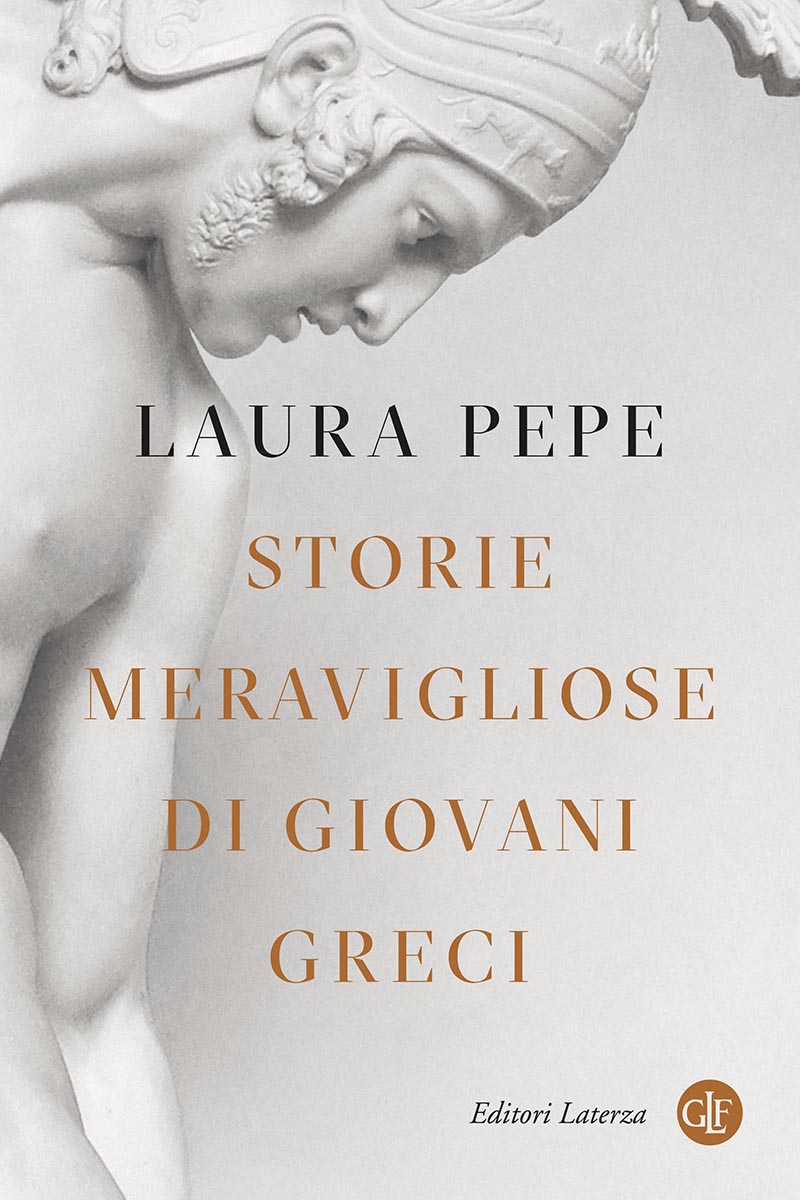Gli eroi bevono vino
La cultura antica attraverso il vino. Un libro che diverte e che insegna molte cose!
Eva Cantarella
Bevanda ristoratrice da offrire agli ospiti, gradita offerta agli dei e, nel contempo, dono di un dio. In Gli eroi bevono vino Laura Pepe descrive il ruolo e la funzione sociale che il nettare dionisiaco ebbe nel mondo greco e romano. Con leggerezza e con misura, come gli antichi prescrivono il bere.
Alice Patrioli, “la Lettura – Corriere della Sera”
Alla moderna società dell’informazione e della connessione in rete, in un solitario mondo virtuale, sarebbe opportuno ricordare il valore del simposio, del convito, quale momento di civiltà. E delle varie forme di simposio nel mondo antico – presso i romani convito – tratta Laura Pepe.
Tullio Gregory, “Il Sole 24 Ore”
Attorno al vino ruota una gran parte dell’identità di Greci e Romani: miti, regole di galateo, codici di comportamento, visioni etiche e filosofiche, religione e molto altro ancora. Con la lievità di un brindisi, una visione originale e vivida della straordinaria cultura di cui siamo figli.