Paolo Mieli | Corriere della Sera | 17 gennaio 2024
La più grande invenzione dell’antica Roma fu l’imperium, quella forma di potere pressoché assoluto che nacque sostanzialmente con Romolo, si perfezionò nell’età repubblicana e si completò, esplicitandosi, ai tempi di Augusto. Ad essa è dedicato un libro prezioso di Giovanni Brizzi, Imperium. Il potere a Roma. Alle radici dell’imperium, mette in risalto Brizzi, si pone una doppia matrice, ad un tempo politica e religiosa. Quella politica è stata sviscerata in ogni suo aspetto e anche qui viene ripercorso il progressivo affermarsi dei «poteri personali» da Publio Cornelio Scipione a Caio Giulio Cesare. Ma su quella religiosa — il cosiddetto «assenso dei Numi» — c’è ancora molto da indagare.
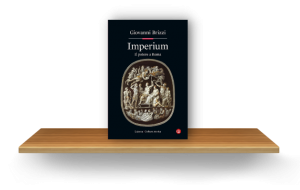 Fino a quando ci sono sullo sfondo gli Dèi il tragitto ha una sua coerenza e una sua linearità. Ma tutto rischia di andare all’aria allorché il potere romano è costretto a fare i conti con il cristianesimo. Qui la personalità della «svolta» è Paolo di Tarso, l’ebreo vissuto nel I secolo dopo Cristo che si convertì alla nuova fede e dedicò la seconda parte della propria vita alla diffusione del messaggio cristiano. In forme che resero tale messaggio compatibile con l’imperium.
Fino a quando ci sono sullo sfondo gli Dèi il tragitto ha una sua coerenza e una sua linearità. Ma tutto rischia di andare all’aria allorché il potere romano è costretto a fare i conti con il cristianesimo. Qui la personalità della «svolta» è Paolo di Tarso, l’ebreo vissuto nel I secolo dopo Cristo che si convertì alla nuova fede e dedicò la seconda parte della propria vita alla diffusione del messaggio cristiano. In forme che resero tale messaggio compatibile con l’imperium.
Che Paolo sia una figura fondamentale nella storia del cristianesimo (e non solo) è un dato storico ormai acquisito. Per qualcuno fu addirittura più importante di Gesù Cristo. Qualche anno fa Andrew Norman Wilson diede alle stampe Paolo. L’uomo che inventò il cristianesimo (Rizzoli) in cui sosteneva la tesi secondo cui il «Gesù dei Vangeli, se non una creazione di Paolo, è un frutto di Paolo». A Wilson quella del santo appariva, nella tradizione neotestamentaria, una figura «più dominante di quella dello stesso Gesù». Si spinse a sostenere che «se Paolo non fosse esistito, è assai improbabile che noi avremmo avuto i Vangeli nella forma presente». E, benché Wilson riconoscesse che c’erano stati molti personaggi di primo piano «coinvolti nell’evoluzione del cristianesimo», gli aspetti che avevano distinto il cristianesimo dall’ebraismo e in effetti lo avevano reso incompatibile con esso, erano «un contributo esclusivo di Paolo». Talché Wilson si spinse a sostenere che fu Paolo (e non Gesù) il «fondatore del cristianesimo».
Il libro piacque pochissimo a monsignor Gianfranco Ravasi che (su «Avvenire») lo stroncò ricordando che l’autore era null’altro che un giornalista dell’«Evening Standard». D’altra parte, perfino Antonio Gramsci aveva parlato dell’Apostolo di Tarso come del «Lenin del cristianesimo» (laddove Marx sarebbe stato Gesù Cristo). «Asserti lapidari» e «approssimazione» furono i capi d’accusa di Ravasi. Il quale — sempre sul quotidiano della Conferenza episcopale italiana — suggerì, come «sano antidoto» all’opera di Wilson, il libro di Rinaldo Fabris Paolo. L’apostolo delle genti (Edizioni Paoline) che pur faceva propria la celebre definizione di William Wrede (1904) di Paolo come «secondo fondatore del cristianesimo». A dispetto della stroncatura di Ravasi, suggestioni in un certo senso wilsoniane si sono potute cogliere in libri successivi come Paolo. L’ebreo che fondò il cristianesimo di Riccardo Calimani (Mondadori) e Paolo. L’uomo che inventò il cristianesimo di Corrado Augias (Rai Libri). Lo stesso Brizzi manifesta un particolare rispetto per la figura del santo e lo presenta come «il genio di Tarso».
Ma — prima di passare a Paolo — torniamo a Gesù e ai suoi rapporti con l’imperium. Nell’affrontare il tema, Brizzi fa sua un’affermazione che fu di Pierre Vidal-Naquet nel libro Il buon uso del tradimento. Flavio Giuseppe e la guerra giudaica (Editori Riuniti): «Il non specialista che si avventura in questo tipo di ricerca piomba nell’angoscia». E la evoca come «in qualche modo assolutoria» nei propri confronti. Anche, forse, per mettersi al riparo da critiche sferzanti come quelle di Ravasi. Quella fondata da Gesù gli appare in ogni caso come una «setta giudaica che si distacca certamente — almeno secondo i Vangeli — dagli aspetti più intransigenti» della tradizione ebraica «per l’atteggiamento di apertura verso i dominatori romani». E «persino verso i rappresentanti più odiati del potere, vale a dire i pubblicani, gli esattori delle imposte». La posizione del Cristo nei confronti dell’imperio è stata dedotta soprattutto dalla sua celebre risposta ai farisei. Interrogato se fosse legittimo o meno, ovviamente dal punto di vista della legge mosaica, pagare il tributo a Roma, il Maestro di Nazareth si fece portare una moneta di Tiberio e chiese ai suoi interlocutori di chi fosse l’effigie impressa sulla moneta stessa; avutane la risposta che si trattava di Cesare, Gesù replicò sostenendo che si doveva «rendere» a Cesare le cose di Cesare e a Dio le cose di Dio. In quel «rendere» c’è, secondo Brizzi, «una sfumatura difficilmente eludibile che richiama al tributo morale se non economico da rendersi al potere in cambio dei servigi alla collettività». Tanto che qualcuno, come Ethelbert Stauffer, ha intravisto nell’uso di quel verbo un implicito «assenso» di Gesù «all’impero».
Ma in Paolo, più specificamente nella Lettera ai Romani, c’è di più. La legittimazione nei confronti del dominio di Roma — che pure, già nella frase di Gesù per alcuni è, come si è visto, qualcosa di più di un semplice accenno — nell’enunciato dell’apostolo non è solo una chiosa al detto del Maestro. Contiene un assenso e, ciò che più conta, un «avallo di natura trascendente» al potere imperiale. Il verbo usato è sempre lo stesso: «rendete a tutti quanto è dovuto». Paolo però aggiunge altre parole non irrilevanti: «Ognuno sia soggetto alle autorità superiori, poiché non c’è autorità che non venga da Dio». Perciò «chi si oppone all’autorità resiste all’ordine stabilito da Dio». Autorità che «non per nulla porta la spada», ed essendo «ministra di Dio», ha il dovere di «punire chi opera il male». Paolo, sostiene Brizzi, «non solo divinizza il potere fino ad ogni sua ultima propaggine ed emanazione funzionale». Giunge addirittura a sostenere che «persino gli esecutori di un atto che per i Giudei costituisce un autentico abominio (l’esazione delle imposte)», sono in quel momento «servitori di Dio».
Qualcuno — come il rabbino filosofo austriaco Jacob Taubes in La teologia politica di san Paolo (Adelphi), le ultime lezioni da lui tenute nel febbraio 1987 a Heidelberg, e soprattutto Wolf-Daniel Hartwich, Alejda e Jan Assmann nella prefazione al libro stesso — ha considerato la dottrina di Paolo come una «intensificazione del giudaismo» o come un «potenziamento liberatorio dell’ebraismo stesso». Ma allora perché Paolo aveva definito gli ebrei «nemici»? Qui Taubes, spiega Brizzi, era stato costretto a far ricorso a qualche «forzatura» per dar conto di quella definizione. Ma, in dialogo con Taubes, Carl Schmitt — in Teoria del partigiano (Adelphi) — aveva tagliato il nodo laddove sosteneva che con quel termine, «nemici», l’apostolo definiva la sua Chiesa per opposizione piena nei confronti degli ebrei. Dopodiché, sempre secondo Brizzi, sono molti i segni che Paolo «seguisse da tempo una linea assai meno radicale rispetto a Giacomo, a Giovanni e persino a Pietro». Finché, forse nella primavera del 61, Paolo abbandonò la Giudea per trasferirsi a Roma. Da dove non sarebbe mai più tornato a Gerusalemme. Comunque, è certo che da allora in poi egli fu «decisamente ripudiato» dagli ebrei. Ed è questo, conclude Brizzi, «ciò che qui importa davvero».
In una prefazione alle Lettere di san Paolo (Bur) il teologo e biblista Giuseppe Barbaglio — già autore di Paolo di Tarso e le origini cristiane (Cittadella editrice) — ha constatato come Paolo, pur trasformato dall’incontro con il Cristo, non si era in realtà poi riferito alle tradizioni evangeliche se non «in misura trascurabile e su punti di secondaria importanza». Si è invece reso in grado di elaborare «una teologia capace di giustificare l’apertura universalistica della Chiesa». Quello di Israele era, secondo Barbaglio, anch’esso un «universalismo», ma «centripeto», cioè atto a trascinare a sé, al mondo giudaico, donne e uomini provenienti da mondi diversi. Quello di Paolo, invece, era per così dire «centrifugo», cioè «incondizionato». Brillante intuizione, afferma Brizzi, senonché a Barbaglio sembra sfuggire il fatto che quell’universalismo «centrifugo», «in forma persino più aperta, esisteva già con altre coordinate ben prima che a diffonderlo si dedicasse l’apostolo». Il precedente «era rappresentato dall’universalismo romano, nel quale rientrava in realtà, perfettamente partecipe e conscio proprio Paolo». Ed «è la coincidenza tra i due modelli a costituirne la straordinaria novità».
Si avverte qui l’eco della scuola di Santo Mazzarino («un’intelligenza storica superiore», secondo Brizzi) e ogni riferimento va alla sua opera L’Impero romano (Laterza). Quel Mazzarino che ben comprese di che pasta fosse fatto l’universalismo romano in grado di assorbire, in nome del diritto, i popoli via via conquistati. Mazzarino intuì tra i primi l’intero senso di questo discorso e approdò alla conclusione che «nessun cittadino romano ha avuto nella storia dell’impero quell’importanza decisiva che noi dobbiamo assegnare a Paolo».
Rispetto al modello proposto da Mosè, scrive Brizzi, la posizione prediletta da Paolo «era, credo, quella che contemplava la possibilità di un ordine politico sancito da Dio attraverso il suo avallo e inverato come forma visibile attraverso un’autorità che potesse per questo pretendere di essere rispettata». Tale autorità, «dovette pensare Paolo», poteva «identificarsi — fino a che la Chiesa non l’avesse sostituita? — con la forma, pur perfettibile, dell’imperio». Brizzi ritiene «che un gigante del pensiero qual era l’apostolo possa avere antiveduto in parte le smisurate possibilità future offerte dalla soluzione proposta».
Avrebbe dovuto essere però un processo graduale, «che richiedeva un paziente lavorio di secoli» e «un adeguamento delle strutture esistenti», scartando «le scelte estreme del giudaismo». Scelte estreme (qui Brizzi si dice sicuro che Paolo ne fosse via via sempre più «chiaramente presago») che «avrebbero finito per condurre la religione dei padri, con le istanze proprie delle anime che la componevano, quella palestinese e quella della diaspora, ad un mortale confronto con l’universalismo opposto, quello di Roma». La «Legge divina contro quella, umana ma potenzialmente inflessibile dell’Urbe».
Ad ogni modo, quale che ne sia stato il germe originario, l’autore ritiene che «l’idea della Nuova Alleanza — proposta in Paolo ancora prima che nei Vangeli — presenta indiscutibili e suggestivi parallelismi con il gigantesco sistema ideologico su cui si regge la nozione prescelta dal primo degli imperatori». Nell’implicito «connotarsi come civis», quando, nella Lettera ai Romani, «dichiara la sua piena adesione all’impero», Paolo è debitore a quel modello augusteo di una suggestione «forse neppure del tutto inconscia». Paolo aveva intuito, ben prima di dar vita alla sua personale impalcatura della Chiesa nascente, come, per sopravvivere, la nuova fede dipendesse «dall’adesione o almeno dalla capacità di inserirsi in un kosmos ecumenico dominato da Roma». Senza «dapprima turbarlo troppo». Adesione in mancanza della quale «rischiava di perire con il resto di una realtà ebraica che, viceversa, con l’Urbe e le sue leggi andava ponendosi su un’irreparabile rotta di collisione». Lungo questo percorso, come sostiene Giuseppe Zecchini in Storia della storiografia romana (Laterza), Paolo offrirà un formidabile sostegno ideologico alla monarchia, guidandola verso la forma assoluta vagheggiata dalla maggior parte dei Cesari.
E la Chiesa? Giovanni Brizzi precisa che esita «a credere che il genio di Tarso possa avere antiveduto l’evoluzione ultima della sua creatura, la Chiesa». Anche se «le infinite, estreme derive della sua visione dovettero risultare inimmaginabili persino per lui», il suo pensiero «approdò comunque di fatto alla genesi di un edificio millenario, proponendo per la sovranità dimensioni nuove almeno in Occidente». E «destinate a rimanere insuperate a lungo». Molto a lungo.
