Quando i profeti incoraggiano e sostengono movimenti di emancipazione nel loro paese aiutano l’emancipazione dell’umanità. Altri profeti seguiranno il loro esempio presso altri popoli, annunceranno visioni di emancipazione affini per i contenuti di libertà, diverse per riferimenti storici e culturali.
Ogni popolo deve conquistare l’emancipazione con i suoi sforzi.
Ogni popolo ha bisogno dei suoi profeti.
In questo brano, tratto dal suo ultimo libro Tempi profetici. Visioni di emancipazione politica nella storia d’Italia, Maurizio Viroli racconta i confini porosi tra profezia e utopia, ove la prima è un’esortazione a riformare l’ordine sociale e politico, la seconda un invito a mettersi in viaggio verso un’incantevole nuova patria: può essere riformato ciò che non esiste?
_________________________________________________
Profezia e utopia
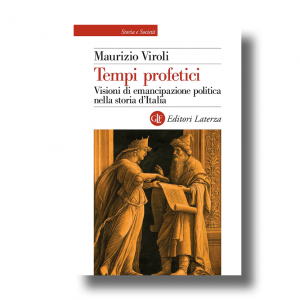 Nell’Italia del secolo XVII circolavano non pochi testi utopistici. Alcuni di essi traevano ispirazione dal De optimo statu reipublicae deque nova insula utopia di Thomas More, l’opera che inaugura la tradizione dell’utopia moderna. Altri la criticavano apertamente. In apparenza simili, l’utopia e la profezia sono invece modelli di pensiero politico e morale molto diversi. I profeti esortano i loro contemporanei, con parole chiare e semplici, a compiere scelte morali e ad impegnarsi per riformare l’ordine sociale politico. Gli scrittori di testi utopici non esortano esplicitamente a compiere scelte morali, non intendono mobilitare le coscienze. Le repubbliche perfette che essi descrivono non devono essere fondate o riformate. Bisogna soltanto mettersi in viaggio e andare a viverci. Il problema è che non esistono. Quando criticano l’ordine sociale e politico lo fanno nella forma velata e indiretta del dialogo per offrire consolazione o semplice distrazione. I confini tra il linguaggio profetico e il linguaggio utopico sono porosi. Le sovrapposizioni e i passaggi dall’uno all’altro sono tutt’altro che rari. L’esempio più eloquente, in Italia, è quello di Tommaso Campanella (1568-1639), autore della Città del Sole, completata nel 1602 e pubblicata nel 1623. Scritta secondo le regole del genere utopistico, l’opera contiene un esplicito messaggio profetico. La forma è quella classica del dialogo. I protagonisti sono un marinaio di Genova che ha viaggiato con Cristoforo Colombo e un cavaliere di Malta che si limita a chiedere spiegazioni e chiarimenti. La benedetta Città del Sole collocata nel mare della Sonda, vicino a Sumatra, imita la struttura urbana della polis greca. L’ordine politico, gerarchico e autoritario, vuole sradicare l’egoismo dal cuore degli esseri umani e rimuovere tutte le tentazioni che possono indurre al peccato. A tal fine i fondatori della Città del Sole hanno abolito la proprietà privata e la famiglia. Nonostante i contenuti teocratici e autoritari, La Città del Sole esprime, come gli studiosi hanno rilevato, aspirazioni di giustizia sociale simili a quelle manifestate dai profeti.
Nell’Italia del secolo XVII circolavano non pochi testi utopistici. Alcuni di essi traevano ispirazione dal De optimo statu reipublicae deque nova insula utopia di Thomas More, l’opera che inaugura la tradizione dell’utopia moderna. Altri la criticavano apertamente. In apparenza simili, l’utopia e la profezia sono invece modelli di pensiero politico e morale molto diversi. I profeti esortano i loro contemporanei, con parole chiare e semplici, a compiere scelte morali e ad impegnarsi per riformare l’ordine sociale politico. Gli scrittori di testi utopici non esortano esplicitamente a compiere scelte morali, non intendono mobilitare le coscienze. Le repubbliche perfette che essi descrivono non devono essere fondate o riformate. Bisogna soltanto mettersi in viaggio e andare a viverci. Il problema è che non esistono. Quando criticano l’ordine sociale e politico lo fanno nella forma velata e indiretta del dialogo per offrire consolazione o semplice distrazione. I confini tra il linguaggio profetico e il linguaggio utopico sono porosi. Le sovrapposizioni e i passaggi dall’uno all’altro sono tutt’altro che rari. L’esempio più eloquente, in Italia, è quello di Tommaso Campanella (1568-1639), autore della Città del Sole, completata nel 1602 e pubblicata nel 1623. Scritta secondo le regole del genere utopistico, l’opera contiene un esplicito messaggio profetico. La forma è quella classica del dialogo. I protagonisti sono un marinaio di Genova che ha viaggiato con Cristoforo Colombo e un cavaliere di Malta che si limita a chiedere spiegazioni e chiarimenti. La benedetta Città del Sole collocata nel mare della Sonda, vicino a Sumatra, imita la struttura urbana della polis greca. L’ordine politico, gerarchico e autoritario, vuole sradicare l’egoismo dal cuore degli esseri umani e rimuovere tutte le tentazioni che possono indurre al peccato. A tal fine i fondatori della Città del Sole hanno abolito la proprietà privata e la famiglia. Nonostante i contenuti teocratici e autoritari, La Città del Sole esprime, come gli studiosi hanno rilevato, aspirazioni di giustizia sociale simili a quelle manifestate dai profeti.
Gli altri testi utopistici che circolarono in Italia nel secolo XVII raccomandano invece docilità e sottomissione all’ordine sociale. Ludovico Agostini (1536-1609), pio giurista e pessimo scrittore, che trascorse quasi tutta la vita nella sua villa vicino a Pesaro, fra il 1583 e il 1584 scrive i Dialoghi dell’infinito, pieni di lunghe citazioni dalle Scritture e dai filosofi classici, soprattutto Aristotele. […] L’utopia di Agostini è una teocrazia senza alcun messaggio d’emancipazione con l’esplicito intento di incoraggiare l’obbedienza alle autorità religiose e secolari. Ancora più avversi alle visioni di emancipazione sociale e politica sono gli scritti utopistici di Ludovico Zuccolo: Della Repubblica d’Utopia e la Repubblica d’Evandria. Il primo è un attacco diretto all’Utopia di More. Gli esseri umani sono così malvagi, asserisce Zuccolo, che è del tutto impossibile fondare una comunità perfetta come quella immaginata dal celebre More. Tutte le istituzioni della Repubblica d’Utopia sono «quale pravo, quale poco retto, quale su debil base appoggiato». Le leggi che impongono di alternare lavoro intellettuale e lavoro manuale, ad esempio, impediscono ai cittadini di raggiungere quell’eccellenza morale che deve essere fine supremo della repubblica. Il lavoro manuale indebolisce le capacità intellettuali e rende i cittadini inadatti a partecipare al governo della repubblica. Altrettanto sbagliato è il costume degli abitanti di Utopia di tollerare diverse confessioni religiose. L’unità religiosa, egli ammonisce, è fondamento prezioso dell’ordine politico. Ma l’aspetto più negativo delle dottrine di More è costituito dalle sue idee sociali comunistiche. Il comunismo può forse essere valido per comunità di monaci, non per cittadini. Priva di contenuti di emancipazione sociale, l’utopia di Zuccolo era di fatto nient’altro che un passatempo intellettuale del tutto estraneo alla tradizione profetica. Un monito eloquente contro le pretese di riforma sociale viene anche dall’altro scritto utopico di Zuccolo, Il Porto, overo della Republica d’Evandria. Il narratore, Lodovico da Porto, è un uomo che ha dedicato la vita alla causa della libertà italiana. Giunto alla conclusione che l’Italia era condannata alla servitù, decide di viaggiare per tutta la terra. Ormai vecchio, ritorna in patria, felice di condividere la saggezza che ha accumulato nella sua esplorazione dell’isola di Evandria. Dopo un’entusiastica descrizione dell’amenità del sito, spiega che in virtù delle loro leggi eccellenti «gli Euandrij erano i più da bene huomini del Mondo, e che la Città loro era più d’ogni altra felice». Mentre gli italiani sono «pieni di frodi e colmi di vitij», gli evandri non indugiano nella lussuria, vestono sobriamente, non praticano il vergognoso costume dei duelli. Ma al suo elogio delle virtù civili degli evandri Zuccolo non fa seguire un’esortazione agli italiani affinché combattano la corruzione e si liberino dalla servitù. Lo spirito degli italiani è corrotto a tal segno che in essi non alberga più coraggio alcuno. Meglio andare a dormire, conclude mesto il narratore, e con queste parole chiude il suo discorso, senza infondere speranza alcuna:
«E tu meschina, e mal saggia Italia, che già nobile Regina sapesti dar legge al Mondo, onde hai tu appreso costume di sottommeter sì di buona voglia il collo a straniero giogo? Non sei tu quella, la quale fosti già sì seconda madre, e sì chiara nutrice di que’ Fabij, Camilli, Marcelli, Marij, Scipioni, i quali fecero correre i fiumi del sangue di queste belve, e inalzarono monti delle loro ossa? E se quella sei, come hai sì agevolmente mutata natura? Forse altro Cielo ti mira? Altre stelle t’istillano nuovi influssi? Altro Sole t’illumina? O’ pur l’aria, che tu spiri, l’acqua, che tu bevi, i frutti della terra, che tu mangi, sono d’altro temperamento? Se quegli antichi Heroi, i quali col senno, e con l’arme loro ti fecero Donna delle genti, ritornassero in vita, e ti vedessero soggetta a quelli, ch’essi condussero già catenati ne’ loro trionfi, come credi tu, che arrossissero di vergogna? Che avampassero d’ira? Che rimanessero confusi di stupore? Con che occhi t’imagini, che havessero a mirare le tue disunioni? Con quali orecchie a sentire, che i loro trofei fossero stati preda degli altri? Con quale animo a soffrire la viltà tua? Ma, perché la notte è già innanzi assai, sarà meglio darsi al riposo, che spendere il tempo in querele, che nulla giovano, poiché non possono nelle sorde orecchie d’Italia penetrare, né gli animi inviliti riempire d’ardore, e di coraggio.»
Scopri il libro:
